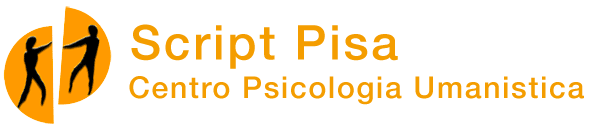Nel periodo 28 Luglio – 10 Agosto 2002, assieme ad amici dell’Associazione per la Pace, sede nazionale di Roma, ho fatto un viaggio di solidarietà politica (nel senso etimologico della parola, di persone che vivono una forma storica di polis) e civile nei Balcani, ho attraversato tutte le attuali repubbliche ex jugoslave, a bordo di un pullman bosniaco, con due accompagnatori bosniaci di origine serba, Rada e Skender (Rada parlava italiano).
Lo scopo era di visitare persone o gruppi della società civile che si erano opposti alle guerre ed ancora si opponevano ai disastri delle guerre.
Assieme ai miei compagni di viaggio ho incontrato sindacalisti, gruppi locali di minoranze etniche, bambini di scuole difese dal filo spinato, donne che hanno nascosto renitenti alla leva per l’arruolamento nella guerra civile fra Jugoslavi, comunità di rom, organizzazioni giovanili, rappresentanti politici atipici (il sottosegretario alla difesa bosniaco, con delega per l’obiezione di coscienza), donne sole (una categoria terribile nei Balcani, indica le donne che, all’interno della propria famiglia, hanno perso tutti gli uomini, mariti, figli, fratelli, scomparsi nella mattanza spaventosa avvenuta a due passi da casa nostra), piccole cooperative mosse più dalla speranza della disperazione che da reali prospettive economiche, carabinieri italiani in missione in Kossovo…
Le righe che seguono sono il racconto parziale di questo viaggio, scritto con lo scopo di dare vita alle immagini tragiche e speranzose insieme, di un’umanità ferita a morte, ancora piena di paura e di disperazione, perché i carnefici sono impuniti e i propri cari, morti nella guerra civile, non hanno ancora sepoltura, dispersi in fosse comuni introvabili.
Nella narrazione affiora qua e là un semplice tentativo di inquadrare nel campo, per ora fragile, della psicologia gli eventi conosciuti.
I passi cronologici della breve ricostruzione di questo viaggio non percorrono puntualmente tutto il cammino intrapreso, ma presentano le tappe che ho ritenuto più significative, ho tralasciato inoltre gli incontri più “politici”, in senso stretto, come quelli con sindacalisti e dirigenti di fabbrica.
“Io vedo la tenebra splendere
Come il roveto sacro
E farsi notte il vostro giorno.
Ho visto case danzare
In deliri di luce e fiamme,
E Roma e altre capitali
Dissolte in tempeste di cenere.
E dentro un silenzio altissimo
Il becchino saliva le scale
Dei sacri palazzi
Coi passi di un mille piedi
In zoccoli di legno e ferro.
E il leone e l’agnello e il lupo
Li ho visti conversare dolcemente
Sulle macerie ammantate di verde.
Perché io sono il disagio del razionale,
Sono l’evocazione e l’annuncio
In diversa lucidità.
Il mio cuore è la conchiglia dei millenni
E il gemito di quanto
È prossimo a venire:
Immolata all’irrisione e allo scherno,
“Sapienza” non creduta.
Sono la salvezza che vi salverà
L’inascoltata e profana
E “inutile” bellezza.
Mi sono amici solo i fanciulli
Ancor per poco liberi
Agli orli delle vostre città:
Avanti di apprendere
A leggere e scrivere”.
David Maria Turoldo
La prima tappa significativa del nostro viaggio è la città di Vukovar, in Croazia.
La città, nel 1992, è stata testimone di una delle più feroci pulizie etniche della storia. Prima della guerra civile la città era composta da circa cinquanta etnie, che vivevano in pace. All’inizio dello smembramento della Jugoslavia l’esercito, prima della divisione per etnie, attaccò la città, dopo che i vertici della Federazione (in maggioranza serbi) diffusero la falsa notizia che i croati avevano iniziato a cacciare via i serbi. La città fu attaccata dall’artiglieria e quello che non fecero le bombe lo finirono i cetnici, bande paramilitari fasciste, riesumate dal regime “socialista” di Milosevic. Fu un massacro casa per casa.
Arrivando nella città a prima vista non ci accorgiamo di nulla di strano. L’aspetto della periferia è quello di una piccola città di provincia, assomiglia ad una città italiana degli anni 30-40, metà contadina e con alcuni aspetti di altre attività economiche (piccole officine, autobus un po’ consumati, bar e osterie di aspetto modesto), ma è sufficiente entrare nel centro e camminare sulla via principale per accorgersi di essere piombati all’improvviso in un paesaggio lunare. Le facciate dei palazzi e delle case sono quasi tutte in piedi, ma sono come limiti esterni di gusci vuoti, all’interno non c’è niente, nessun pavimento, nessun soffitto, come per facciate di cartone alzate scenograficamente, all’interno del set di un film.
Una delle due guide, una donna coraggiosa di 40 anni di nome Rada Zarkovic ci spiega come l’aspetto delle distruzioni testimoni di come sono stati colpiti gli edifici, se la distruzione ha lasciato in piedi le facciate significa che le case sono state colpite da bombe di mortaio che hanno sfondato il tetto e poi sono esplose all’interno, se le facciate sono state sbrecciate vuol dire che i colpi sono stati sparati frontalmente, da distanza ravvicinata nelle battaglie corpo a corpo e casa per casa del 1992.
Più di una volta, nel corso del viaggio, ho cercato di capire le motivazioni di tanta violenza annientante, che è andata molto al di là al di là di una guerra tesa a mettere il nemico in condizioni di non nuocere. L’uccisione di civili, di bambini, di donne indifese, di vecchi (a Vukovar i cetnici hanno ucciso tutti i degenti dell’ospedale) è, sempre e comunque, apparentemente inspiegabile.
Durante tutto il viaggio sono stato alla ricerca, come essere umano e come psicologo, di un pensiero che potesse contenere qualcosa che poteva sembrare incontenibile ed ho lottato contro la tentazione di relegare nella follia della storia tutto quanto avevo cominciato a vedere. Poi mi sono accorto che avrei fatto l’errore speculare degli assassini, anche senza essere come loro, avrei espulso la loro appartenenza all’umanità, come si fa quando si condanna a morte chi si è macchiato di crimini spaventosi. Ho sentito come non mai, anche se con fragili strumenti, la necessità di unire in passaggio dialettico l’inconscio e il reale, di imparare a conoscere le dinamiche psichiche distruttive, senza mai perdere di vista una forte attenzione nei confronti dell’oggetto d’amore uomo, che non poteva non essere salvato, pena la dissociazione paranoica che non mi avrebbe allontanato dal modo di essere dei carnefici. La definizione di follia omicida non conteneva quanto di umano era presente nell’altro e quindi avrebbe potuto essere vivo anche in me. Lo sforzo era enorme, mi veniva in mente la massima di Lucrezio che non considerava estraneo niente che fosse umano. Era umana la forza che spingeva uomini ad uccidere inermi, a massacrarli, ad umiliarli, a togliere loro le possibilità di sopravvivenza, era umana la crudeltà?
Mi sono venute in aiuto, almeno parzialmente, le letture fatte durante gli anni dell’Università, in mezzo a quel caos di idee che è andato sotto il nome mediatico di ’68, ai libri di Franco Fornari sulla psicoanalisi della guerra, all’allora molto conosciuto “Fuga dalla libertà” di Erich Fromm, uno dei primi libri che facevano uscire la psicoanalisi dalla stanza dell’analista, per incontrare le comunità e la società.
Nei luoghi violentati, nelle abitazioni che facevano intravedere scorci inusuali prodotti dagli effetti delle bombe, nei volti dei passanti in cui vedevi un misto di curiosità e di ostilità, quasi l’onta di un peso insopportabile, da nascondere e non da mostrare, ho creduto di vedere gli effetti perversi delle strutture di personalità autoritario-gregarie, di cui ho letto per la prima volta nelle opere di Wihlem Reich. Nelle personalità autoritario-gregario dipendenti la sofferenza è allontanata e negata, la colpa è proiettata all’esterno, e tutto questo è tenuto insieme (paradossalmente contenuto) da una dipendenza indiscutibile e ossessiva (di cui si è ostentatamente bisognosi) nei confronti dell’autorità. I fatti sono elaborati in maniera paranoide, il male è tutto nel nemico e comunque fuori dal gruppo di appartenenza, per cui, reciprocamente, serbi e croati (e, alternativamente, le altre etnie in opposizione) sono stati non soltanto i nemici, ma i depositari del male e quindi, per questo, da distruggere in quanto tali, siano stati essi donne, bambini o vecchi. Il male proiettato tutto all’esterno rende puro chi se libera e lo assolve dalle colpe. Eichmann si difese dicendo “Befehl ist Befehl”, “un ordine è un ordine”.
E mentre sto per lasciare Vukovar mi appare, in mezzo allo scenario di distruzione, con la forza che la natura umana sa esprimere anche nelle tragedie, sulle rive del Danubio, uno spettacolo di anziani pensionati intenti a pescare, ogni tanto abbocca qualche pesce, come se la sequenza degli orrori della guerra lasciasse il posto, in una successione temporale immediata, al tempo del dopo, al tempo della pace. Una pace precaria, scenografica. Migliaia di sfollati da Vukovar non torneranno mai più, alcuni che sono tornati, dopo qualche mese sono ripartiti. I danni che ha fatto l’odio nessun patto di carta li potrà cancellare molto in fretta.
La tappa successiva più importante è Belgrado, che già conoscevo. Belgrado è una città europea, con angoli e scorci “parigini”, con la bellezza della confluenza di due grandi fiumi, la Sava e il Danubio. La sua popolazione è aperta e chiassosa, ma ha la dignità di appartenenza ad una capitale che nell’epoca moderna è stata un vero crocevia della storia.
La gran sorpresa è di vedere che, accanto ai viali di palazzi ottocenteschi, a volte inframmezzati da architetture del Novecento, si trovano pochi, ma significativi edifici distrutti: il palazzo della televisione, l’ambasciata cinese (bombardata con un “errore millimetrico”), la sede della ex Lega dei comunisti jugoslavi. Sono gli effetti dei bombardamenti chirurgici della Nato. Per ora queste rovine appartengono al paesaggio e sembrano far parte di un presepe in disarmo.
L’incontro più commovente di Belgrado avviene nella sede delle “Donne in Nero”, un’organizzazione di donne contro la guerra e la violenza del regime che, a partire già da prima dell’inizio delle ostilità interetniche del 1991, ha dato vita ad un programma di educazione pacifista, unendo la primitiva militanza femminista al pacifismo e alla politica internazionale alternativa dal basso. Le donne che incontriamo all’interno della casa si chiamano tutte per nome, anche nelle manifestazioni ufficiali, sono Stasa, Senka, Liljana, Jovana, Radmila (Rada), la nostra guida, e altre.
L’organizzazione delle Donne in Nero è ora diffusa in tutte le repubbliche jugoslave, si occupa di recuperare la memoria di ciò che è stato distrutto, di riportare alla vita le relazioni interetniche all’interno dei Balcani, cominciando da quelle donne coraggiose che hanno smesso di essere profughe e vogliono ritornare nei luoghi di origine, anche se in mezzo ad estreme difficoltà.
Le donne in nero non si sentono sole, ma sono sole, a pochissime organizzazioni della cooperazione internazionale, fino ad ora, sono interessati progetti di educazione alla pace o alla convivenza.
Esco dalla sede delle Donne in Nero di Ulica Jug Bogdanova con una sensazione che allora non ho so descrivere, ma che mi fa stare bene. In seguito avrei capito che l’operato di quel gruppo di donne, con tutti i limiti che poteva avere, era un esempio di atteggiamento profondamente umano, teso a prendere al proprio interno il peso della crisi epocale dei paesi balcanici, con una presa di coscienza che il male non è etnico, ma è “dentro”, è antropologico, con una consapevolezza che l’alienazione dell’odio (gettare tutto il male sul nemico) è una conseguenza diretta dell’alienazione della morte (e in primo luogo della propria morte). La loro azione mi sarebbe sembrata, in seguito, come uno sbarramento, una luce interiore che dispiegava il suo lume contro il pericolo della propria morte interiore, la cui ombra poteva sempre irrompere, a causa di alienati desideri di morte (proiettati in maniera scissa sull’altro).
Stasa, Senka, Rada e le altre hanno saputo e sanno guardare dentro la morte, si vestono di nero, ci dicono che hanno capito come stare vicino a tutto il dolore che è ancora al lavoro nelle terre jugoslave, non lo allontanano, aiutano le donne a ritrovare i resti dei loro mariti, figli e fratelli: come moderne Antigoni strappano alle indifferenze della natura e alle atrocità degli uomini la memoria dei morti, ricondotta così all’interno del sacro (la tomba, il dolore pianto, il ricordo, il tempo che continua). E il fare memoria e giustizia sono le condizioni perché la vita possa riprendere, il perdono non può esistere, può rendersi certamente attiva una giustizia senza pena, ma che renda palese ciò che è successo, perché l’inganno e la menzogna non continuino a farsi beffe della perdita e del dolore.
La tappa seguente a Belgrado è la Bosnia, un’altra terra martoriata, divisa in tre entità, una serba, una croata e una musulmana. All’ingresso in Bosnia, al posto di frontiera di Zvornik facciamo la conoscenza con le guardie di frontiera della Repubblica Srpska, con una lunga attesa per motivi burocratici: è difficile far capire alla polizia che il pullman è bosniaco, le guida sono serbe, noi siamo italiani (una passeggera ha un passaporto belga). Ma con una serie di timbri e qualche battuta della nostra guida e dell’autista (un bosniaco simpaticissimo che se la sa sbrigare in mezzo alle migliaia di regolamenti che sono comparsi con la divisione negli stati attuali). Passiamo il fiume Drina e siamo a pochi chilometri dal famoso ponte descritto da Ivo Andric nel suo romanzo (“Il ponte sulla Drina”), preso ad emblema del passaggio fra Oriente e Occidente. Incontriamo un camion di carabinieri italiani, molto sorpresi di trovare tanti connazionali in quelle zone.
Ci stiamo addentrando nei luoghi più tetri dell’orrore. E’ strano come in momenti come questi possano venire alla mente ricordi letterari o filmici. Mentre seguo il paesaggio aspro dei monti di Bosnia, mi viene alla mente il Conrad di “Cuore di Tenebra”, il film “Apocalyps Now” di Coppola. Anche noi stiamo risalendo il fiume dell’orrore per arrivare a Srebrenica, il luogo del massacro, della vergogna dell’Occidente, della violenza cieca e vigliacca sui civili.
Nel Luglio del 1995, dopo che i rispettivi nazionalismi andarono al potere sia nella parte serba che nella parte musulmana della Bosnia, la città era protetta dai caschi blu dell’ONU, per l’occasione olandesi. Per l’imperversare della guerra, la comunità civile di Srebrenica aveva deciso di ritirarsi all’interno della Bosnia, in zone meno esposte ai combattimenti. Le forze internazionali, schierate a protezione della popolazione, convinsero gli abitanti a rimanere, con l’assicurazione che sarebbero stati protetti, in caso di pericolo.
I paramilitari serbi si presentarono in forze e armati di fronte ai soldati olandesi sotto bandiera ONU. Difendere la popolazione significava, da parte delle truppe ONU, scontrarsi con loro. Il generale olandese, dopo aver ricevuto l’assicurazione dal comandante dei paramilitari serbi che non sarebbe stato torto un capello ai civili (anzi, credette o finse di credere che gli stessi soldati serbi avrebbero trasportato su camion la popolazione in zone meno esposte alla guerra), abbandonò il campo.
Seguì un massacro. Tutti gli abitanti musulmani maschi di Srebrenica furono trasportati in capannoni industriali alla periferia della cittadina, in località Potocari e furono uccisi tutti, alcuni sgozzati con colli di bottiglia. Le donne e i bambini di Srebrenica furono costretti ad assistere alla mattanza. Furono uccise 5.000 persone, i cui resti sono scomparsi in fosse comuni sparse per la Yugoslavia.
A visitare Srebrenica ci accompagnano tre donne: Stana (serba), Zejneba e Amela (musulmane). Zejneba ha perso il marito nel massacro del Luglio del 1995, Amela il fratello, Stana è una donna coraggiosa che coordina le associazioni di donne della zona (interetniche) che operano per far ritornare i profughi e costituire le condizioni economiche di sopravvivenza.
Ci fermiamo di fronte ai capannoni industriali, ora chiusi e dismessi, dove fu attuato il massacro.
Il cielo è coperto, piove e fa freddo. Scendiamo dall’autobus, di fronte alla spianata delle fabbriche c’è un prato con un albero solitario, sotto il quale si trova un monumento funebre musulmano, una lastra tombale di marmo bianco con accanto, sempre in marmo, un colonna a pinnacolo, alta poco più di un metro e molto sottile, il monumento caratteristico delle tombe musulmane, la colonna rappresenta una stilizzazione del minareto.
La lastra tombale porta la scritta “Srebrenica Luglio 1995”. Zejneba ci dice che quella piccola struttura è il primo passo per la costituzione di un monumento funebre alle vittime della ferocia della guerra civile. Stana, Zejneba e Amela ci raccontarono episodi terribili della guerra, con una voce di tono normale, Rada traduce per noi, qualcuno si commuove.
Ci raccontano che ogni tanto vengono scoperte fosse comuni e che le ruspe deturpano ulteriormente i cadaveri, nello scavo, aggiungendo dolore a dolore, ci dicono che, più della morte dei loro cari, è terribile non sapere dove si trovano i loro corpi, è devastante non poterli piangere in un luogo.
Stana ci rivolge una preghiera. Lì vicino c’è un cimitero cristiano-ortodosso, serbo, se fossimo andati a visitarlo (anche lì c’erano le vittime della guerra civile) lei avrebbe potuto far tesoro di questa iniziativa, per provare ai suoi connazionali che i visitatori internazionali non sono soltanto vicini alle vittime musulmane, ma anche agli altri, dell’altra parte.
Accettiamo tutti e la nostra giornata termina in mezzo a tombe di colore nero (quelle musulmane sono bianche) che portano le fotografie di ragazzi in divisa mimetica e con atteggiamento marziale.
Alla fine della giornata in tutti noi si rafforza l’idea di impegnarci, come sarebbe stato possibile, per non accettare l’ineluttabilità di quanto avevamo conosciuto.
Passati momenti come questi, mi sono sempre interrogato, in silenzio, sul possibile significato di tutto ciò e sullo sforzo per contenere all’interno della ragione fatti che ne esulavano continuamente.
Mi sono interrogato sul pericolo che, nella dannazione a vivere “fuori” dal senso di questi avvenimenti, potesse esistere la attuale forma collettiva di “elaborazione paranoica del lutto” di freudiana memoria, e che soltanto uno sforzo continuo di conoscenza dell’aspetto della natura umana che aveva provocato tutto ciò avrebbe potuto essere il primo antidoto contro il suo ripetersi. Ho incominciato a dire con convinzione a me stesso che, per questo scopo, occorreva non soltanto l’intenzione degli uomini e delle donne di buona volontà, ma anche molta intelligenza per mettere in atto tutte le possibilità preventive in un mondo che, fino ad ora, non aveva confinato i massacri nel ricordo della storia, ma li aveva resi attuali a pochi chilometri dalle nostre esistenze.
Dopo la Bosnia ci accoglie il Kossovo, una terra sospesa in un limbo politico pericolosissimo: la popolazione di questa zona era ed è, in maggioranza, albanese. I serbi, dominatori prima della guerra della NATO, sono diventati ora minoranza senza più potere e vivono in isole all’interno del mare albanese.
Nella città di Mitrovica (nel Nord del Kossovo), a maggioranza albanese, esiste una zona serba, all’interno della quale ci sono piccole realtà albanesi (la città in realtà è divisa in due: il Nord dove vivono i serbi e il Sud dove vivono gli albanesi, a Nord continuano a vivere ancora famiglie albanesi e di altre minoranze come bosniaci, turchi, ecc., prevalentemente in due quartieri, Bosnjacka Mahala e Kodra Minatore.
In tutto il Kossovo, e particolarmente nelle città, sono presente i funzionari dell’ONU, che hanno compiti di amministrazione civile e i militari dei paesi della NATO, che hanno compiti di mantenimento dell’ordine e di protezione del territorio delle varie etnie.
A Mitrovica la zona serba e quella albanese sono “protette” da soldati francesi, tedeschi, danesi. I carabinieri italiani pattugliano la città come polizia militare.
Il nostro viaggio ci porta a visitare una piccolissima scuola elementare, nel quartiere di Kodra Minatore, una delle due enclave albanesi all’interno della zona serba.
La via di accesso alla scuola è presidiata da una postazione militare di francesi, armati di mitra, mitragliatrici e con a disposizione un carro armato. La scuola è protetta da una rete di filo spinato.
La scolaresca (bambine e bambini molto piccoli, di classi diverse, raccolti per l’occasione, perché, naturalmente, durante l’estate sono in vacanza) ci accoglie festosa. Le maestre ci danno il benvenuto. Franciska, che lavora nello staff locale della Caritas di Pisa e Roma e da tempo collabora volontariamente alle attività dell’Associazione per la Pace (una ragazza kosovara-albanese che conosce molto bene l’Italia e l’italiano), per l’occasione è la nostra interprete, ci traduce i messaggi di benvenuto. Sembra (ma è realtà) di essere in una scuola di fortuna sorta sulle macerie di una guerra. Mi ricordo delle scuole di campagna che, nell’immediato dopoguerra, popolavano la pianura padana.
Mi chiedo, mentre osservavo incuriosito questa semplice cerimonia del saluto, che cosa sarebbe successo se fossero spariti all’improvviso i soldati internazionali, se fossero venute meno le garanzie protettive, venute dall’esterno e con la violenza della guerra, ma pur sempre garanzie.
Un’immagine mi è rimasta particolarmente in mente della guerra che ha insanguinato la Jugoslavia negli anni ’90 del secolo scorso: una fotografia vista su una rivista di politica, nel 1994 o 1995, che mostrava due soldati, probabilmente serbi, ma il loro esercito di appartenenza non ha molta importanza, un uomo e una donna, che tenevano per mano, entrambi, una bambola, una preda di guerra che avevano prelevato in un appartamento distrutto e che avrebbero portato a casa per la loro bambina (la fotografia era corredata da un articolo che raccontava la storia in questo modo).
Cioè una bambina avrebbe giocato con la bambola di un’altra bambina, costretta a fuggire o uccisa (quali saranno le ferite dell’infanzia che ha vissuto questa guerra e che è cresciuta immediatamente dopo?).
La visione di questi bambini sorridenti mi suscita mille pensieri.
Ritorno con la mente alla possibilità di spiegazione di tutto l’orrore che ha dilaniato le vite e le coscienze, al “disagio del razionale” evocato da David Maria Turoldo nella poesia che ho voluto mettere ad apertura di queste note di viaggio, ma non riesco a concepire nessun discorso. La condizione è quella dantesca “…il cor si dispaura…”.
Mentre osservo le facce contadine delle maestre kossovare mi viene in mente la poesia di Quasimodo dedicata ai fratelli Cervi, il verso “…quest’umanesimo di razza contadina…”, e penso alle trappole della ragione quando non riesce a spiegare secondo i dettami della logica i fatti, i comportamenti, le offese, la morte, quanto di orrendo è avvenuto in questi luoghi.
Mentre ripercorro al contrario la strada piena di posti di blocco che mi fa ritornare nella parte serba e poi nella zona albanese, penso che una delle nefandezze intellettuali del nostro tempo sia quella di proclamare come inspiegabile, oscuro e misterioso l’atto del massacro collettivo, della guerra di sterminio della popolazione civile, della pulizia etnica. Penso ancora una volta di al pericolo che questa “inspiegabilità” diventi il contraltare della elaborazione paranoica del lutto: non è possibile trovare spiegazione perché la ragione di quanto accade è “fuori” di noi.
Penso anche che l’umanesimo di tempi nuovi e futuri possa consistere nel profondere tutte le risorse intellettuali per contenere, per spiegare, illustrare, conoscere i reconditi meandri della violenza collettiva, al fine di costituire risorse di sapere che permeino l’educazione delle donne e degli uomini, con menti libere e decise, simili alla ginestra leopardiana e che rifuggano per sempre dall’invocare un dio a protezione e giustificazione di eventi nefandi.
Rimane tuttora dentro di me il grande problema di come tradurre in prassi un insieme di sentimenti e di ragioni intellettualizzate che, da sole, possono rimanere un mero fatto consolatorio e astratto, di fronte alla pesante concretezza dei massacri.
Note in libertà:
il viaggio è stato molto più articolato rispetto al racconto. Sono state toccate anche le città di Novi Sad, di Sarajevo, di Mostar, di Tetovo, Skopje, le repubbliche di Macedonia, il Montenegro. Ultima tappa l’Albania, dalla quale la comitiva è tornata in Italia solcando quel mare che è diventato la tomba o la speranza degli immigrati d’oltre Adriatico.
A Mostar ho preso contatto con psicologi ed educatori di una scuola per portatori di handicap di diverse età. La reciproca promessa è stata di risentirci e di rivederci. Nel villaggio di Bratunac, in Bosnia, alcuni genitori di bambini disabili si sono riuniti in associazione per cercare di capire come aiutare meglio i loro figli. Aspettano aiuto. Mi sono ripromesso di riprendere i contatti.
Molte delle osservazioni di natura psicologica le devo all’interessante lettura del numero 13/2002 della “Rivista di psicologia analitica” nuova serie, dal titolo “Il terrore nell’anima”. Aggiungo una breve bibliografia per approfondire la conoscenza del problema della violenza collettiva dal punto di vista della psicoanalisi o della psicologia:
SIGMUND FREUD Psicologia delle masse e analisi dell’Io. Bollati Boringhieri, 1971.
SIGMUND FREUD Il disagio della civiltà. Boringhieri 1971.
WILHLEM REICH Analisi del carattere. Sugar Edizioni 1973.
WILHELM REICH Psicologia di massa del fascismo. Sugar Edizioni 1974.
ERICH FROMM Anatomia della distruttività umana. Monadarori 1973.
ERICH FROMM Fuga dalla libertà. Edizioni di Comunità. 1970.
FRANCO FORNARI Psicoanalisi della guerra. Feltrinelli 1964.
FRANCO FORNARI La malattia dell’Europa. Feltrinelli 1981.
LUIGI DE MARCHI Lo shock primario Eri 2002.
A. MARIA SASSONE (a cura di) Psiche e guerra Manifesto libri 2002.
Per chi desiderasse avere altre informazioni sugli eventi politici e civili può consultare i seguenti siti web:
– www.balcanicaucaso.org è una fonte molto aggiornata sui principali avvenimenti che riguardano la trasformazione della società civile e la evoluzione dei vari Stati balcanici, dopo la fine delle guerre;
– http://www.assopace.org è il sito nazionale dell’Associazione che ha organizzato il viaggio, vi si trova, fra l’altro, una ampia descrizione della situazione di Mitrovica e dei suoi sviluppi.
Giovanni Lancellotti – Psicologo-psicoterapeuta