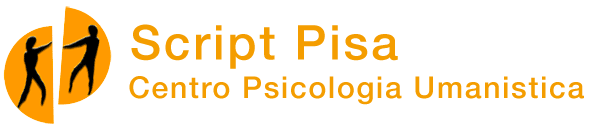Un accompagnamento riflessivo ai dialoghi d’amore recitati nella sede dell’associazione SCRIPT, il 22 maggio 2010
Duro compito, quello di prendere il bisturi in mano, dopo una tale emozionante carrellata d’infinite voci, accorate suppliche e strazianti dichiarazioni d’amore, che s’inseguono nei secoli quasi a comporre un unico ed eterno canto di gioia, quando non sia un lamento per la gioia perduta.
In maniera un po’ esorcizzante, ho intitolato la mia relazione con il titolo di un famoso film di Troisi, Sembrava che fosse amore, invece era un calesse. A volte, l’amore non è amore, ma è un malinteso: Troisi ci ha presentato un equivoco molto grosso, infatti si trattava di un calesse, ma non era poi un caso troppo strano, perché è evidente che ci sbagliamo spesso nella vita, fa parte della natura umana, fa parte del gioco della vita, che è quello di non essere già esperti in partenza, anzi di non essere mai abbastanza esperti in ogni caso.
Anche a prescindere dall’eventualità di errori così grossolani, si può lavorare moltissimo nell’intento di demistificare l’amore. Per esempio, la psicoanalisi nei suoi primi decenni di vita, cioè la psicoanalisi freudiana (che ancora si trova molto rappresentata in ambito letterario e umanistico in generale), era proprio caratterizzata da una particolare tendenza al sospetto e dalla convinzione che dietro alle espressioni più tipiche e più nobili dell’animo umano ci fossero sempre delle motivazioni molto meno nobili, molto prosaiche, animalesche ed elementari.
Freud, nel suo totale disincanto, pensava che l’amore fosse sessualità sublimata, cioè spostata dalla sua meta naturale verso una meta socializzata, conforme alla creazione di legami e di scambi utili per la società. Questo dirottamento della libido dalla meta naturale poteva seguire, secondo lui, due diversi percorsi: uno di tipo “anaclitico”, cioè di appoggio su un bisogno primario, e uno di tipo narcisistico. Nel primo caso, amiamo chi ci dà la pappa, chi ci accudisce e si prende cura di noi, nel secondo amiamo nell’altro lo specchio di noi stessi, o meglio l’esaltazione di noi stessi: la persona meravigliosa che eravamo, quella che siamo o quella che saremo.
Da queste iniziali concezioni psicoanalitiche sull’amore è passato molto tempo e la psicoanalisi si è assai complessificata, per cui oggi essa utilizza altri paradigmi di pensiero, che vanno molto oltre il meccanicismo e il riduttivismo di Freud.
In primo luogo, sono stati fatti molti progressi nello studio del narcisismo, un argomento decisivo che si è completamente trasfigurato nelle mani degli studiosi e si è allargato a comprendere lo sviluppo emotivo della soggettività dell’essere umano, la capacità emotiva di vivere in prima persona e di essere un soggetto. Kohut, lo studioso che maggiormente ha contribuito a questo sviluppo, alla fine del suo percorso decise di abbandonare il termine stesso di “narcisismo”, in quanto obsoleto, e di sostituirlo semplicemente con la nozione del sé ferito. Motivo per cui, si capisce facilmente, è caduta ogni preclusione morale a riguardo
Secondo Freud il narcisismo rappresentava una fase iniziale dello sviluppo emotivo, che, in seguito, con la maturazione della personalità, si sarebbe dovuto trasformare in amore per gli altri. Si trattava di un giudizio negativo che aveva una lunga tradizione alle spalle. Nasceva da un equivoco tradizionale della nostra cultura, una grossolanità che viene dal passato e che, al di fuori della psicoanalisi, perdura ancora oggi nel senso comune. Mi riferisco alla concezione per cui l’amore per se stessi è il contrario dell’amore per gli altri. Da questo punto di vista, l’amore sarebbe una cosa che io posso dare a qualcun altro oppure tenerla per me stesso ed essere egoista. Mia nonna, l’unica persona religiosa della famiglia, mi diceva, pur non essendo io una ragazza, di non guardarmi troppo a lungo nello specchio, perché c’era il rischio di vedere comparire il diavolo. Gliel’avevano confidato, a suo tempo, le suore. D’altra parte, la mia maestra di scuola elementare ci diceva che nei componimenti il pronome “io” andava usato con molta parsimonia. Questo si sarebbe dovuto capire, secondo lei, anche dal fatto che “io, io, io” è il verso dell’asino!
Di fatto, la cosa più straordinaria emersa dagli studi sul narcisismo è che esso riguarda la genesi della soggettività, la costruzione di se stessi come soggetto-individuo, costruzione difficile, spesso fallimentare, ahimè. Siamo nell’età del narcisismo, perché siamo nell’età dell’in-dividuo. Questo può anche risultare scomodo, ma è l’esito e il portato di secoli di evoluzione psicologica e sociale dell’essere umano. Sono caduti i valori tradizionali e ognuno di noi deve trovare i propri significati, per poi convalidarli e realizzarli nello scambio con gli altri: è chiaro che tutto questo rende la vita più complicata che in passato, ma io credo anche molto più interessante. Oggi la vita è difficile, perché non ci sono facili binari precostituiti nei quali possiamo pacatamente lasciarla scorrere, seguendo l’esempio delle generazioni passate. Per emanciparsi dal livello psicologico zero, oggi un essere umano deve affrontare un mondo combattivo, mettersi alla prova, avere fortuna, scoprire il valore prezioso della propria individualità e riuscire a farne qualcosa nello scambio con gli altri. Per cimentarsi in quest’impresa è indispensabile una dote iniziale di autostima, di fiducia in se stessi e di competenza relazionale che poche famiglie sono in grado di fornire.
Si può dire che nelle manifestazioni dolorose del narcisismo (dolorose per se stessi e per gli altri) non è in gioco lo scontro fra interessi di soggetti separati, cioè di individui già costituiti, ognuno con i propri interessi o con i propri significati da negoziare e da difendere, in grado di affrontarsi, discutere, competere, ecc. Il narcisista è, nei casi gravi, un soggetto mancato, e in quelli meno gravi un soggetto mancante, non finito di costruire. Motivo per cui, si verifica la drammatica incapacità da parte sua di accettare e di valorizzare se stesso. Potremmo anche dire, diversamente da come sembra, che il narcisismo, o meglio il sé ferito, comporta una drammatica incapacità di amare se stessi, motivo per cui chi ne soffre ha due possibilità davanti a sé. Idealizzare stesso o idealizzare gli altri. Nel primo caso si sceglie un aspetto di sé, per esempio l’aspetto fisico o l’intelligenza, o il coraggio o altro ancora e ci si identifica con quello, esaltandolo, in modo da nascondere tutto il resto. Si tratta, è ovvio, di una soluzione fragile oltre che di una falsificazione e, soprattutto, essa comporta il bisogno maniacale di conferme che la sostengano. La strega della fiaba di Biancaneve è un esempio meraviglioso di questo genere di narcisismo, nel suo rito quotidiano con lo specchio, quando lo interroga e gli chiede: “Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?” Guai se lo specchio dice che non è lei e guai a chi si trova quotidianamente nella posizione di specchio a dovere sostenere questo genere di personalità. Si dice infatti che l’esperienza che si fa nel rapporto con un narcisista è quella di sentirsi tiranneggiati.
Nel secondo caso, quando sono gli altri a essere idealizzati, il narcisista si aspetta di poter trovare in qualcun altro la parte mancante di se stesso e anche in questo caso sono guai. È facile, in questo caso, pensare alla follia d’amore, all’idealizzazione straordinaria della persona amata e alle pretese assurde che ne derivano. Infatti, il narcisista cerca facilmente una medicina nell’amore e ovviamente non la trova, perché se è vero che l’amore non è un calesse, bisogna dire che non è nemmeno una medicina; allora si rimane delusi, si vive l’esperienza che la persona amata è molto diversa da come sembrava, che anzi è cattiva, non dà quello di cui si avrebbe bisogno, ecc. Bisogna sottolineare però che la persona ferita nel proprio sé non è una persona bizzosa per natura, ma è una persona disperata che si aggrappa in cerca di ciò che sente drammaticamente mancare a se stessa (fiducia, autostima, competenza relazionale), motivo per cui non è in grado di capire gli altri come persone separate che hanno dei bisogni, dei limiti o dei desideri per proprio conto. Gli altri significativi vengono percepiti come parti mancanti di cui il narcisista ha urgentemente bisogno per mantenere la sensazione di esistere e di essere intero: braccia, gambe, piedi che si devono muovere al suo comando.
A proposito della patologia più grave, mi viene in mente Misery non deve morire, un bellissimo film dove la protagonista, identificata con un personaggio letterario, Misery appunto, rapisce l’autore della fiction, lo lega al letto, gli rompe le gambe e lo obbliga a cambiare il finale del suo ultimo romanzo dove Misery moriva, perché attraverso quell’identificazione voleva continuare lei stessa a vivere. Ma, al di là dei casi più estremi, tutti siamo più o meno feriti nel nostro sé e mancanti d’essere, perché, come ho detto, siamo nell’età dell’individuo, e per dare un senso alla nostra vita dobbiamo impegnarci davvero tanto, dobbiamo individuare e perseguire delle mete e dei valori personali, fino a diventare interi come individui.
In conclusione, potremmo dire che il mito platonico dell’amore come ritrovamento della metà mancante è un attrattore formidabile per le problematiche di sofferenza grave di cui stiamo parlando. Quindi, è ovvio, dal punto di vista della psicoanalisi ne consegue che per fare un’esperienza felice dell’amore, c’è un’unica regola fondamentale: prima di avventurarci nell’amare qualcun altro dobbiamo essere capaci di amare noi stessi. L’esatto contrario di ciò che dicevano le suore a mia nonna. Amatevi, vi prego, amate prima di tutto voi stessi e non usate l’amore per fare e per farvi del male. Non andate a cercare nessuna medicina nell’amo-re; quello che vi manca, cercatelo dentro a voi stessi.
Questo, io credo, è il distillato di ciò che la psicoanalisi ha da insegnare agli amanti.
Ora però vorrei proporre una visione d’insieme un po’ più originale e personale dell’essere umano e dell’amore.
All’origine dell’essere umano, come all’origine di tutti gli animali superiori, c’è un’espe-rienza immediata delle cose che ci fa essere ciò che siamo in sintonia con l’ambiente intorno a noi, cioè con il mondo, e determina la nostra appartenenza al mondo: un ricco tessuto di coscienza pre-riflessiva che si organizza attorno alle percezioni.
Come nella storia dell’universo, così anche nella storia dell’individuo, più si retrocede e più è densa la successione degli eventi. Nel corso dell’interminabile primo secondo di vita dell’universo dopo il big bang sono successe le cose più importanti che hanno determinato le caratteristiche dell’universo per tutti i miliardi di anni a venire. Il nostro universo è quello che è a causa di ciò che è successo durante il primo secondo della sua vita, un tempo che per i fisici è lunghissimo. Credo che, per quanto riguarda l’essere umano, l’intervallo tra zero a due anni sia molto più “lungo” e significativo di quanto ancora oggi siamo disposti a credere. Qui però, all’età di due, accade quell’evento drammatico di cui parlano tutti i miti: la cacciata dal paradiso, la perdita della pienezza dell’essere. Accade drammaticamente e irrevocabilmente la ristrutturazione della coscienza attorno alla parola (il linguaggio, con tutte le sue ramificazioni, è l’albero della conoscenza) e, in particolare, attorno a quel dialogo interno che chiamiamo coscienza riflessiva. La parola toglie il primato alla percezione e con essa s’instaura un mondo finto, al quale occorre credere, perché non può più essere direttamente sperimentato. Alle esperienze dirette dei sensi si sostituiscono le parole, gli insegnamenti dei genitori, della scuola ecc.
Gli animali vivono nell’essere, non sono mai usciti dal paradiso e sono pienamente se stessi, sono esseri divini e immortali, in quanto guidati dalla “danza relazionale” dell’essere, di cui parla Bateson, come l’ape dai fiori e dal sole o la preda dal predatore e il predatore dalla sua preda, tutt’uno con il proprio genere e quindi immortali, perché il genere non muore, mentre il bambino che tanto ci commuove per la sua fiducia ingenua e totale è in realtà un animale totalmente smarrito, un individuo, cioè un essere sbalzato fuori dall’identificazione con il genere. Su questa perdita dell’origine animalesca e divina, cioè su questa perdita dell’essere, s’innesta la cultura, il gioco di identificazioni e di ruoli, l’addestramento alla civiltà.
Con l’adolescenza questo traballante sistema va in crisi e si dà la possibilità di una negoziazione: andare con quanto si è appreso alla ricerca di quanto si è precedentemente perduto. Utilizzare le competenze culturali acquisite per ritrovare un po’ più di quelle esperienze originarie per sentirsi personalmente vivi e partecipi della danza relazionale che ci lega a tutto il resto dell’essere. La nevrosi e in particolare il vuoto di sé, il senso di mancanza cui ho precedentemente accennato, dipendono dal fallimento o dalla totale impossibilità di questa negoziazione. In questi casi, la cicatrice callosa dell’innesto, la barriera che separa l’essere culturale da quello naturale resta troppo poco permeabile e risultiamo divisi in due metà che non comunicano fra loro.
Goethe diceva che l’essere umano ha energia sufficiente per tre adolescenze. Era un teorico del rinnovamento attraverso una nuova adolescenza. In fondo, aveva ragione: non penso che esista altra possibilità di terapia che questa. Quando una psicoanalisi funziona, non è per le spiegazioni che lo psicoanalista dà al paziente e di cui questi si avvale per capirsi meglio e cambiarsi. Questa sarebbe l’idea canonica del trattamento eppure, vi assicuro, è pura fantascienza, è superstizione. Non esiste una tecnica per intervenire su se stessi: il “mondo interno” è una metafora, non è come l’interno del corpo umano e non esistono pinze e bisturi per intervenire sulle metafore. Quando una terapia funziona, essa funziona secondo un principio maieutico, come aveva già capito Socrate, che diceva di essere una levatrice. L’unico cambiamento possibile è lo sblocco di una crisi. L’unico parto possibile è quello di ciò di cui si è gravidi. Quando una terapia funziona è una nuova adolescenza che si compie fruttuosamente: infatti si è sentito il bisogno di inventare il concetto di processo psicoanalitico e di ridimensionare sempre più il significato magico (anzi, romantico) che all’inizio si attribuiva all’in-terpretazione o spiegazione psicoanalitica.
Anche l’interpretazione è utile nella misura in cui contribuisce al processo psicoanalitico, cioè al coinvolgimento e al cambiamento, perché, in definitiva, se la terapia psicoanalitica funziona altro non è che una forma molto particolare dell’amore. Se ne accorsero subito gli inventori di questo metodo psicoterapeutico. Breuer fuggì allarmato quando la prima paziente della storia della psicoanalisi s’innamorò di lui e Freud esorcizzò l’amore chiamandolo “transfert” che voleva dire follia momentaneamente spostata sulla persona dell’analista, in attesa di soluzione.
In realtà, solo l’amore può portare davvero a un nuovo inizio. Prima ho citato Socrate e devo aggiungere che, ai suoi tempi, anche la filosofia era una forma d’amore e la parola “filo-sofia”, secondo la sua etimologia voleva davvero dire “amore della sapienza”. Ma la filosofia con Eraclito, ancora prima di Socrate, era stata addirittura “filo-ousia”, cioè amore dell’essere.
Chiudo la mia relazione con una notizia buona e una cattiva. La buona notizia è che, al di là di tutte le falsificazioni possibili, l’amore contiene davvero questo straordinario significato, il nuovo inizio. In questo caso, non siamo più alla ricerca della parte mancante come qualcosa che dovrebbe arrivare già pronta dall’essere di qualcun altro, ma viviamo una messa in crisi e una speranzosa trasformazione dei nostri significati e dei nostri modi di essere, all’interno della relazione con un altro essere che vive la stessa esperienza e la stessa avventura. Allora il rapporto d’amore, la simbiosi che isola gli amanti dal resto del mondo, diventa il contenitore di questo eccezionale processo. Si fonde e si ricrea la comunicazione fra l’essere culturale e quello naturale, si rimaneggia il callo nel punto d’innesto. Nuova linfa comincia a irrorare tutte le foglie e si riversa in una nuova primavera. Già Jung aveva descritto il processo della trasformazione psicologica in questi termini, come conjunctio oppositorum, prendendo a prestito l’immaginario dell’opus alchemicum. Il maschile e il femminile si sciolgono nel crogiuolo della trasformazione alchemica, impersonati da frater e soror, sole e luna, re e regina o comunque i due amanti. L’amore fisico funge da veicolo a quello spirituale e anche i due termini opposti di corpo e di spirito nei quali l’essere umano è dolorosamente diviso si sciolgono dentro all’anima di ciascun partner e si ricongiungono in maniera più felice.
La cattiva notizia, invece è sempre la stessa: per vivere il nuovo inizio e non il fallimento disastroso delle spirali delle reciproche accuse che distruggono sanguinosamente la coppia amorosa bisogna essere già abbastanza sani, abbastanza congiunti a se stessi nella propria interiorità. Abbastanza capaci di amare se stessi. Vale il proverbio spaventoso (parabola dei talenti) per cui piove sempre sul bagnato. “Chi già ha, altro ottiene e chi non ha perde anche quel poco che aveva”.
Alberto Lorenzini
alberto.lorenzini@gmail.com