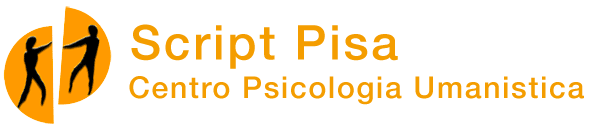Faceva caldo, era buio e io viaggiavo compressa nel’ultima fila dei sedili di un furgone Volkvagen bianco con indosso una maglia di lana e sulle ginocchia un piumino blu.
Era il primo gennaio 2000 ed ero appena arrivata a Rio Branco, Stato di Acre, Brasile.
Il furgone correva sobbalzando, frenando e deviando, nel buio quasi assoluto, solo qualche lampadina sulle porte delle poche case di legno ai margini della strada di terra rossa. Le sagome più scure degli alberi altissimi si scorgevano appena, ai lati.
Quella strada in seguito l’avrei percorsa molte volte, guidando io il furgone bianco, per andare a prendere o a riaccompagnare all’aeroporto amici che partivano o il personale italiano della organizzazione non governativa per la quale stavo lavorando, che periodicamente faceva visite di monitoraggio al Progetto al quale partecipavo come consulente, il Beija – Flor (colibrì, in italiano). Consulente, in particolare, per il coordinamento e il lavoro di comunità. In realtà facevo, per fortuna, tutto quello che capitava…molto spesso l’autista e scarrozzavo i ragazzi per la città per permettere loro di partecipare alle poche attività che erano organizzate per loro.
I ragazzi appartenevano tutti a famiglie con un reddito inferiore alle trecentocinquanta mila lire al mese, erano stati quasi tutti contattati nelle strade e nelle piazze dove svolgevano, spesso per l’intera giornata, “piccoli lavoretti”, come il posteggiatore abusivo, caricatore – scaricatore al mercato, raccoglitore di alluminio, venditore nelle bancarelle, lustrascarpe.
Tutti abitavano in quartieri estremamente periferici come quello dove era, ed è tutt’ora, la sede del Progetto Beija – flor “Cidade Nova”.
La mia prima impressione, che ha dato il via a un radicale “rimescolamento” interiore, che è durato nel tempo e, per certi aspetti, si è pure approfondito, è nata dalle prime visite realizzate nei quartieri e nelle case dei ragazzi.
Era il periodo delle piogge, che ai tropici dura quattro o cinque mesi, e le strade di argilla rossa erano spesso impraticabili: una sola striscia di fango rimestato e impastato con rifiuti vari organici e non; io provavo un profondo senso di schifo (questa è la parola) a camminarci sopra, tentando di non affondare, con le mie scarpe nuove di tela bianca. Accanto a me, invece, camminavano alcuni bambini che, a piedi scalzi, affondavano rapidi e sicuri nel fango.
Ho imparato, dopo pochi mesi, a usare le comode e diffusissime (tra i poveri) ciabattine infradito di plastica dura, con le quali non solo non affondavo nel fango ma riuscivo anche a non sporcarmi i piedi.
Questo episodio è emblematico del cambiamento che credo di aver compiuto, subìto anche, vivendo per due anni nello stato dell’Acre, uno degli stati più piccoli e poveri del Brasile, in mezzo alla foresta amazzonica.
Una unica strada collega Rio Branco, la capitale, alla capitale dello Stato più vicino, e da lì al resto del Brasile. I collegamenti tra la capitale e le cittadine dell’interno sono, soprattutto nel periodo delle piogge, aerei o fluviali.
L’Acre ha una estensione territoriale pari a circa il 60% di quella italiana con una popolazione di circa 540.000 persone, circa l’88% di questo territorio è coperto dalla foresta.
L’attività economica principale fino agli anni del secondo dopoguerra è stata l’estrazione del lattice, elemento base della produzione della gomma. La “seringa”, l’albero del lattice, è un albero nativo che produce il liquido bianco con cui si estrae la gomma. A causa della concorrenza inglese che, attraverso quello che possiamo definire come il primo caso di spionaggio biologico, rubò la piantina di “seringa” e la piantò a Macao, e di quella della gomma artificiale, l’economica della zona ha avuto un tracollo fortissimo così come, di conseguenza, le condizioni di vita della maggioranza della popolazione della regione.
Attualmente, infatti, questo Stato ha gravissimi problemi economici e sociali e risulta essere uno dei più poveri del Brasile.
Gli indicatori sociali in quella regione per esempio, toccano percentuali sbalorditive: grado di analfabetismo disoccupazione, tipologia delle abitazioni, diffusione dei mezzi di trasporto…
In un luogo così si “arriva” in un modo e si “riparte” in un altro, dopo essersi sottoposti, nel frattempo, ad un processo di adattamento a situazioni di cui spesso si ignorava persino l’esistenza o, comunque, la portata emotiva. Processo che per un verso sembra estremamente spontaneo, di cui poco ci si accorge, nel periodo in cui lo si vive, e che per altro verso è, in realtà, molto profondo e dagli esiti imprevedibili.
Mi sono spesso chiesta se comunicare la mia esperienza personale potesse essere interessante soprattutto in una società che produce molte informazioni sulle problematiche terzomondiste, con i mezzi di comunicazione che continuamente ci informano delle varie emergenze e dei diversi organismi che se ne occupano; informazioni aumentate negli ultimi anni, a mio parere con un pullulare di numeri verdi pubblicizzati alla televisione cui rivolgersi per inviare sostegno, soprattutto in denaro.
Mi sono chiesta e, credo sia necessario farlo pubblicamente e girare al lettore questa domanda, che cosa possa significare questo pullulare di informazioni, immagini, richieste di denaro, quale impatto possa avere veramente sulle persone, che fine raggiunge, a quale obiettivo mira.
Non vedo un reale aumento della consapevolezza nelle persone del ruolo che l’ Europa, l’Italia, ha effettivamente avuto nella creazione delle profonde ingiustizie che separano i paesi nel mondo. Semmai si percepisce un interesse filantropico ma distaccato, con un atteggiamento simile a quelli che, alla domanda “cosa faresti se vincessi un miliardo di lire (milioni, in euro)”, rispondono sempre che una parte la darebbero in beneficienza, il 10% circa diceva un sondaggio effettuato. Insomma bisogna ingraziarsi, la fortuna, la sorte, non si può certo fare invidia agli dei.
Poche persone hanno la reale consapevolezza che i governi del mondo ricco hanno delle precise responsabilità e che se, il 10% della popolazione mondiale consuma l’80% delle risorse disponibili, non si può certo affermare che sia un caso. E pochissimi pensano che noi, cittadini degli stati ricchi, che abbiamo vinto alla lotteria della sorte, come dice Frei Betto, possiamo realmente fare qualcosa per cambiare questo stato di cose.
I miei due anni, duri certamente, sono stati un laboratorio interiore ricchissimo. Mi hanno obbligato a confrontarmi con i miei pregiudizi, le mie paure, i miei limiti e mi hanno insegnato a vedere, e in una certe misura, a vivere, il mio altro: la me stessa razzista, paurosa, limitata dal benessere nel quale sono vissuta. Mi hanno insegnato a essere felice di quello che ho.