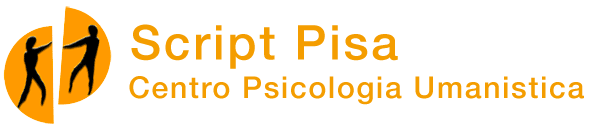I gruppi nell’associazione hanno subito una notevole evoluzione nel tempo. Nati dall’esperienza politica e sociale dell’UDI e affidati al volontariato si sono trasformati negli ultimi anni in modo significativo.
La filosofia, il modello rimangono gli stessi, ma le donne dell’Udi si sono trovate a vivere la trasformazione in servizio sociale della propria esperienza. Questo cambiamento si è riflettuto anche sui gruppi, e l’arrivo di donne molto sofferenti ha costretto le volontarie a professionalizzarsi, ricercando per sé e per il gruppo una formazione psicosociale pluriennale e una supervisione psicologica da parte di donne psicoterapeute.
La formazione è stata ampia in tutte le discipline umanistiche e si è orientata negli ultimi anni verso l’analisi transazionale, che tra le diverse scuole psicologiche è uno degli orientamenti più significativi per la teoria dei gruppi e dei copioni psicologici.
Dunque il linguaggio si è indirizzato principalmente verso quello analitico-transazionale, quindi in supervisione si può sentir parlare di stati dell’Io, transazioni e giochi psicologici.
La teoria di riferimento
La teoria degli stati dell’Io, elaborata dallo psichiatra americano Eric Berne, permette di identificare comportamenti, emozioni e sistemi di pensiero relativi a tre dimensioni funzionali:
Lo stato dell’Io Genitore è lo stato dell’Io in cui si osservano attivi i modelli di comportamento interiorizzati per imitazione e modellamento delle figure genitoriali dell’infanzia. Nelle donne in difficoltà generalmente lo stato dell’Io Genitore è costruito sul modello materno: la donna deve accudire ai figli e gli uomini di casa, deve sacrificarsi per la famiglia, deve fare molto per essere amata. La capacità di accudire e proteggere non è quasi mai orientata verso se stessa. Nel caso poi di persone che hanno subito maltrattamenti e abusi sessuali il Genitore interno è assolutamente poco protettivo e si comporta invece come un Genitore punitivo (se ti è accaduto quello che ti è accaduto la colpa è tua, tu sei sporca, sbagliata, indegna di amore). Dal punto di vista funzionale parleremo di Genitore interno protettivo quando la persona è capace di orientare verso di sé la capacità di cura e di nutrimento, parleremo di Genitore critico negativo, di Persecutore interno quando la donna si giudica continuamente in modo negativo come se avesse interiorizzato una costante svalutazione di sé.
Lo stato dell’Io Adulto è la dimensione psichica che sta in contatto con il qui-ora, con il presente, contiene la capacità di pensare e fare in modo congruente con le richieste ambientali. Spesso nelle donne la parte Adulta è molto centrata sul fare e poco sul pensare e rielaborare la propria esperienza, l’Adulto è contaminato da svalutazioni sulle proprie possibilità. E’ frequente, infatti, che queste donne mantengano il peso economico maggiore della famiglia, provvedendo al mantenimento dei figli per intero, lavorando all’esterno e dentro casa, eppure hanno la sensazione di dipendere dall’uomo e di non potercela fare da sole.
Lo stato dell’Io Bambino è il mondo interno dei bisogni emotivi, affettivi, ludici dell’infanzia e delle modalità apprese per soddisfarli. Certo con la crescita i bisogni si sono evoluti e trasformati, ma generalmente il modo di avvicinarsi agli altri, di cercare riconoscimenti, di giocare e scherzare, di divertirsi o inibirsi sono molto simili a quelli che usavamo nell’infanzia. Dal punto di vista funzionale in analisi transazionale distinguiamo uno stato dell’Io del Bambino libero che esprime i bisogni naturali e la spontaneità da uno stato dell’Io del Bambino adattato in cui rispondiamo alle esigenze di accettazione sociale e ci comportiamo in un certo modo per essere OK agli occhi di un Genitore personale o sociale. Nelle psicologia contemporanea si definisce con il termine “coping” questa capacità di rispondere in modo adeguato alle interazioni con l’ambiente. Nelle donne in difficoltà la parte Bambina è spesso inibita nella funzione libera, di godere e prendersi permessi, mentre è molto attiva nella dimensione di iperadattamento agli altri, soprattutto agli uomini. Ciò diventa evidente nel ruolo da Vittima che spesso ricoprono, nell’estrema difficoltà di concedersi cure personali e di sorridere.
In gruppo
È molto utile che la conduttrice sappia riconoscere gli stati dell’Io delle partecipanti al gruppo e di se stessa per utilizzare la comunicazione in modo da offrire stimoli positivi, cioè stimoli ad attivare lo stato dell’Io Genitore come funzione di autoprotezione, lo stato dell’Io Bambino come energia vitale libera e lo stato dell’Io Adulto come capacità di riconoscere le proprie risorse e di usarle in modo costruttivo.
L’analisi transazionale di Berne è nata come terapia di gruppo, proprio perché Berne riteneva che poiché la costruzione dell’Io avviene in modo interpersonale con l’interiorizzazione di limiti molto negativi, dovevano allo stesso modo esistere transazioni., cioè scambi tra persone che potessero curare e correggere le nostre esperienze primarie.
Gli esseri umani hanno un bisogno biologico di riconoscimenti, di carezze (strokes) diceva Berne. Per il bisogno di essere accolti e amati si prendono le decisioni di fondo del nostro copione psicologico.
Il copione (script) è, infatti, quell’insieme di decisioni inconsce che abbiamo preso nell’infanzia a proposito della vita, del rapporto con gli altri e con noi stessi e che ci condiziona ad assumere la parte della “buona” o della “cattiva” ragazza, la parte della madre martire o della prostituta, la parte della vittima o qualunque altro ruolo psicologico. Nei gruppi non si lavora all’analisi del copione, lavoro decisamente psicoterapico, ma si danno stimoli cognitivi perché si possa individuare che il copione si può cambiare e non è una sorta di destino nefando che incombe sulla vita come un maleficio. Spesso, infatti, la credenza popolare nelle fatture e nei malefici esprime la paura della parte Bambina della nostra personalità di essere prigioniere, senza potere nelle mani di dei malvagi o di oscure forze maligne. Scoprire che possono essere le nostre scelte ad attirarci i malefici, che può essere il nostro copione a farci scegliere gli uomini sbagliati è spesso la conquista di un percorso di apprendimento che si fa in gruppo. Così il gruppo, quando funziona come esperienza culturale, toglie lavoro ai maghi e lo restituisce agli psicologi e alla scienza.
Un altro concetto molto utile per i gruppi è quello di gioco
psicologico. Berne parlava già nel 1964 di gioco psicologico nel senso di una serie di transazioni inconsce, di scambi tra persone che producono esperienze negative e finali sgradevoli, nei casi più gravi finali tragici. E’ come affermare che ogni persona nella vita cerca partner compatibili con il proprio copione e che negli scambi che abbiamo con gli altri ognuno ripete generalmente degli schemi fissi, di cui in genere non ci accorgiamo. Se una persona si sente vittima degli altri, misteriosamente si ritroverà di frequente in relazioni in cui effettivamente sarà sfruttata. Ciò che in genere non percepiamo è che alcune esperienze negative potrebbero essere evitate se avessimo un diverso approccio alla realtà che ci circonda.
Una personalità dipendente è probabile che giochi a lamentarsi “E’ tutta colpa sua”, ma che non decida poi di sganciarsi dalla relazione infelice di cui si lamenta. E’ come se il vuoto fosse temuto di più del consueto negativo schema di gioco.
I gruppi hanno lo scopo di diminuire il potenziale negativo dei giochi che si fanno tra donne e di quelli che le donne fanno con i propri compagni.
La struttura del gruppo
Il gruppo si svolge come un circle-time in cui si arriva per invito. Il gruppo si svolge in due ore settimanali pomeridiane per dodici incontri in un tempo dunque di tre mesi.
Al primo incontro è spiegato dalla conduttrice come funziona l’esperienza. Le regole di partenza impegnano alla riservatezza su quanto si ascolterà nel gruppo, in modo che ogni donna si senta libera di poter condividere la sua storia e a mantenere la continuità di frequenza se accetta di partecipare. Si spiega che l’obiettivo del gruppo è aiutare le partecipanti a migliorare l’autostima e lo star meglio con se stesse.
Si spiega anche che in ogni incontro saranno proposti esercizi psicologici per introdurre la riflessione e la discussione. Si chiede di essere disponibili all’ascolto e di sperimentare un ascolto senza giudizi.
Il ruolo della conduttrice è quello di introdurre il tema, proporre gli esercizi, facilitare lo svolgimento della discussione e il confronto. In alcuni casi si chiede di accettare la presenza di una volontaria in formazione o di una studentessa in tirocinio che si impegna ad osservare le regole del gruppo.
Di solito gli incontri sono registrati con il consenso delle partecipanti per essere riascoltati in supervisione e permettere dunque una revisione del processo comunicativo.
Gli argomenti e le attività
Le conduttrici di gruppo hanno a loro disposizione un pacchetto di esercizi psicopedagogici, di attività di animazione di gruppo che combinano in vario modo, dopo aver tenuto conto di alcune regole fisse: prima tra tutte l’esigenza di dedicare i primi incontri alla conoscenza reciproca e alla formazione del gruppo e di dedicare l’ultimo incontro al feedback e alla separazione.
Nei primi incontri si fa un lavoro che è definito di contratto perché, dopo l’illustrazione delle regole e le presentazioni, si ascoltano le aspettative personali rispetto al gruppo e la facilitatrice aiuta a definire un obiettivo realistico di apprendimento e sperimentazione. L’obiettivo concordato e trascritto su un grande foglio costituisce il contratto sul quale poi sarà con dotta la verifica finale.
Es. Se una donna dice: “Io dal gruppo mi aspetto di trovare delle amiche perché non ne ho mai avute.”
La conduttrice potrebbe risponderle: ”Che cosa metterai di tuo in questa esperienza per trovare amicizia?” e la risposta della donna è utilizzata per valorizzare un suo impegno attivo nel cercare amicizie femminili.”Dunque tu raggiungerai il tuo obiettivo se ti sarai impegnata a comunicare e vivere la vicinanza con le altre.”
Oppure se una donna arriva con un atteggiamento di forte chiusura e dice: ”Io non mi aspetto più niente da nessuno, sono venuta in gruppo solo perché mi ci hanno mandato.”
La facilitatrice le chiederà di chiarire cosa sta dicendo: ”ci stai dicendo che sei stata così delusa dagli altri che adesso non ti aspetti più di ricevere cose buone?”
Se la risposta fosse affermativa, come è probabile, allora la facilitatrice potrebbe rispondere: ”Allora ti invitiamo a sperimentare se in questa situazione nuova potrai trovare invece qualcosa di utile per te. E c’è comunque qualcosa che tu sei disposta a dare alle altre?”
La specificazione delle aspettative e la definizione del contratto iniziale sono un momento molto importante perché si cominciano ad attivare le partecipanti nel gruppo e a confrontarle in modo soft rispetto ad aspettative magiche e grandiose (aspetto Babbo Natale o il principe azzurro) e rispetto ad un vittimismo lamentoso e passivo. La professionalità della conduttrice di gruppo sta proprio nell’arte di ascoltare senza giudicare e di confrontare con rispetto senza spaventare o criticare la persona che ha di fronte. L’atteggiamento benevolo e aperto della conduttrice fa il gruppo nella fase iniziale in cui l’identificazione con lei definisce il clima e dunque l’emotività del gruppo. Si torna al secondo incontro se ci si è sentite guardate e accolte, se il clima è stato sufficientemente caldo e accogliente, se gli input di confronto non sono stati percepiti come minacciosi. Infatti, quanto più una persona ha un’autostima bassa e un fragile senso di identità tanto più non potrà tollerare critiche e confrontazioni che percepirebbe come attacchi aggressivi. In analisi transazionale si definisce la posizione esistenziale assertiva verso sé e gli altri: ”Io sono Ok, tu sei Ok”. Soltanto da questa posizione emotiva può partire una decisione costruttiva di cambiamento. Per intraprendere una separazione con successo, per fare una dieta, per smettere di fumare, bisogna sentire in sé l’energia per farcela, quando si è molto disperate ci si aggrappa a ciò che si ha nel presente perché il cambiamento non appare possibile.
La posizione comunicativa nei gruppi vuole essere per le donne il metamessaggio di fondo: “Tu sei Ok”, “Tu hai l’energia per farcela”, “Tu hai le risorse per vivere in modo autonomo”, “Tu puoi essere amata per quello che sei”, “Tu puoi imparare ad amare te stessa”.
La posizione emotiva della facilitatrice non si improvvisa, ma è il frutto di un lungo lavoro di formazione e supervisione e si rinforza nell’appartenenza al gruppo-associazione dove ciò che si propone alle donne-utenti del servizio è vissuto in prima persona. La credibilità di ciò che si dice, infatti, non dipende dalle parole, ma dal comportamento.
Dal secondo incontro si cominciano gli esercizi sulla conoscenza di sé e sull’aumento dell’autostima. Ad esercizi di aumento della consapevolezza si intrecciano esercizi di incremento dell’autostima per rinforzare lo stato dell’Io Adulto e far sperimentare che si possono avere piccoli successi. In questa logica, infatti, si insegna a dare “carezze”, cioè riconoscimenti positivi alle compagne di gruppo e nella stessa ottica la facilitatrice propone semplici compiti per casa (homework) come ad es. “Prenditi mezz’ora al giorno per te” o “Ogni giorno scrivi una cosa che ti è piaciuta di te.”
E’ importante che agli incontri centrali del percorso si arrivi con un bagaglio di vissuti positivi rispetto alla relazione con le altre donne, per cui quando comincia il tempo della condivisione delle storie drammatiche di violenza e sofferenza ci sia un gruppo capace di contenere il dolore. In alcuni gruppi quando i racconti drammatici sono portati precocemente ci sono alcune interruzioni perché il potenziale negativo, distruttivo può spaventare e far fuggire qualcuna. E’ dunque un’abilità della conduttrice permettere i racconti più drammatici quando c’è un gruppo capace di accogliere e di contenere inizialmente alcuni sfoghi perché non debordi l’angoscia. Il gruppo è indubbiamente anche un luogo di sfogo, un luogo di espressione emotiva, un luogo catartico in cui lasciare la negatività accumulata e scaricarsi, ma questo deve essere fatto con la protezione adeguata per tutte le partecipanti e con l’obiettivo di imparare qualcosa da questa condivisione.
Nell’ultima fase di gruppo in genere si è creato un forte senso di appartenenza e le donne sentono che sono riconosciute e premiate psicologicamente dalle altre se fanno qualcosa di positivo e spesso se avviano la separazione dal compagno. Per questo talvolta le donne si vergognano delle proprie fragilità, delle crisi, dei ritorni indietro ed è ancora compito della conduttrice mantenere il gruppo in una lettura realistica. Non si fanno capovolgimenti radicali in pochi mesi, è comprensibile che si possa regredire anche nel cammino intrapreso, l’importante è che non si premi il “falso sé” che spingerebbe a fingere per essere approvate dal gruppo. Il meccanismo naturale di adattamento al gruppo spingerebbe, infatti, le partecipanti a fingere di essere diverse da quello che sono pur di sentirsi integrate ed accettate dalle pari. Dare il permesso di sbagliare, di decidere in autonomia sulla propria vita, di riconoscere le proprie dipendenze senza negarle significa spesso indirizzare le donne verso la psicoterapia successiva al gruppo e verso un sostegno individuale che il centro può fornire. Spesso queste donne hanno un vissuto di depressione, hanno disturbi alimentari, hanno un copione di dipendenza affettiva e storie di abusi, hanno figli con problemi e compagni difficili. La resistenza al cambiamento è forte in queste situazioni in cui spesso si aggiungono anche problemi economici e carenze culturali. Il percorso dell’affrancamento è lungo.
Bibliografia:
E. Berne, Analisi transazionale e psicoterapia, ed. Astrolabio,
E. Berne, Principi di terapia di gruppo, ed. Astrolabio, 1986 (Principles of group treatment, Grove Press, New York, 1966)
E. Berne, Ciao.. e poi?, Bompiani, 1979 (What do you say after you say hello?, Beverly HillsCity National Bank, 1972)
E. Berne, A che gioco giochiamo, Bompiani, 1967 (Games people play, Grove Press, New York, 1964)