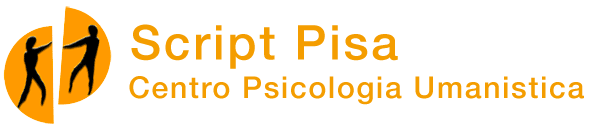… perché una prima infanzia custodita, protetta è il
fondamento per un’età adulta accompagnata dal
successo. Non è contemplabile la possibilità che
un bambino sia amato troppo.
D. Morris, Il bambino
Introduzione
Mai come in questi ultimi anni si sente così tanto parlare del tema della genitorialità.
Se ne parla purtroppo quando ci si scontra con fatti di cronaca nera che riguardano violenze e abusi sui minori, con fenomeni di bullismo, con l’uso di sostanze stupefacenti e con una sessualità che sembra essere sempre più anticipata e sempre meno compresa dai giovanissimi. Ci si domanda: in tutto ciò dove sono i genitori? Sono causa o vittime loro stessi di questi fenomeni?
In realtà, si parla molto di genitorialità anche rispetto semplicemente al “come si diventi dei bravi genitori”.
Dilaga infatti il boom di libri, veri e propri “manuali d’istruzione” per genitori e neo-genitori. La formula è molto semplice: se hai difficoltà nell’educare il tuo bambino, segui queste brevi e semplici regole e il gioco è fatto! La parola chiave è “educazione”.
Non nascondo la mia perplessità e la mia sfiducia nei confronti di un approccio così semplice, semplicistico e preconfezionato ad un tema invece così complesso e delicato come quello del rapporto genitori-figli e più in generale dell’Infanzia. Troppo si è parlato, si è straparlato, troppo poco si è realmente compreso ciò di cui il bambino ha realmente bisogno e dunque ciò che un genitore deve mettere in atto per rispondere alle sue esigenze.
La pedagogia nera e i falsi miti
Alice Miller, psicoterapeuta ed ex-psicoanalista freudiana, utilizza il termine “Pedagogia nera” (1980) per indicare un approccio educativo basato sull’utilizzo di castighi, punizioni corporali, regole rigide, manipolazione, induzione di paure, sottrazione d’amore, isolamento, umiliazione, disprezzo, derisione e più in generale una relazione con il bambino che sia distaccata e mai troppo amorevole. L’autrice sottolinea come questa pedagogia venga in qualche modo razionalizzata, da chi la sostiene, con il fatto di essere messa in atto “per il bene del bambino”. In realtà, continua la Miller, l’unico vero bene che ne può scaturire è esclusivamente quello dei genitori stessi e mai, in nessun modo, quello del bambino.
Volendo riassumere il pensiero milleriano, la pedagogia nera si basa su alcuni pilastri ben definiti:
1)Gli adulti sono i padroni (anziché i servitori) dei bambini che da loro dipendono;
2)Essi, atteggiandosi a dèi, decidono che cosa sia giusto o ingiusto;
3)La loro collera deriva dai loro conflitti personali;
4)Essi ne considerano responsabile il bambino;
5)I genitori vanno sempre difesi;
6)I sentimenti impetuosi del bambino rappresentano un pericolo per il loro padrone;
7)Si deve “privare” il più presto possibile il bambino della sua volontà;
8)Tutto questo deve accadere molto presto affinché il bambino “non si accorga” di nulla e non possa smascherare gli adulti.
La pedagogia nera fornisce sin da subito delle false informazioni che il bambino acquisisce a livello cognitivo ed emotivo e che si trasmetteranno poi di generazione in generazione. Eccone alcune:
1)L’amore può nascere per senso del dovere;
2)I genitori meritano rispetto a priori proprio in quanto genitori;
3)I bambini, a priori, non meritano rispetto;
4)L’obbedienza fortifica;
5)Un alto grado di autostima è nocivo;
6)Un basso grado di autostima favorisce l’altruismo;
7)Le tenerezze sono dannose (amore cieco);
8)È male venire incontro ai bisogni dei bambini;
9)La severità e la freddezza costituiscono una buona preparazione per la vita;
10)I genitori sono creature innocenti e prive di pulsioni.
Credo che questo tipo di pedagogia sia ancora molto in auge oggi. Il problema è che troppo spesso appare in una forma velata, mascherata e dunque più difficile da percepire. Appare inoltre in una forma professionale di “pseudo-scientificità”estremamente difficile da mettere in discussione, soprattutto per un non addetto ai lavori (psicologi, medici, educatori).
Sono per fortuna lontani i tempi in cui si applicavano metodi che letteralmente torturavano il bambino, come ampliamente descritto e suggerito per esempio dal pediatra D.G.M. Schreber nella seconda metà dell’800, in cui si consigliava al genitore di utilizzare veri e propri strumenti di tortura per educare i propri figli (raddrizzatori, lacci, punizioni corporali).
Rimane però di fatto un tipo di educazione che, come vedremo, nuoce gravemente alla salute psichica ed emotiva del bambino, benché spacciata per l’unica vera “educazione infantile” possibile.
I manuali a cui accennavo prima, per esempio, oltre a programmi televisivi tanto in voga in questi ultimi anni, nascondono a mio avviso i germi di una pedagogia nera, benché di fatto siano vendutissimi ed accessibili davvero a tutti. Hanno copertine accattivanti, spesso in piena contraddizione poi con i reali messaggi contenuti all’interno, e sono reperibili addirittura nei supermercati. I loro grandi numeri di vendite ci fanno pensare per logica ad una grande realtà: c’è effettivamente un disperato bisogno dei genitori di farsi dire cosa e come fare per poter svolgere al meglio il proprio ruolo genitoriale.
L’aspetto inquietante di questi manuali parte già dal titolo: Neonati maleducati, Fate i bravi, Fate i compiti, Fate la nanna, Facciamola finita, Si fa come dico io, Manuale di sopravvivenza per neomamme, per finire in bellezza con l’ironico ma quanto mai agghiacciante Fai la nanna bastardo!
Il prossimo in uscita potrebbe essere direttamente Bambini, non rompete i coglioni!oppure Maledetto il giorno che vi ho creato!
Si potrebbe iniziare con la ben nota “Tata Lucia”, che nei suoi libri e nella sua famosa trasmissione, sembra relegare l’essere genitore all’unico ruolo del saper imporre un’educazione: sostanzialmente imporre regole in base alle quali, in un’ottica skinneriana, stabilire premi e punizioni. Devo dire che mi rimane difficile inserire totalmente questo approccio in una pedagogia nera, visto che alcuni passaggi possono a mio avviso essere condivisibili, come per esempio il fatto che vengano messi in discussione anche i genitori stessi, che siano sconsigliate le botte e che, più in generale, l’approccio non risulta essere totalmente “anti-bambino”. Gli aspetti “neri” di questo approccio pedagogico sono legati però al fatto di vedere nel bambino un essere capriccioso da “correggere”, da far crescere quanto prima (come ai tempi dell’antica Grecia e dell’antica Roma, quando l’infanzia era vista come un periodo “inutile” per l’individuo, da superare il più in fretta possibile per raggiungere l’età adulta, unico vero status degno di nota). L’autrice sottolinea per esempio l’importanza di sistemare sin da subito il neonato in una sua stanza, diversa da quella dei genitori e ci mette in guardia dal prendere il neonato in braccio ad ogni suo minimo cenno di protesta. Nella sua trasmissione la tata osserva, come una sorta di orwelliano “Grande Fratello”, il comportamento di bambini e genitori, appuntando tutto e pronta a dare un voto. Mi lascia perplesso quando vedo la casa venire riempita da regole affisse sui muri, davvero come il monito del romanzo di Orwell che, affisso nelle strade e nelle case, avvisa:“Il grande fratello vi guarda”…
Ci sono poi alcuni autori che vanno ben oltre questi suggerimenti, andando ad inficiare seriamente quello che credo rappresenti uno dei significati profondi della nostra esistenza e cioè la relazione tra genitori e figli nei primi anni di vita.
Ecco alcuni esempi:
“Si possono ottenere risultati solo se si è capaci di instaurare un rapporto che riesca a convertire l’inevitabile frustrazione del piacere immediato in obbedienza a ciò che ‘impone’ il genitore […] ››, oppure ‹‹ sottoporre il bambino a frustrazioni (divezzarlo, farlo dormire da solo nel suo lettino e nella sua cameretta, non fargli mangiare il cibo spazzatura, imporgli il rispetto degli altri…) non vuol dire di per sé sottoporlo a traumi irreversibili che lo condanneranno a malesseri gravi nella vita adulta. Anzi. Una ‘giusta’ dose di frustrazioni lo aiuterà a crescere, a fare i conti con l realtà, che porrà sempre problemi conflittuali tra ciò che desideriamo e ciò che possiamo. E’però il genitore che spesso non regge alla prova di fronte a un bambino che piange, strepita, si dispera, urla” (P. Sarti, 2011). Si parla di bambini “antipatici”, di genitori che sbagliano ad utilizzare le “coccole”, perché non lo fanno per il bambino, ma per una loro grave incapacità di imporre delle regole.
Questo testo trasuda a mio avviso un vero e proprio odio verso i bambini, credo evidente per esempio in questo passaggio: “E non sarebbe poi meglio che i figli pensassero anche che ogni tanto i genitori si divertono facendo cose ‘da grandi’, proprio perché e quando loro non ci sono? Non è giusto fargli credere che tutto ciò che è ‘senza di loro’ è fatica, brutto e noioso [..]”.
In realtà, come vedremo, il bambino ha bisogno proprio di sentirsi al centro dell’attenzione dei suoi genitori, pena un senso di annientamento psicologico ed esistenziale. Scrive anche l’autore: “L’ultima, ma non minore, antipatia è quella di quando (i bambini) si ritrovano esortati e autorizzati a fare lo spettacolino, con noi, impossibilitati a fuggire, costretti a fare da spettatori. Non mi riferisco tanto al classico, ormai antico “Fai ciao con la manina!” o alla recita della poesia di Natale (tortura storica, che è toccata un po’ a tutti […]. Parlo piuttosto dell’antipatia di cene dopo cene immancabilmente trascorse a parlare solo di loro, a far parlare solo loro, ad analizzare e approfondire solo ciò che fanno loro […] quando noi ospiti, ormai stremati, possiamo finalmente liberarci, salutare e ringraziare per la splendida serata”.
Il bambino è dunque visto come un “adulto in miniatura”, egoista, narcisista, con gli stessi bisogni dell’adulto e ci si relazione a lui proprio come ad un adulto (“adultomorfismo”): lo si disprezza, lo si umilia, non se ne riconoscono i bisogni profondi di amore, attenzione, conferma e si dà per scontato che voglia solo consapevolmente rovinare la vita agli adulti.
Altri autori come R. Albani (2004) vedono nel bambino un soggetto attivo che ha un grande “potere”, un potere di cui è consapevole e che utilizzerebbe in modo distruttivo contro i suoi genitori per ottenere un soddisfacimento immediato a propri bisogni istintuali. Un potere di cui il bambino abusa sin dai primi mesi di vita. Si parla del rapporto tra genitori e figli come di una “guerra” in cui spesso e volentieri è proprio il bambino a vincere, sapendo utilizzare al meglio il proprio armamentario bellico: “I bambini, anche in tenerissima età, non sono affatto gli esseri indifesi che sembrano, ma, nel contesto del rapporto d’amore con i genitori, posseggono mezzi perfettamente adeguati per ottenere ciò che desiderano […]. Anzi, se non limitati con fermezza, sono in grado di conquistare agevolmente una posizione di predominio nella famiglia”.
Nel loro armamentario rientrerebbero, secondo l’autore, l’essere polemico, manipolatore e ricattatore. Tutti requisiti, io credo, tipici invece dell’adulto, consapevole di ciò che è e di come ottenere ciò che vuole ed assolutamente lontani anni luce dalla mentalità semplice e fragile del bambino. Non si parla di amare il bambino, di comprenderlo, di proteggerlo, che come vedremo rappresentano l’essenza dell’essere genitori, ma di ‘deludere’ il bambino già nelle prime settimane di vita, frustrando i suoi bisogni, che altro non sono che ‘capricci’ e facendogli capire sin da subito chi è che comanda. Ma questo, tranquilli, sempre e solamente per il bene del bambino…
Questo autore ritiene che l’educazione dei bambini possa e debba passare anche attraverso l’uso delle percosse, visto che “è enormemente esagerato affermare che, picchiando un figlio, si rischia sempre di danneggiarne la personalità o di spingerlo a essere a sua volta violento”.
E invece è esattamente quello che succede, si rimettono in atto da adulti quegli stessi comportamenti e atteggiamenti che per primi, da bambini, abbiamo vissuto e subito. Alice Miller ha dedicato una vita a spiegare proprio questo, analizzando per esempio a fondo le biografie di grandi dittatori della storia, come Hitler, Stalin e Ceausescu: le violenze subite nell’infanzia vengono “inconsapevolmente” rimesse in atto su terzi una volta diventati adulti. Anche autori ben noti come G. Gabbard (2000) e N. McWilliams (1994) descrivono in lungo e in largo come esperienze traumatiche nell’infanzia possano creare un disagio psicologico più o meno grave in età adulta. J. Bowlby (1969-1980) ha studiato sul campo le reazioni emotive e comportamentali dei bambini ai differenti stili di accudimento genitoriale e dimostrato che, una volta adulti, quegli stessi bambini utilizzeranno uno stile relazionale più o meno disfunzionale, introiettato nell’infanzia ed automaticamente applicato alla vita adulta.
Nella presentazione dell’ennesimo libro su come far dormire i propri bambini si legge: “Non più considerare il vostro pupo come un agnellino dolce e paffuto da lenire e blandire, ma come quello che la scienza e l’esperienza ci insegnano essere: un vero perverso polimorfo, come dice Freud. Uno cui non frega niente se voi non dormite, anzi che ci gode, a non farvi dormire. Un egoista assoluto, un tiranno senza pietà, dedito solo ed esclusivamente al suo proprio piacere. Un piccolo mostro. […] è una battaglia da combattere faccia a faccia e con le stese armi del nemico: l’astuzia, la furba malizia, l’inganno, qualche volta anche la necessaria crudeltà”.
Non metto in dubbio che nel libro si possa volutamente utilizzare un linguaggio ironico e provocatorio, ma i messaggi sull’infanzia che ne emergono sono infondati e soprattutto deleteri. I concetti di “perversione” e “crudeltà” sono sicuramente mutuati dalla letteratura freudiana e kleiniana che, come oggi sappiamo, nessun contributo scientifico hanno dato alla comprensione dello sviluppo infantile, ma hanno creato solamente falsi miti che ancora oggi, ahimè, permeano la nostra (non) cultura dell’infanzia. In un’altra sede (A. Costantini, “Freud. La grande menzogna sull’infanzia”, in press) ho voluto approfondire come il falso mito freudiano del bambino perverso sia ancora molto in auge e messo in atto attraverso un modo adultocentrico e perverso in tutti gli ambiti di intervento rivolti ai minori (psichiatria, psicoterapia, scuola, giustizia minorile, etc.).
Tanto si è detto anche sul pianto del bambino. Secondo il filone pedagogico di cui sopra, moltissime volte il pianto non è un indicatore di un reale disagio, ma è semplicemente un capriccio, una modalità manipolatoria che il bambino utilizza per attirare l’attenzione su di sé anche se non ce ne è necessità. Sicuramente esistono anche i capricci, ma solitamente quando un bambino molto piccolo piange, lo fa per esprimere un vissuto di disagio che va sempre preso molto sul serio.
Non padroneggiando ancora il linguaggio e non avendo ancora una struttura di personalità ben definita, il bambino utilizza il pianto come unico canale di comunicazione a lui noto e per il quale è programmato geneticamente. Il pianto ha infatti una funzione adattativa, permette cioè al bambino di mostrare il suo bisogno di aiuto e di attivare nel care-giver una risposta di cure parentali, anche questa programmata geneticamente. M. Sunderland e J. Panksepp (2006) hanno raccolto circa ottocento ricerche che dimostrano i danni psicologici e neurologici del pianto prolungato nel bambino. OTTOCENTO studi scientifici! C’è da aggiungere altro?
La massima espressione della pedagogia nera la troviamo però in un autore spagnolo, E. Estivill (1996), che nel suo libro “Fate la Nanna” arriva perfino ad associare il bambino appena arrivato in famiglia ad un “oggetto”, il cui libretto di istruzioni è rappresentato dal suo metodo che, a detta dell’autore, sarebbe efficace nel 96% dei casi.
E’un metodo che nasce per far addormentare i bambini, o meglio per permettere ai genitori di dormire… L’insonnia del neonato, infatti, è secondo l’autore solo uno degli “orrori domestici” a cui i genitori devono sottostare per colpa del bambino, in aggiunta a coliche, prima dentizione, deambulazione e quant’altro. Ecco allora che il suo illuminante metodo risolve definitivamente il problema del nostro bambino, che proprio non ne vuole sapere di prendere sonno. Senza entrare nei dettagli, basti sapere che questo metodo è molto “tecnico”, si comincia con una fase, per poi passare alle altre; l’autore indica cosa fare, come farlo, per quanto tempo farlo… il risultato è garantito!
Credo che questo video valga più di mille parole http://www.youtube.com/watch?v=i6_t100Nj2Y
Ebbene, cosa ne pensate? Che effetto vi fa? Io personalmente lo trovo agghiacciante, a stento riesco a trattenere le lacrime pensando a quanta sofferenza quel povero bambino deve provare. Sofferenza e frustrazione che a detta dell’autore è normale e salutare che il bambino provi. Mi colpisce anche l’angoscia della povera mamma che è evidentemente in uno stato confusionale, di ambivalenza, fa quello che l’esperto le dice, ma emotivamente non regge, percepisce il dolore del suo cucciolo. Un metodo dunque che nuoce al bambino, ma credo anche al genitore che lo mette in atto, perché va a snaturare una sana e serena relazione tra genitore e figlio.
Mi preme sottolineare come il fatto che il bambino, se ignorato dai genitori, alla fine si addormenta, non sia altro che aver scoperto l’acqua calda: in etologia questo fenomeno si chiama “tanatosi”, un modo con cui l’animale predato simula di essere morto per poter non essere divorato dal predatore. Il bambino dunque non si addormenta perché ha sonno ed è finalmente tranquillo, ma perché è come se i suoi geni gli dicessero “la minaccia (buio, solo nella stanza, genitori non protettivi) è troppo grande per te, non puoi sconfiggerla, arrenditi e fingiti morto”.
E’ lo stesso meccanismo emotivo inconscio che troviamo per esempio alla base della depressione. Il bambino che si addormenta in questo modo è un bambino terrorizzato, che vivrà nel terrore (ansia, attacchi di panico, insicurezza) anche da adulto.
Estivill dedica alcune righe anche ai “movimenti autocullanti” del bambino, cioè quei movimenti di dondolamento che il bambino mette in atto da solo per addormentarsi. Secondo l’autore sono comportamenti infantili normali, che non devono mettere in apprensione il genitore. In realtà essi rappresentano un mezzo che il bambino ha per fare da solo ciò che qualcun altro dovrebbe fare per lui: essere cullato, coccolato e protetto, soprattutto in un momento così delicato e fragile come quello del sonno, in cui il bambino è totalmente inerme. Una sorta di movimento “transizionale” per dirla con Winnicott, che va a sostituire il cullare materno. Una mamma “naturale” culla il proprio cucciolo per farlo addormentare, non lo mette da solo in un lettino lasciandolo con un bisogno frustrato al punto tale da metterlo nella condizione di cullarsi da solo. Altro che comportamento normale!
Questi autori, a mio avviso, peccano inoltre di almeno due errate convinzioni:
a)confondono la causa con l’effetto: il bambino che piange, per esempio, non è capriccioso, ma il suo pianto altro non è che una conseguenza di un deficit delle cure genitoriali. Così il bambino che richiede molto affetto, non è un bambino “appiccicoso”, ma un bambino che evidentemente non sta ricevendo dai suoi genitori la giusta dose di affetto. Questi autori sostengono che il bambino troppo coccolato diventerà poi un “mammone” o addirittura un “narcisista” o un “criminale”, ma la ricerca scientifica dimostra esattamente il contrario: un bambino amato crescerà più autonomo e più sicuro di sé e della relazione con gli altri. Il narcisista, per esempio, è colui il quale ha ricevuto poche attenzioni da bambino e, da grande, in una sorta di idealizzazione compensatoria, si convincerà di essere speciale e di meritare attenzione, quell’attenzione che proprio da piccolo ha ricercato nei suoi genitori e che non gli è stata concessa. Ricordiamoci che tanto più ricerchiamo qualcosa, tanto più evidentemente ci è mancata e non il contrario.
b)sembra che i genitori di oggi siano tutti “mollaccioni”, pronti a rispondere adeguatamente ad ogni minima richiesta del loro bambino e che per questo necessitino di imparare ad educare i loro figli… Ma è davvero questo ciò che vediamo nelle famiglie di oggi? A me, senza voler generalizzare, sembra esattamente il contrario. E se anche ci fossero (e fortunatamente ce ne sono) genitori davvero competenti, ecco che arriva puntuale e feroce la critica dei pedagoghi neri!
c)probabilmente a livello inconscio i sostenitori della pedagogia nera non hanno loro per primi elaborato e superato le sofferenze e i conflitti legati alla loro infanzia. Dice infatti D. Stern che nei confronti del bambino “le risposte dell’adulto dipendono, in gran parte, dal trattamento che egli stesso ha ricevuto durante l’infanzia, ovvero dalla interpretazione che i suoi genitori hanno dato, a loro volta, dei suoi sentimenti e del suo comportamento” (D. N. Stern, 1990).
Il cosiddetto bambino “viziato”, sostiene D, Morris (1991), non è quello che è stato amato, preso in braccio e protetto, ma quello che non ha ricevuto tutto questo. E’ “viziato” nel senso che viene “forzata” la sua normale espressione ed il suo normale sviluppo. E’ dunque la definizione esattamente opposta a quella che viene data di solito.
La Pedagogia bianca e i veri miti
Per fortuna, però, esiste anche una “Pedagogia bianca”, purtroppo ancora troppo poco conosciuta e troppo poco applicata. Questa, come è intuibile, si poggia su assiomi diametralmente opposti a quelli della pedagogia nera:
1)Il bambino è sempre innocente;
2)Ogni bambino ha esigenze particolari ineluttabili, tra le altre il bisogno di sicurezza, affetto, protezione, contatto, sincerità, calore e tenerezza;
3)Queste esigenze sono soddisfatte raramente, ma sono spesso sfruttate dagli adulti per i loro scopi;
4)L’abuso subito da bambino ha delle conseguenze per tutta la vita;
5) La società è dalla parte degli adulti e accusa il bambino di ciò che a lui è stato fatto;
6)La realtà della vittimizzazione del bambino è sempre negata;
7)Pertanto, si continuano ad ignorare le conseguenze di tale vittimizzazione;
8)Il bambino, abbandonato alla sua solitudine dalla società, non ha altre possibilità che negare il trauma e idealizzare coloro che glielo hanno inflitto;
9)La negazione crea nevrosi, psicosi, disturbi psicosomatici e crimini;
10)Nella nevrosi i veri bisogni sono repressi e negati e il soggetto vive al loro posto sentimenti di colpa;
11)Nella misura in cui sarà possibile scoprire con sicurezza e senza ambiguità le risorse di consapevolezza nascoste nelle esperienze dell’infanzia, le storie delle vittime potranno aiutare la società in generale e la scienza in particolare, ad aumentare il loro livello di coscienza.
Possiamo ritrovare in E. Weber (2007) delle differenze sostanziali tra pedagogia nera e pedagogia bianca anche rispetto a quelle che sono le interazioni madre-bambino nei primissimi anni di vita del bambino:
|
A basso contatto |
Ad alto contatto |
|
Nascita industrializzata con separazione madre/bambino. |
Nascita in ambiente protetto.
|
|
Risposta ai bisogni del bambino non immediata e con surrogati (ciucci, biberon, oggetti sostitutivi della madre). |
Risposta immediata ai bisogni dei bambini tramite contatto fisico.
|
|
Interazione diretta principalmente visiva e verbale, solo occasionalmente fisica. |
Interazione basata sul contatto fisico.
|
|
Allattamento artificiale, o al seno solo per pochi mesi e non a richiesta. |
Allattamento a richiesta giorno e notte. |
|
Durante il giorno bimbo in contenitori vari (ovetti, sdraiette, box, girelli, passeggini). |
Portare i bimbi in fasce e altri portabebè.
|
|
Sonno solitario. |
Sonno condiviso (co-sleeping). |
|
Madre sola, cure non condivise. |
Cure materne condivise. |
L’aspetto a mio avviso interessante, è che non ci sono studi scientifici che dimostrino l’efficacia e i vantaggi di una genitorialità a basso contatto e più in generale di un approccio all’infanzia basato sulla pedagogia nera. E’vero invece che molti sono gli studi e le ricerche scientifiche che dimostrano l’efficacia e i vantaggi per il bambino di cure parentali ad alto contatto e secondo i principi della pedagogia bianca.
E. Balsamo (2002) ha dimostrato come i bambini cresciuti con un relazione ad alto contatto piangono molto meno di quelli allevati con una relazione a basso contatto, sono più sicuri, meno aggressivi e i disturbi mentali sono in una percentuale bassissima. Altri studi dimostrano come i bambini portati in fascia piangano meno (A. Hunziker, R. Barr, 1986) e diventino autonomi prima dei bambini lasciati per molto tempo da soli in box o passeggini (E, Weber, 2007).
La genitorialità ad alto contatto aumenta inoltre il numero dei recettori del cortisolo, che produce una maggiore capacità di gestione dello stress (S. Gerhardt, 2006).
Uno studio del Dott. Lipsitt della Brown University riportato da P. Angela (2000), dimostra come bambini nati prematuri, se stimolati con massaggi, coccole, parole, offrendogli cioè quegli stimoli materni che solitamente un neonato riceve, riescono a recuperare dei deficit cognitivi, cosa non possibile nei bambini prematuri lasciati soli in incubatrice.
Come non prendere definitivamente atto di tutto ciò?
Genitorialità: quando l’attaccamento incontra la cura parentale
Il concetto di Genitorialità è comprensibile solo in rapporto al concetto di Attaccamento.
Comprendere cosa significhi essere genitori implica necessariamente il comprendere cosa significa essere bambini e figli. Sono convinto che non “si fa” il genitore, ma “si è”un genitore. E la distinzione non è solo accademica.
Avete mai visto un animale, in particolar modo un mammifero (la specie a cui apparteniamo anche noi), o ancora meglio uno scimpanzé (con il quale condividiamo circa il 99% dei geni) chiedere spiegazioni su come prendersi cura del proprio cucciolo? Avete mai visto in natura una tata pelosa con caschetto biondo insegnare ai cuccioli a fare i bravi e ai genitori ad essere dei bravi genitori? Credo proprio di no… Con questo voglio dire solamente che ciò che viene richiesto ad un genitore rispetto al prendersi cura del proprio piccolo, è tutto già scritto nei nostri geni.
Un genitore (mi riferisco a genitori “medi non patologici”; qui infatti si aprirebbe tutto un altro capitolo sul maltrattamento subito nell’infanzia che viene poi reiterato a sua volta sui propri figli) sa già come comportarsi con i propri figli piccoli, basta seguire il proprio istinto. Questa non deve essere vista come una brutta parola, ma anzi rappresenta il normale e naturale corso che la genitorialità dovrebbe seguire se qualcuno o qualcosa non si frapponesse tra genitori e bambini.
D. Winnicott (1987) sostiene proprio questo: “Accadrà spesso che persone sconsiderate cerchino di insegnarvi come fare le cose che voi siete in grado di fare meglio di quanto chiunque possa mai insegnarvi a fare. E’mia opinione che non ci sia bisogno di dire alle madri che cosa devono fare o come devono essere. Ciò che possiamo fare è non interferire”.
Alice Miller si è battuta per creare un filone “anti-pedagogico” (con la stessa enfasi di quello “anti-psichiatrico”), perché ha sempre considerato inutile e deleteria qualsiasi forma di pedagogia..
J. Bowlby, a partire dagli anni ’70, ha coniato il concetto di “attaccamento”: un processo innato che spinge il cucciolo animale e umano a ricercare protezione e cure parentali da parte del proprio genitore. K. Lorenz (1952) coniò il concetto di “imprinting” per sottolineare il fatto che un individuo alla nascita si “attacca” al “primo oggetto di cura” con cui entra in relazione (a Lorenz si attaccò l’oca Martina). E’ un processo spontaneo, programmato geneticamente, finalizzato alla sopravvivenza della specie. Il bambino, infatti, non ha alcuna possibilità di sopravvivere senza l’accudimento del genitore, da solo non può nulla, è totalmente inerme.
L’imprinting nell’Uomo è collegato ad un processo cerebrale che dura circa 36 mesi chiamato “sinaptogenesi” e che rappresenta la piena formazione dei collegamenti sinaptici, più semplicemente la maturazione di base del cervello. Come sappiamo, infatti, nell’Uomo si parla di “esogestazione” per indicare come i nove mesi di vita intrauterina non siano sufficienti al feto per svilupparsi completamente. Una grossa parte del cervello, con annesse tutte le su funzioni, si sviluppa dopo la nascita. E a chi spetta far sì che il tutto proceda per il meglio? Chiaramente ai genitori. L’imprinting infatti è un processo irreversibile, che dura tutta la vita. E’ legato alla memoria, che farà da riferimento per le future esperienze relazionali: svilupperemo una personalità e faremo delle scelte relazionali proprio in base a quanto abbiamo “appreso” su di noi e sul mondo circostante nei primissimi anni della nostra vita.
Lo scopo ultimo dell’attaccamento è quello di essere “protetti” dalle “minacce” del mondo circostante (ieri animali predatori, oggi automobili, malattie, pedofili…)
Come dimostrano studi pioneristici, il “cucciolo” non ricerca solo la soddisfazione di bisogni fisiologici primari (fame, sete, sonno, addirittura “sesso” secondo la teoria freudiana!), ma prevalentemente è mosso dalla ricerca di protezione e di relazione(Harlow, 1958-1965).
Questa breve digressione per sottolineare come la genitorialità debba essere intesa rispetto al proteggere e all’amare chi abbiamo messo al mondo, dal momento che da solo non può farlo. In questo senso credo che i genitori, nei primi anni di vita del bambino, rappresentino a tutti gli effetti un “corpo in comodato d’uso ai propri figli”.
Il genitore è agevolato in questo, perché è la natura stessa del bambino che lo spinge alla ricerca di protezione, unico vero comportamento per lui fondamentale. La natura infatti ha donato al bambino una serie di “caratteristiche” specifiche che gli permettono di riuscire in questo suo intento:
a)la “configurazione infantile”: testa e occhi grandi, pelle liscia, movimenti goffi, rotondità. Tutte caratteristiche del bambino che attraggono il genitore verso di sé;
b)l’ attenzione del bambino “focalizzata” sul viso della madre, sia a livello visivo, sia a livello acustico: “Ehi, io sono qui, mi vedi?”;
c)il “sorriso ammaliante”: anche nei bambini nati ciechi, a dimostrazione del fatto che il sorriso rappresenta un comportamento non appreso, ma innato, che ha l’unico scopo di avvicinare a sé il genitore;
d)il “pianto” come richiesta di attenzioni: chi può rimanere impassibile di fronte al pianto di un bambino?
Il bambino perciò fa di tutto per poter essere protetto dai genitori, massimizzando l’utilizzo degli “strumenti comportamentali” in suo possesso per attirare la loro attenzione. E’ inoltre dotato di risposte innate che mettono in risalto proprio questo suo bisogno di attaccamento:
a)il “riflesso di presa”: lo stringere le dita al semplice passaggio di un dito per esempio;
b) il “riflesso di Moro”: il bambino sollevato tende ad “aggrapparsi” al genitore per non cadere (è un riflesso atavico, eredità di quando avevamo una folta pelliccia a cui il cucciolo si aggrappava);
c)il “riflesso di suzione”: il tendere a succhiare appena ci si avvicina intorno alla bocca con la mano o con un oggetto;
d) il “riconoscere” l’odore materno (anche al buio). E la madre riconosce quello del figlio.
Insomma, il bambino molto piccolo non fa altro che dire: “Ehi sono qui! Mi raccomando non distrarti da me! Ho bisogno dite, senza te non vivo!”. Lo fa, ripeto, perché programmato per farlo. Non sa probabilmente fare altro, ma questo gli riesce davvero bene!
Cosa deve fare allora un genitore per essere un bravo genitore?
Semplicemente rispondere con il suo naturale amore, che si tradurrà in “adeguate cure parentali” come risposta alle richieste e ai bisogni del bambino. E’sicuramente molto impegnativo e faticoso, ma il “cosa” fare è tutto qui. Per le “regole”, sicuramente importanti, ci sarà tempo….
Invece il “come” fare non ce lo può insegnare davvero nessuno, ce l’abbiamo già dentro di noi. Credo che una volta stampati bene in mente quei pochi fondamentali passaggi di cui sopra, il più è fatto. Il come tradurre tali concetti (scientifici) in strategie genitoriali è a vostra libera espressione.
S. Agostino diceva “Ama e fai quello che vuoi”: ebbene, amate incondizionatamente i vostri piccoli bambini, fate quello che vi sentite di fare, il “come” farlo sta a voi. Ognuno di noi, infatti, ogni bambino, ogni relazione genitori-figli rappresenta una realtà unica e irripetibile.
Per i consigli legati alla nutrizione, alle malattie dell’infanzia, più in generale per tutto ciò che concerne l’aspetto “fisico-organico” del bambino è giusto rivolgersi ad un medico-pediatra, ma per tutto quanto concerne la “vostra” relazione con il “vostro” bambino…fate vobis!
Anche il genitore infatti, come abbiamo visto, è programmato geneticamente per reagire alle richieste infantili. Addirittura nella neo-mamma si innalza l’ossitocina, il cosiddetto “ormone dell’amore” o delle “coccole”, segno evidente che il nostro stesso corpo ci “suggerisce” di empatizzare di più con il nostro piccolo, di entrare in una “sintonizzazione affettiva” (D. Stern, 1971) con i suoi bisogni, perché di questo lui ha bisogno nei primi mesi di vita.
Benché ancora senza l’utilizzo del linguaggio, dunque, il bambino comunica a livello non verbale con i propri genitori e questi fanno lo stesso con lui, innescando una sorta di “valzer” che i due ballano insieme (Stern, 1985). La madre, anche lei, è “programmata” per rispondere adeguatamente ai segnali e agli stimoli inviati da suo figlio.
Possiamo riassumere la genitorialità in due grandi funzioni:
1)Massima protezione e cura nei primi anni di vita del bambino;
2)Massima spinta all’ esplorazione, alla socialità e all’autonomia dopo.
Inutile dire che troppo spesso avviene esattamente il contrario: massimo distacco nei primi anni di vita del bambino, massima resistenza all’indipendenza del figlio ormai cresciuto.
Dunque possiamo affermare che la genitorialità altro non è che l’ “accudimento” del bambino in risposta al suo bisogno di “attaccamento”. In quest’ottica è evidente come la genitorialità non sia altro che un DARE, un DARE INCONDIZIONATO, senza chiedere nulla in cambio.
Riallacciandomi al messaggio montessoriano del guardare al bambino con “venerazione”e all’invito provocatorio di M. R. Parsi, che sottolinea la necessità di inserire un altro comandamento tra i dieci conosciuti e cioè “Onora il figlio e la figlia”, voglio concludere con una bellissima frase di J. Korczack, pediatra che subì il trauma della deportazione nei campi di sterminio nazisti e che fondò nel secolo scorso la “Casa degli Orfani”:
“Dite: è faticoso frequentare bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli”.
(J. Korczack)
Bibliografia
Albani R., Si fa come dico io, Marco Tropea Editore, Milano, 2011
Angelo P., Da zero a tre anni, Mondadori, Milano, 2000.
Balsamo E., Bambini immigrati e bisogni insoddisfatti: la via dell’etnopediatria, in: La casa di tutti i colori, Mille modi di crescere, Franco Angeli, Milano, 2002.
Bowlby J. (1969), Attaccamento e perdita, 1: L’attaccamento alla madre (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Bowlby J. (1982), Attaccamento e perdita, 2: La separazione dalla madre (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
Bowlby J. (1980), Attaccamento e perdita, 3: La perdita della madre (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 2000.
Costantini A., Freud. La grande menzogna sull’infanzia, Kappa, Roma, in corso di pubblicazione.
Estivill E., de Bèjar Sylvia (1996), Fate la nanna (tr. it.), Mandragora, Firenze, 1999.
Gerhardt S. (2004), Perché si devono amare i bambini, Cortina, Milano, 2006.
Harlow H. (1958), The Nature of Love, Am. Psychol Vol. 13, 673-85, in Bowlby J. (1969). Attaccamento e perdita1: L’attaccamento alla madre (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Hunziker A., Barr R.G. , Increased Carrying Reduces Infant Crying: A Randomized Controlled Trial in “Pediatrics”, Vol. 77 No. 5 May 1986, pp.641-648.
Lorenz K (1949 ), L’anello di Re Salomone (tr. It.), Adelphi, Milano, 1989
Miller A. (1980), La persecuzione del bambino. Le radici della violenza (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 1987.
Morris D. (1991), Il bambino. Tutti i perché (tr. it.), Mondadori, Milano, 1993.
Parsi M. R., Onora il figlio e la figlia, Salani Editore, Milani, 2006.
Ricci L., Fate i bravi! (0-3 anni), Rizzoli, Milano, 2009.
Sarti P., Facciamola finita!, Mandragora, Firenze, 2011.
Schreber D. G. M., L’educazione totale (tr. it.), Biblioteca Biographica Treccani, Roma, 1981.
Stern D. N. (1985), Il mondo interpersonale del bambino (tr. it.), Bollati Boringhieri, Torino, 1987.
Stern D. N. (1990), Diario di un bambino (tr. it.), Mondadori, Milano, 1991.
Stern D. N. (1971), Le interazioni madre bambino (tr. it.), Raffaello Cortina, Milano, 1998.
Sunderland M., Panksepp J.,The Science of Parenting: Practical Guidance on Sleep, Crying, Play, and Emotional Well-Being for Life, DK Publishing, London, 2006..
Weber E., Portare i piccoli, Il leone verde, Torino, 2007.
Winnicott D., I bambini e le loro madri, Cortina, Milano, 1987.
Alessandro Costantini
Psicoterapeuta APDP
Consiglio Direttivo Movimento per l’Infanzia