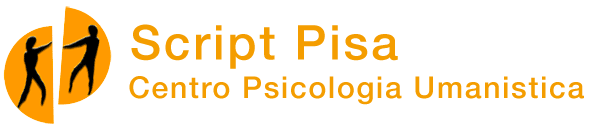Le teorie della personalità, gli orientamenti psicoterapeutici e le pratiche conseguenti hanno raggiunto numeri e conseguenti differenziazioni considerevoli.
I diversi paradigmi, dai “maggiori” ai “minori”, si esprimono generalmente attraverso contenuti di natura metaforica (inconscio, Sé, Io, Superio, stati dell’Io…) e ottengono una validazione teorica rispetto alla coerenza interna di ogni particolare “visione della cura”.
I punti di partenza sono comunque costituiti da postulati indimostrabili, ritenuti indispensabili appunto all’interno di un sistema di conseguenze e riferimenti che si costituiscono necessariamente sul postulato stesso.
Invalidato il postulato, come una cascata a domino, viene falsificata la costruzione teorica, o per interno o in alcune sue parti.
E così, dalle sorgenti teoriche originarie, si generano i “neo…”, in un processo all’infinito.
In alcune situazioni, che mostrano le loro caratteristiche culturali nella manipolazione culturale del momento, le teorie diventano ideologie, cioè un insieme di binari principali di un orientamento, scientifico, filosofico o altro, nettamente strumentale, di natura politica o similare, che nulla ha a che fare con la libera ricerca e la coerenza interna del sistema stesso (ad esempio la genetica in Unione Sovietica ai tempi di Lysenko, la fisiognomica lombrosiana, la teoria della superiorità di una razza su di un’altra, ecc…).
Le mille teorie non sono certo l’epoca dei “cento fiori” e tanto meno le idelogie, nella loro rigidezza strumentale, sono l’humus migliore della “cura”.
Ma le mille teorie esistono e compito di chi opera sul campo è, quanto meno, la loro conoscenza.
Questa lunga premessa per presentare l’articolo di fondo di questo numero, scritto dallo psicoanalista Alberto Lorenzini: un percorso che fotografa la psicoanalisi dalle origini “pulsionali” freudiane fino ad arrivare alla psicologia del Sé, di matrice kouthiana.
È il terzo di fondamentali articoli di fondo già pubblicati: i rapporti fra psicoanalisi ed analisi transazionale (Michele Novellino, Psico-analisi transazionale, “Script riflessioni”, n. 4) e la teoria centrata sulla persona (Rogers e Raskin, La psicoterapia centrata sulla persona, “Script riflessioni”, n. 7).
I prossimi numeri vedranno l’illustrazione di altre impostazioni teoriche.
Rogers è di nuovo presente, con un lavoro riassuntivo e sintetico dell’amica e collega Simona Balestra sulla teoria della personalità secondo Carl Rogers: un paradigma che deve molto alla biologia e alle scienze naturali e che, almeno nella pubblicistica di lingua italiana, è stato spesso trascurato, in favore di una vulgata semplicistica.
Le artiterapie, che presto vedranno una sezione apposita in questa “picciola” rivista, in questo numero sono rappresentate dagli appunti all’interno del viaggio congressuale di Cascina, cioè il convegno nazionale di teatroterapia, dal titolo emblematico “Teatro in terapia?“. Nei prossimi numeri ci ripromettiamo di pubblicare almeno estratti più significativi e con caratteristiche di completezza, derivati dagli atti ufficiali del convegno, in via di pubblicazione in altra sede. Con questo percorso pensiamo di approfondire, per passi successivi, la conoscenza di un’attività di gruppo (in questo caso teatroterapia) molto diffusa, anche in ambiti terapeutici complessi come la psichiatria.
Nelle sezione “Sceneggiature della psiche” l’attenzione è per il film di Ferzan Ospetek “La finestra di fronte“.
Il breve articolo si inserisce nel filone dell’analisi della memoria, iniziato col racconto del viaggio nei Balcani (Giovanni Lancellotti, “Viaggio attraverso i Balcani. Camminando sui campi di asfodeli”, “Script riflessioni”, n. 6), perché pensiamo che, anche nell’ambito terapeutico (nella ricerca dei propri significati, dell’individuazione junghiana), l’elaborazione della memoria come lievito del futuro (senza passato non c’è futuro) sia un tratto essenziale sia degli individui che dei gruppi. Falsamente progressive sono le palingenesi che non si riappropriano del passato, dello stadio del “bruco”, e che promettono “farfalle” qui ed ora. Spesso tali impostazioni sono il prodromo di una dimensione di sé comunque violenta, che è l’esatto contrario di ogni principio psicologico in ambito umanistico.
La recensione del libro di Watzlawick chiude questo numero. “Il linguaggio del cambiamento” ci porta repentinamente in medias res psicoterapeutiche.
La domanda del libro sembra essere: “Quali sono le parole per dirlo”, riferita naturalmente alla psicoterapia.
Parafrasando indebitamente Lacan, se possiamo conoscere soltanto attraverso il linguaggio, ecco che la cura psicoterapeutica non può essere altro che “il linguaggio che cura”.
Con un occhio alle neuroscienze ed uno alla psicologia del linguaggio, Watzlawick ci permette di entrare nel mondo analogico della metafora e delle figure retoriche essenziali, per aprire una breccia, per fornire un insight all’interno del colloquio psicoterapeutico.
Giovanni Lancellotti psicologo-psicoterapeuta