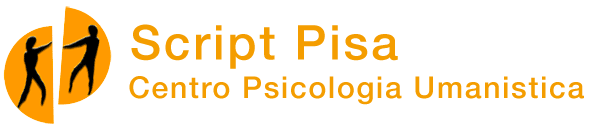Dopo lunga attesa, la montagna ha partorito qualcosa più di un topolino. Questo numero di Script esce dopo una pausa di due anni, ma in compenso si presenta piuttosto ricco di contenuti.
Proponiamo come articolo di fondo la Lettera agli insegnanti italiani che James Hillman lesse a Milano nell’aprile del 2002 e che fu poi pubblicata negli Atti del Primo meeting internazionale della Fondazione Liberal (1). Pensiamo che, a distanza di tredici anni, questo breve scritto sia oggi ancora molto attuale. Preoccupazione fondamentale dell’autore, famoso allievo di Jung, è che la formazione e la crescita culturale dei giovani debba essere parte del loro processo individuativo e, pertanto, rispettosa di percorsi esperienziali individuali, diversi da persona a persona. Hillman ha studiato a fondo la mitologia ed è convinto che essa non costituisca un fenomeno tipico delle società antiche, da relegare nel passato. Anche noi abbiamo le nostre mitologie, ma facciamo fatica a rendercene conto, perché ci siamo dentro e ne siamo condizionati. Se non vediamo la mitologia in cui siamo immersi, è perché ci troviamo nella stessa condizione di un pesce che non vede l’acqua in cui nuota. Attualmente, la mitologia più insidiosa – quella che, secondo Hillman si configura come rischio di un nuovo totalitarismo – è rappresentata dall’ultima versione del “prometeismo” tipico dell’Occidente, che si estende ormai a tutto il pianeta. Si potrebbe dire che essa consiste nel culto di “una soluzione per ogni male” (la vittoria del bene sul male, per collegarci alla critica di American Sniper, a cura di Giovanni Lancellotti, su questo stesso numero), un estremo trionfo del positivismo che si insinua in ogni settore della nostra vita, principalmente sotto forma di egemonia della logica aziendale. Sotto i nostri occhi che non vedono, la logica aziendale inserisce progressivamente il suo principale valore, rappresentato dal denaro, accompagnato dai suoi “derivati tossici”, pragmatismo, competizione e marketing, al posto dei precedenti valori di ogni tradizione culturale. Nella scuola italiana i valori che sono progressivamente relegati a svolgere un ruolo minoritario, di significato sempre più trascurabile, sono anzitutto quelli umanistici che appartengono/appartenevano alla nostra tradizione culturale plurisecolare. Credo che Hillman avesse voluto parlare agli insegnanti italiani, perché identificava nella nostra tradizione culturale l’eredità del Rinascimento e della cultura classica, che lui aveva ampiamente utilizzato come base della propria “psicologia archetipica”.
Vengono di seguito gli articoli per la rubrica “Contributi alla cultura della psicoterapia”.
Giuseppe D’Amore ci presenta il suo nuovo lavoro, dedicato ai problemi dell’adozione, materia di cui si occupa da molto tempo. Il suo discorso si concentra su un equivoco insidioso e decisivo che rischia spesso di rendere ancora più difficile e gravoso un compito già difficile di per sé: l’incontro e la reciproca comprensione tra figli e genitori adottivi. I genitori vorrebbero che i figli adottivi fossero, per così dire, “senz’anima”, cioè senza un’anima precedentemente formatasi nelle loro vicissitudini di vita, pre-esistenti all’adozione. Per questo portano così spesso il desiderio di ricevere un neonato e non un bambino più grandicello, nella speranza che il neonato possa magicamente nascere, in un certo senso, proprio nell’incontro con loro. In quel modo egli sarebbe totalmente recettivo verso le loro aspettative e li confermerebbe senza riserve nel ruolo, consentendo loro di dimenticare il dolore di essere infertili o, per qualche altro motivo, mancanti non solo di figli, ma anche di una parte di sé, o di una parte dell’immagine di sé. Molto saggiamente, l’autore propone ai genitori di orientarsi verso un diverso target relazionale: essere “chi si prende cura di”, piuttosto che immediatamente genitori. La genitorialità, in questi casi, non può essere data per scontata, ma è tutta da costruire. La nostra impressione è che questi consigli valgano altrettanto bene per tutti i genitori e non solo per quelli adottivi, nella misura in cui ci riconosciamo non solo come esseri di natura, ma anche come esseri di cultura.
Tiziano Carbone ci parla della coscienza nella prospettiva logica dei sistemi complessi. Da questo punto di vista, la coscienza non è qualcosa che si affaccia sulla realtà delle cose, a partire da una dimensione diversa dalla realtà delle cose, come vorrebbe la tradizione cartesiana che contrappone res cogitans a res extensa. Siamo rimasti molto colpiti dalla sua affermazione: “ritengo che la realtà esista e che le nostre rappresentazioni non possano essere mai totalmente avulse da essa, perché anche noi ne facciamo parte, e le nostre rappresentazioni sono una espressione fenomenologica emergente della nostra interazione globale con l’ambente in cui evolviamo”. Alberto Lorenzini è dell’opinione che la coscienza rappresenti una forma particolare d’interazione con l’ambiente, emersa da una forma d’interazione precedente. La forma precedente è quella che Bateson chiamò “danza relazionale”, la danza che l’ape fa con il fiore e con il sole, la preda con il predatore, il cucciolo e il bambino con tutto ciò che trovano, quando sono assorbiti e persi nel gioco. Il titolo che Tiziano ha dato al suo scritto ci pare particolarmente appropriato: altro non c’è, se non proprio il senso di meraviglia, davanti a ciò che scaturisce dal gioco, e la coscienza è la cosa più incredibile che scaturisce, quando a giocare sia un animale sufficientemente evoluto.
Fabio Rapisarda rivisita il mito fondamentale della psicoanalisi freudiana, il complesso d’Edipo, riassumendo diversi autorevoli punti di vista che si sono succeduti sull’argomento nel corso del tempo e privilegiando una lettura in chiave relazionale.
Alberto Lorenzini ci parla del peccato originale in termini piuttosto sorprendenti e nuovi, per quanto si mantenga fondamentalmente in accordo con l’ortodossia che vede in quel peccato l’orgogliosa presunzione di un’identificazione con Dio. Il significato psicologico del mito consiste nella scoperta esaltante di poter accedere, attraverso il linguaggio, a metafore di ordine superiore, distanti dall’esperienza e capaci di manipolare l’esperienza. Il risultato di quell’antico imbroglio dilaga attraverso i secoli e i millenni della storia umana, in maniera apparentemente inarrestabile. Oggi si presenta nei mille diversi modi, attraverso i quali l’apparenza conta più della realtà delle cose e la mappa, per dirla con Bateson, ci appare più interessante e reale del territorio che descrive.
La rubrica “Magmatica” ospita un curioso lavoro che l’autore anonimo ci spiega essere un prodotto del suo inconscio, più che del suo io cosciente. In forma di tragedia classica e, in un certo senso “involontariamente” egli ha rappresentato le dinamiche familiari dalle quali si sente intrappolato. “Il testo da me vagheggiato ha cominciato prepotentemente a scriversi da solo nella mia testa, e mi sono visto costretto, da una peculiare e a me ben nota forma di compulsione, a metterlo per iscritto. Nel corso della stesura il testo si è trasformato, vivendo di vita propria, senza chiedermi il permesso e nemmeno un parere, in un grottesco teatrino che vedeva per protagoniste le caricature mie, dei miei familiari e delle dinamiche che tra noi abitualmente s’intrecciano”. Per questo motivo, riconoscendo come autore il proprio inconscio, piuttosto che l’io conscio, l’autore ha preferito mantenere la propria identità nell’ombra e rimanere anonimo.
Eleonora Aquilini, per la rubrica “Psicologia, Scuola, Formazione” ci fa entrare in classe e ci presenta uno strano miracolo di attenzione e di meraviglia, ricompensa meritata e, tuttavia, inaspettata di un percorso scolastico fatto di competenza professionale e di empatia nel rapporto con gli allievi. Le “facce stanche che implorano pietà, [gli] occhi che guardano e non vedono, [i] corpi semisdraiati sui banchi e [il] chiacchiericcio scomposto” dell’ultima ora si ricompongono di fronte alla meraviglia di poter riassumere un lungo percorso esperienziale nella sintesi di una formula matematica: “Ma… questa è una ganzata!”
La rubrica “Poesie” ospita i versi di Giuliana Mussa Jacob, una collega che si occupa con particolare sensibilità e competenza di donne vittime di violenza e di abuso. Si tratta di alcune poesie (si potrebbe anche dire “psicopoesie”) che sono tratte dal suo libro, fresco di stampa: Pelle di filigrana (Aletti Editore, 2015).
Giovanni Lancellotti, per la rubrica “Sceneggiature della psiche, psicologia e cinema” legge il film di Clint Eastwood “American Sniper”, la storia del cecchino Chris Kyle (interpretato dall’attore Bradley Cooper), membro del corpo militare americano dei Navy Seal e protagonista di diverse missioni in Irak e in Afghanistan. Più voci hanno accusato Eastwood di aver girato un film di sottile propaganda patriottica, analogo, anche se molto più “intelligente”, alla serialità di guerra che seguì, negli anni Cinquanta, l’impresa di Corea. Noi siamo invece dell’opinione che il film rappresenti una vera “saison en enfer”, una descrizione cinematografica che si può leggere come i dipinti di Goya “los desastres de la guerra”. Non ci sono né vincitori né vinti, come nella realtà dei due campi di guerra, ma “l’America che uccide se stessa”, come ebbe a dire il poeta russo Evtushenko, a proposito dell’assassinio di John Kennedy.
La rubrica “Un vasto campo, psicologia e società”, curata, per questo numero della rivista da Giovanni Lancellotti, ci porta alla lettura di due articoli con differenti contenuti: “Noi siamo Farkhunda” di Giuliano Battiston e “Addicted” di Gabriele Battaglia, entrambi pubblicati su “Il manifesto quotidiano”. Ringraziamo la Redazione per la cortese autorizzazione alla pubblicazione di entrambi gli articoli, ulteriore manifestazione nei nostri confronti di aver maggior interesse alla diffusione della cultura che a detenerne il monopolio.
“Noi siamo Farkhunda” ci introduce nel campo, poco studiato dalla psicologia, del fanatismo religioso. L’articolo tratta dell’assassinio della ragazza ventisettenne Farkhunda Madikzadah, afghana, uccisa da una folla inferocita perché accusata di aver bruciato il Corano davanti ad una moschea. Accusa rivelatasi, in seguito alle indagini di polizia, falsa. Il campo in cui ci introduce l’autore, quello del fanatismo religioso, appunto, ci rimanda alla voce di Voltaire sul suo Dizionario Filosofico, da cui traiamo alcune affermazioni:
“…Chi sostiene la propria follia con l’omicidio è un fanatico…Una volta che il fanatismo ha incancrenito il cervello, la malattia è quasi incurabile…Le leggi non bastano contro questa peste degli animi; la religione, invece di essere per loro un alimento salutare, si tramuta in veleno nei cervelli infetti…Quella gente è persuasa che lo spirito santo che li pervade stia al di sopra delle leggi, e che il loro fanatismo sia la sola legge cui debbano ubbidire…Che cosa rispondere a un uomo il quale vi dice che preferisce ubbidire a Dio che agli uomini e che, di conseguenza, è sicuro di meritare il cielo sgozzandovi?… Se la nostra santa religione è stata tanto spesso corrotta da questo furore infernale, bisogna prendersela con la pazzia degli uomini…” (2).
Addicted tratta di tutt’altro argomento, della dipendenza da Internet, o comunque da attività correlata al computer dei giovani cinesi e della cura di un comportamento che è stato giudicato patologico. Si tratta di una strana comunità di recupero in cui si incrociano tecniche di natura comportamentale, come si riscontravano in tutto il mondo occidentale, all’inizio della presa in carico delle tossicodipendenze, con usi pedagogici in una realtà tutta cinese, “confuciana”, caratterizzata da una auspicabile armonia che nulla lascia alla spontaneità, ma che è diretta centralmente e viene considerata un argine ad un’anarchia temuta come disgregatrice. Qualcosa di simile, ma con molta meno violenza, ai campi di rieducazione degli elementi antisociali durante il regime maoista, anche se il paragone è più di curiosità intellettuale che di indicazione reale di riferimento.
La rubrica “Rogers contemporaneo” vede il lungo scritto di Stefano Fratini: “Approccio Centrato sulla Persona e malattia cronica”. Esperienze di diabetologia. Vent’anni in prospettiva. 1994-2014”. Si tratta del resoconto di un lavoro durato a lungo che vede la presenza di un’attività psicoterapeutica all’interno di un gruppo di persone ammalate di diabete. Al di là della malattia specifica, si tratta di una condizione sempre più diffusa, quella della sofferenza prolungata, che dura tutta una vita, caratterizzata da limitazioni o da dolore fisico (penso al vissuto del dolore cronico benigno) e, di solito, alla progressività e all’aggravamento dei sintomi. Sono situazioni che fino ad ora non hanno avuto l’attenzione psicologica dovuta. L’articolo di Fratini è un fondamentale stimolo di conoscenza in questo campo. Ringraziamo la rivista di studi rogersiani “Da Persona a Persona” per la gentile concessione alla pubblicazione dello scritto di Stefano Fratini.
Fragmenta, in questo numero a cura di Giovanni Lancellotti, è un insieme di lacerti tratti da letture disordinate, anche se non certamente “matte e disperatissime”, impressioni molto forti al momento, che possono rimanere inesplorate o rivelarsi fonti di approfondimento. Di per sé sono “nugae” (cose di poco conto, bagatelle, scritti senza importanza), come chiamava Catullo le poesie che considerava meno solenni (ma che non erano affatto “nugae)”: Le nugae di Fragmenta invece sì, lo sono per davvero.
La rubrica “Recensioni, riflessioni sulla scrittura” si presenta da sé, con l’analisi delle due opere in questione. Ringraziamo la redazione di “Il manifesto quotidiano” che ci ha autorizzato a pubblicare la recensione di Renato Foschi al libro di ALLEN FRANCES. Primo non curare chi è normale. Contro l’invenzione delle malattie. Bollati Boringhieri 2015.
Di seguito abbiamo la recensione di Pietro Pellegrini al libro di FABIO VANNI. La consultazione psicologica con l’adolescente. Franco Angeli, 2014.
Giovanni Lancellotti (Script) giovannilance@alice.it
Alberto Lorenzini (Script) alberto.lorenzini@gmail.com
Note:
1 www.edscuola.it/archivio/ped/hillman.htm
2 Ed è di questa “pazzia degli uomini” che vorremmo incominciare a parlare, non tanto perché sia un terreno vergine (della follia che albergava nella repressione dei campi di sterminio nazisti se n’è molto scritto), ma perché, ad esempio, non c’è ancora una definizione condivisa di che cosa sia il fanatismo religioso e dove si trovino esattamente le sue radici. Navigando sul web, immettendo nei canali di ricerca l’espressione “fanatismo religioso criminale” ci siamo imbattuti nel sito dell’ UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) e, precisamente nello scritto intitolato “Patologie indotte dalla religione”, a firma Francesco D’Alpa, di cui riportiamo la parte iniziale, che ci sembra molto significativa:
“Nel momento in cui lo abbiamo scelto, il tema monografico di questo numero de L’Ateo ci sembrava abbastanza autoesplicativo: “Religiopatie”, ovvero psicopatie e sociopatie a carattere primitivamente religioso, e dunque indotte da ogni particolare religione.
Un inevitabile giro di orizzonte (innanzitutto sul WEB, come oramai è quasi d’obbligo) ha tuttavia prodotto un risultato sorprendente: il termine, che sembrava del tutto ovvio, anche se declinato nelle principali lingue, è quasi inesistente. Non lo si trova nei dizionari e non lo si trova nelle enciclopedie. Lo riporta, come proposto neologismo, quasi solo la “Conscienciclopédia” (“Enciclopédia Digital da Conscienciologia”), con la seguente definizione “Parapatologia della coscienza causata dalla religione e dai suoi dogmi” ed i relativi sinonimi “Infermità religiosa”, “Gurulatria”, “Filosofia della credenza”, “Virus della religione” (http://pt.conscienciopedia.org).
Fra il poco recuperabile su Internet, troviamo alcune interessanti definizioni proposte da un utente (che si presenta con lo pseudonimo di Jak Tak e ritiene impropriamente di avere coniato il termine nel 2011): “Religiopatia: disordine della personalità caratterizzato da mancanza di coscienza morale, per il quale un individuo utilizza le proprie credenze religiose per creare un’illusione di giustizia o innocenza; condizione sociale caratterizzata da atti immorali ed antisociali compiuti per guadagno o per gratificazione personale adoperando la religione come giustificazione”; “Religiopatico: persona senza coscienza morale che usa la religione come giustificazione per comportamenti antisociali; […] una persona che usa il balbettio religioso per rappresentare falsamente se stessa come onesta; un ipocrita religioso; un sociopatico che usa la religione per giustificare il proprio comportamento sociopatico”(http://humalution.blogspot.it/2011/11/humalution-dictionary.html).
Nel prossimo numero della rivista ci ripromettiamo di approfondire la questione, innanzi tutto con la lettura puntuale di alcune opere che ci introdurranno alla tematica. Si tratta di Robert Hare. La psicopatia. Astrolabio, 2009 (un’esaustiva panoramica su aspetti della psicopatia correlati all’individuo), di Françoise Sironi. Violenze collettive, saggio di psicologia geopolitica clinica. Feltrinelli 2010 (il sottotitolo ci indirizza ad una attenzione alle violenze di natura collettiva, politica) e di Francesco Stoppa. L’offerta al dio oscuro. Il secolo dell’olocausto e la psicoanalisi. FrancoAngeli, 2002. Sollecitati da una recente ennesima visione del film di Pier Paolo Pasolini “Salò o le 120 giornate di Sodoma” ci proponiamo un’approfondita riflessione sul sadismo e su quanto questo sia favorito da particolari situazioni politiche o sociali.