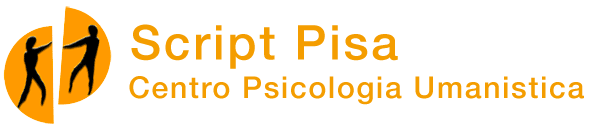Riflessioni sul film dopo l’anteprima
 Parlando di Rino Zena, protagonista scomodo del suo ultimo film, Gabriele Salvatores sa essere molto efficace: “Odio tutto quello che dice, ma gli invidio la capacità di amare suo figlio”.
Parlando di Rino Zena, protagonista scomodo del suo ultimo film, Gabriele Salvatores sa essere molto efficace: “Odio tutto quello che dice, ma gli invidio la capacità di amare suo figlio”.
Rino è violento, razzista, ostile verso la società che lo esclude, e soprattutto colpevole per ciò che insegna al figlio: una logica che non conosce il ragionamento, né tanto meno la persuasione, fatta di idee rabbiose su come va il mondo e su come guadagnarsi il proprio posto, a forza. Regola numero uno del suo codice morale trasmesso con esaltata passione: far sempre più male di quanto se ne possa ricevere.
Disoccupato, alcolista, inaffidabile: non si sa come Rino riesca a mantenere la famiglia, formata da lui e dal suo ragazzo, Cristiano. Eppure, nella miseria della loro casa, sembra quasi impossibile, si respira un’affettività inaspettata.
Proprio lì, dove anche le lenzuola sono un lusso e l’ospite più assiduo è l’assistente sociale; in stanze che esalano l’odore di polvere e di fumo stantio, mentre la pioggia si accanisce sulle finestre sempre chiuse; nei locali opachi dove l’enorme svastica alle pareti è l’unico ornamento, insieme alle lattine vuote di birra che fanno da soprammobili.
In una delle prime scene del film, padre e figlio lottano, di mattina presto, sul letto; sembrano spensierati, ma poco prima, ancora al buio, il ragazzo ha ucciso il cane dei vicini che ha osato interrompere il sonno paterno. Dovremmo odiarlo questo pessimo padre, cattivo maestro che insiste con le lezioni di falsa sopravvivenza e il disprezzo verso tutti, sotto lo sguardo perso, interrogativo, preoccupato e al tempo stesso adorante, del figlio adolescente.
 Ma davanti al gioco dei corpi, alla confidenza, al sorriso felice di Cristiano, non possiamo odiare. Anzi, facciamo nostre le emozioni di Salvatores: non c’è una sola cosa nei gesti e nei discorsi di Rino che potremmo perdonare, ma il suo amore per Cristiano e la loro relazione sono intensi al punto da toccare le corde più intime.
Ma davanti al gioco dei corpi, alla confidenza, al sorriso felice di Cristiano, non possiamo odiare. Anzi, facciamo nostre le emozioni di Salvatores: non c’è una sola cosa nei gesti e nei discorsi di Rino che potremmo perdonare, ma il suo amore per Cristiano e la loro relazione sono intensi al punto da toccare le corde più intime.
La profondità di questa intesa ci viene svelata da Filippo Timi, lui così buono, così dolce, così arrendevole, ora nel suo primo ruolo da cattivo; è stato liberatorio, ci dice, ma sulla parola liberatorio inciampa, proprio su quella, e dopo aver pronunciato li-li-liberatorio, con la sua tenera auto-ironia chiarisce: “liberatorio, tutto attaccato!”.
Alcuni di noi lo hanno visto la prima volta nelle interviste pacate e distese delle Invasioni barbariche, quando ha esordito dicendo: “Io sono balbuziente”.
E se il parlare lo tradiva, a riprova che le sue difficoltà non sono un vezzo, lui aggiungeva subito dopo che la parola è tutta unita. Il pubblico ride quando Filippo Timi parla, perché le lezioni di naturalezza (conquistata, si può intuire, a caro prezzo) sono rare nella vita e portano sempre con loro il piacere di un dono.
Dopo la proiezione di Come Dio comanda, ha parlato lui per primo della figura paterna, dicendoci quanto sia stato importante essere nel film un padre amorevole, se pure inacidito dalle delusioni. Quel ruolo gli ha fatto capire di più suo padre, e i suoi silenzi: “forse ha spesso taciuto per paura, non per il poco ma per il troppo che vorrebbe dire”.
Poi, quando sembra averci convinti, aggiunge; “Chissà cosa dirà dopo aver visto il film! Forse niente, come al solito” e il pubblico ride. E ride anche quando, incespicando su alcune parole con la lettera p, proprio mentre sta parlando di padri, Filippo Timi dice divertito: “Ho qualche difficoltà con la lettera P”!. E’ incredibile con quanta leggerezza sappia sfiorare il tema del rapporto col padre e quello del desiderio di un’intimità a lungo negata!
Tanto delicato è l’attore, tanto il suo personaggio è oltre modo rude, un individuo che ha fallito nella vita e nei valori; ma un padre che non rinuncia al suo dovere, quello di educare, se pure inteso in maniera così distorta.
“La crisi del maschile”, commenta Salvatores, “è stato un alibi per la fuga, un modo per guadagnare l’uscita di sicurezza”, e invece è importante che il padre sia presente a far rispettare le regole; sottrarsi a questo ruolo significa non educare, una forma di disamore, tristemente travestito da moderna liberalità.
Per i figli le conseguenze dell’assenza di divieti possono essere drammatiche. In Genitori che amano troppo Caroline Thompson sostiene che negare ai bambini le frustrazioni non evita il conflitto, se mai lo sposta; non più quindi tra soggetto e oggetto esterno (il genitore) ma tra sé e sé, un dissidio intrapsichico insostenibile al quale si può sfuggire solo strutturando una personalità narcisistica.
Anche Gustavo Pietropolli Charmet, nel suo recente Fragile e spavaldo, parla di un senso di colpa ormai sostituito dalle patologie narcisistiche. L’individuo centrato solo su di sé “ha continuamente bisogno di essere rassicurato da qualcuno o qualcosa di esterno, e la sua insicurezza di fondo può manifestarsi attraverso un sentimento di onnipotenza, un’intolleranza alla frustrazione o un’autosufficienza ostentata, senza alcuna empatia per il mondo che lo circonda”. E non è certo un danno di poco conto.
“Oggi il padre, nell’esperienza del maschio, tende ad essere una figura del tutto irrilevante” teorizza Claudio Risé (Il maschio selvatico). “Per la prima volta nella storia dell’umanità, il giovane maschio non è più iniziato alla vita da altri maschi. Conseguenze: una profonda insicurezza, una perdita di contatto con l’ istinto maschile e quindi con i propri desideri, un’abulia nell’immaginare, nel progettare la propria vita, spesso coperta da un maniacale attivismo che cerca di nascondere il vuoto e l’angoscia”. E anche questi non sono danni da poco.
Ancora Charmet, per fortuna, in Un nuovo padre sostiene che però negli ultimi anni la figura paterna è stata più presente. Esauriti i tempi dell’uccisione simbolica, sostituita da un lungo processo di elaborazione pacifica, al padre si può affidare con fiducia la gestione del potere contrattuale (che non è più l’autorità della tradizione, né tanto meno l’assurdo delegare degli ultimi decenni).
E soprattutto è sua la responsabilità di promuovere, garantire e facilitare il processo di separazione dalla madre, nella quale si perpetua la tenacia di Herzeloyde (la madre di Parsifal) disposta a tutto pur di non far allontanare il figlio adorato.
Ma in questa storia non ci sono madri, non ci sono donne. Persino l’assistente sociale è un uomo, contrariamente a come siamo abituati nella vita, nella letteratura e nel cinema.
L’assenza di ogni figura femminile rende la relazione ancora più esclusiva: nessuna mediazione, nessun confronto. Nessuna diversità, che potrebbe essere solo un’intrusione nel rapporto simbiotico padre-figlio. Relazione malata, certo, ma è l’unica risposta possibile al nulla, ad un vuoto affettivo intollerabile.
Rino e Cristiano temono che l’assistente sociale, stupito e impotente davanti a queste due vite alla deriva, possa da un momento all’altro separarli: sarebbe davvero il passaggio dalla profonda solitudine alla più cupa disperazione.
 Solo una persona può avvicinarsi a loro con affetto e a lui solo è riservata una sorta di benevolenza; è l’amico Quattro Formaggi, un derelitto che ha perso la ragione dopo un incidente sul lavoro. E’ sempre con loro, quasi a costituire una famiglia davvero singolare; quando è solo, si muove impacciato in una stanza tutta occupata dal suo presepe. Parla con le statuette e le mette in relazione tra loro, o amoreggia ossessivamente attraverso il video con il volto di una porno star.
Solo una persona può avvicinarsi a loro con affetto e a lui solo è riservata una sorta di benevolenza; è l’amico Quattro Formaggi, un derelitto che ha perso la ragione dopo un incidente sul lavoro. E’ sempre con loro, quasi a costituire una famiglia davvero singolare; quando è solo, si muove impacciato in una stanza tutta occupata dal suo presepe. Parla con le statuette e le mette in relazione tra loro, o amoreggia ossessivamente attraverso il video con il volto di una porno star.
Quattro Formaggi è il matto tante volte incontrato nella letteratura. Ci sono parecchi elementi shakespeariani in questo film: il re, il giovane principe e anche il folle, oltre alla tempesta nel bosco. Piove sempre durante la narrazione, ma è un’acqua che non ripulisce l’anima, né i luoghi; anzi, ci affonda sempre più nel fango, fino agli eventi assurdamente drammatici che nella foresta si consumano.
La notte, il buio, le ombre, la parte sommersa che sonnecchia nel nostro inconscio, l’incontro con i mostri che albergano in ognuno: tutto diventa realtà o forse no. Tutto può essere vissuto come sogno, uno di quegli incubi da cui sembra impossibile liberarsi.
Avventura, anzi disavventura onirica. A tratti vorremmo che le luci si riaccendessero e il rumore della pioggia la smettesse di farci soffrire. E’ una storia davvero molesta, una tragedia greca consumata nel Nord Italia, con abitazioni tutte uguali, centri commerciali anonimi, cave di pietra e il greto immenso di un fiume carsico che anche quello scorre sotterraneo, come le nostre segrete pulsioni, momenti di piena a parte.
Margherita Fratantonio è nata a Ravenna, ma ha vissuto anche in Sicilia e molti anni a Milano. Abita ora a Gornate Olona, un piccolo paese sulle colline di Varese, e insegna materie letterarie all’Istituto L. Geymonat di Tradate.
E’ specializzata in Counseling presso il CSTG di Milano (Cento Studi Terapia della Gestalt); iscritta alla Società Italiana di Counseling (S.I.Co). Ha frequentato un master in conduzione di gruppi secondo i Metodi d’Azione e Psicodramma.
Esercita il Counseling nel settore privato e scolastico. A scuola gestisce da anni colloqui individuali con genitori e studenti, organizza e conduce gruppi sulla genitorialità e percorsi motivazionali allo studio.
E’ esperta di Cinema e Psicologia. Ha presentato spesso film con tematiche psicologiche ed esistenziali. Scrive per PsicoLab, Ilcinemante, Psychiatry on line, oltre che per le riviste didattiche Insegnare e Nuova Secondaria.