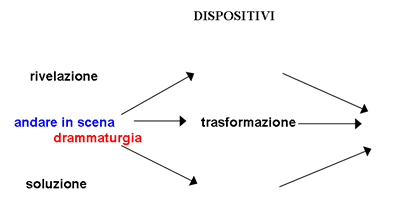Da parecchi anni, come psicologo, cerco di trovare convergenze significative ed operative tra “fare psicoterapia” e “fare teatro”, tra l’essere con e per le persone che soffrono di disturbi psichici e, contemporaneamente, l’essere in un laboratorio teatrale per improvvisare ed interpretare personaggi di ogni genere.
Tra i progetti scaturiti da questa continua ricerca del confine fra psicologia e teatro nasce la professione del teatroterapeuta. Da sette anni questo progetto si chiama con un solo nome senza più congiunzione e separazione tra le due discipline e, dal 1996, mi considero non più psicoterapeuta e nemmeno teatrante, ma teatroterapeuta.
Il teatro e la psicologia relazionale e del profondo, con tutte le loro potenzialità educative e trasformative, sono strumenti da me utilizzati come mediatori delle relazioni con i pazienti-attori e gli attori-pazienti.
Alla base dell’intervento c’è sempre la relazione a mediazione “teatrale”, ovvero il linguaggio delle arti sceniche, che si avvicina alla totalità dei linguaggi conosciuti: improvvisazione corporea, espressione grafica, sonora e pittorica, scrittura drammaturgica e recitazione. Questo linguaggio artistico è particolarmente adatto a produrre cambiamenti in sinergia con altri interventi psicoterapeutici e, nei casi più gravi, farmacologici.
Sempre più, in questi anni, si vedono pazienti psichiatrici, carcerati, ex tossicodipendenti, persone diversamente abili, calcare i palcoscenici di teatri stabili o instabili, di provincia o di grandi centri urbani, a volte persino al fianco di prestigiosi attori, per apprendere le tecniche e cercare di trovare un ruolo nel mondo del teatro. Può far sorridere, ma sono certo che questa realtà, che in Italia e all’estero va sotto il nome di teatro delle diversità, si stia conquistando sempre più spazio e sia degna d’attenzione.
A metà degli anni ’70 sono andato al Festival del Teatro di S. Arcangelo di Romagna per conoscere Jerzy Grotowski. Avevo appena letto “Per un teatro povero” e avevo, qualche tempo prima, partecipato ad un laboratorio condotto da Rena Mirecka, attrice formatasi alla scuola di Grotowski, e per me, appena venticinquenne, che rifiutavo l’idea della carriera in qualsiasi possibile campo, Grotowski già rappresentava un mito; vederlo in carne ed ossa, dietro quei suoi occhiali spessi, fu una conferma che rimane viva ancora oggi.
Giovane apprendista in identità, quale ero, e futuro psicologo, ero attratto dall’idea del teatro come percorso che trasforma il singolo e incide sul sociale era entusiasmante. Da allora Grotowski è sempre stato, insieme a Freud, un riferimento nel vasto campo dello studio dell’uomo, dal punto di vista della rappresentazione psico-fisica e della riflessione analitica.
In seguito ho letto Konstantin Stanislavskij e sperimentato il “metodo”, ho divorato l’opera omnia di Jung, non trovando alcun metodo, ma un continuo lavoro processuale, proprio come in Grotowski. Anni dopo ho frequentato, alla Statale di Milano, le lezioni di Carlo Sini su Platone, e così ho scoperto le radici del linguaggio simbolico e filosofico.
Questi incontri sono stati una fonte ricca di ispirazione metodologica per il mio lavoro di teatroterapeuta, che poneva, e pone tuttora, l’accento sul linguaggio globale di ciò che definiamo teatro, nel senso di creativa presenza del Sé individuale e collettivo.
Ciò che viene espresso con le parole-azioni nella performance sarebbe muto, se non fosse accompagnato dal principio fondante della psicoterapia a mediazione teatrale: il personaggio è il linguaggio fondante e creativo del cuore, metafora poetica del corpo in scena, espressione inconscia del divenire, principio che fa leva sulla parte sana e creativa di ognuno di noi. Anche il più sofferente degli schizofrenici possiede la capacità di ritagliarsi una “nicchia”, uno spazio sia pure limitato, di attività in cui le azioni più piccole, spesso ripetitive, non incontrano l’ossessione del giudizio altrui, non mettono a rischio l’autostima; nella persona “normodotata”, invece, anche se lo spazio di attività si espande diversamente, la percezione della propria particolare fragilità permane.
Per il nostro lavoro di artisti e terapeuti è indispensabile dotarsi di umiltà, a partire dalla relazione transitiva e transferale tra psicoterapeuta e paziente, simile a quella tra regista e attore.
LA TERAPIA
Esaminiamo nel dettaglio le ragioni della neonata disciplina che chiamiamo teatroterapia.
Nel teatro si attua l’immaginazione attiva in azione, il récit o resoconto ideale e materiale dell’essenziale: movimento che dal cuore coinvolge lo spirito, va verso le origini delle cose comuni a tutti gli esseri umani, in quanto portatori evolutivi della vita sulla terra.
In questo senso la pedagogia teatrale cui facciamo riferimento, quella d’origine grotowskiana, che ha avuto la sua evoluzione nell’antropologia teatrale barbiana e, ancora prima, in quella dell’’ultimo Stanislawskij, sviluppa l’immaginazione performativa come presenza attiva profonda dell’essere in scena. Si tratta di una pedagogia che rompe ogni schema precedente dell’attore istrione, grande esibitore di virtuosismi tecnici per ridare all’attore la sana umiltà, virtù grazie alla quale le invenzioni che crediamo nostre si presentano in modo evidente non come creature fabbricate da noi, ma come creature autonome oltre che autentiche.
Il teatroterapeuta che cerchiamo di formare nei nostri corsi rappresenta il canale umile e attento a ciò, per riuscire ad instaurare il clima giusto perché avvenga il teatro di gruppo.
Il cuore delle persone è pieno di personaggi, si tratta di esternarli e far dialogare i cuori tra loro in un contesto rituale che richiami l’inconscio collettivo.
Se la mente inizia a sentire e il cuore a pensare, si “scatena” nella persona ciò che definiamo terapia, cioè il desiderio di individuarsi mediante la conoscenza di Sé.
Il travestimento mediante il teatro conduce l’attore a questo stato extraquotidiano.
Come avviene ciò? Quando entriamo nello spazio teatrale varchiamo una soglia, la soglia del tempio, lasciamo le scarpe fuori, muoviamo il nostro corpo in dimensioni altre dai movimenti stereotipati del quotidiano modo di vivere.
Azionando il corpo, la mente inizia a “sentire” e le immagini che produce vanno verso il cuore.
Interpreto il personaggio numero uno: il corpo è coinvolto in azioni fisiche pre-espressive, derivate da tradizioni e discipline antiche che giungono a noi con l’eco di un’antropologia dell’attore.
Sono accolto nel gruppo teatro che è anche un gruppo di psicoterapia a mediazione corporea, quindi un gruppo chiuso, alla ricerca di un’identità e una fisionomia propria.
Per sentirmi parte del tutto devo affidarmi, mettermi nelle mani di un altro, degli altri e cancellare provvisoriamente i confini dell’Io. Essere attivo e passivo nella stessa unità di tempo e di spazio.
Interpreto il personaggio numero due: partendo dalla disciplina mi concedo libertà espressiva. Possiamo chiamare questo soggetto spontaneità vivente che cerca di definire un personaggio.
Interpreto il personaggio numero tre: la mente ritorna a pensare, ma ora il cuore è nella mente.
1 – IL CORPO IN AZIONE PRE-ESPRESSIVA.
Questo corpo viene dall’infanzia, dall’adolescenza, ma anche da più lontano. I suoi simboli sono l’albero, la pietra, la terra e l’acqua.
Quando vengo massaggiato, il mio corpo è come acqua, liquido amniotico dove nasce la vita primordiale.
Quando sono io che massaggio è come se plasmassi il corpo, assumo la medicina dello sciamano per cui le mani vanno dove l’organismo dell’altro ha bisogno di essere toccato.
La percezione attenta e profonda totalizza l’Unità con la natura, rappresentata dal corpo in azione non espressiva all’interno di uno spazio scenico: sala teatrale, bosco, greto del fiume che sia. Il training dell’attore concepito come mediazione in movimento scioglie dolcemente ogni resistenza, liberando l’Io dai confini preconcetti, per consentirgli una dimensione di cambiamento.
Tecnico, repressivo, libero, sensoriale o trascendente che sia (vedi: Orioli, “Teatro come terapia” 2001, pag. 77), il corpo in azione pre-espressiva è un vero e proprio processo di affrancazione dai condizionamenti, dalle resistenze, dalle reticenze e da qualsiasi cosa blocchi il processo creativo. Le azioni, che impegnano l’intero corpo-mente in un salto d’energia, non favoriscono le polarità immedesimazione-estraniamento, vero-falso, ma, bensì, la qualità primordiale di un corpo dilatato nel tempo e nello spazio.
2 – IL PERSONAGGIO ESPRESSIVO.
Interpretare un personaggio equivale a calarsi nei panni di una metafora vivente.
Dare vita a Prospero è come dare vita a se stessi, nel tradimento del fratello, dell’amico, di qualcuno in cui riponi invano la tua fiducia.
Travestirsi da leone o dar vita a una gazzella è come rappresentare il carnefice o la vittima, la forza o la fragilità per poi elaborare, nel gruppo teatro, forza, agilità, debolezza e vulnerabilità.
Questo personaggio che nasce dall’improvvisazione è un altrove, un altro da sé, è mondo che parla, che pone domande e annienta l’estraneità degli oggetti inconsci.
Esiste un forte legame tra attore e personaggio. Il soggetto-attore e l’oggetto-personaggio strada facendo cambiano il loro posto e finiscono per coincidere nel luogo vero del teatro.
Si attua così lo svelamento dell’inganno attraverso l’immediatezza dell’esperienza espressiva che, imperfetta e frammentaria in prima battuta, entra successivamente a far parte di un sogno di interezza con l’altrove.
Da questo punto di vista il teatro è un mezzo e non un fine. Quel particolare e utile mezzo per farsi abitare da forze misteriose, per imparare ad accettare ogni contraddizione dell’Io e per salvare la propria anima, ovvero per scoprire che “Noi non siamo al mondo / la vera vita è assente”, come scrivono Arthur Rimbaud, Carmelo Bene e Georges Gurdjieff.
La nascita del personaggio opera una trasmutazione alchemica dall’impossibile al possibile, dall’assenza alla speranza di una presenza.
Il personaggio in sé non esiste, pur non essendo è del tutto un
effetto astante la persona dell’attore; sappiamo che dà voce e corpo a qualcosa che è privo di voce, o, comunque, di qualcosa che è stato esiliato dalla coscienza e che, ora, si riprende la vita, nei tempi e nei luoghi del teatro, metafore del tempo e luoghi comuni.
Il personaggio ha la consistenza della materia dei sogni che s’invera nella carne dell’attore ed è, pertanto, un istante autentico, un effetto di verità. In questo senso l’esperienza dell’interpretazione attraverso l’improvvisazione porta alla coscienza la parte rimossa o dimenticata.
Questo processo può arrestarsi alla pura registrazione della perdita o procedere oltre verso lo sviluppo del personaggio stesso, in un altro e poi un altro ancora, fino a costituire una costellazione di personaggi. Si possono tracciare così i contorni di una personalità a più dimensioni quale noi siamo.
3 – IL CUORE È NELLA MENTE.
Il processo di messa in scena giunge al suo apice nella regia, funzione in cui si produce la transizione allo spettacolo teatrale, cioè ad un lavoro che può essere visto da un pubblico chiamato a testimoniare il processo attivo della creazione artistica.
La mente degli attori-pazienti “analizza”, s’interroga sul personaggio “uno” (corporeo) e sul personaggio “due” (espressivo), ricercando le emozioni del cuore e le sue reticenze, le motivazioni della coscienza e i desideri istintuali. Si cercano così le relazioni tra personaggi descritte dal testo e/o emerse nelle improvvisazioni, nonché le affinità elettive tra le persone-personaggi.
Di seguito, dall’informe irripetibile si procede verso una forma riproponibile, dove totalità e qualità dell’atto garantiscono, nei processi drammaturgici, la buona riuscita dell’effetto personaggio.
Non siamo entrati semplicemente nella nuova fase del processo artistico, siamo entrati in un nuovo ordine post-espressivo dove il sé animale diventa folklore simbolico, o, per meglio dire, storia raccontata della propria ed altrui evoluzione.
Darwin sostiene che, quando la tradizione è ridotta a passato, la scena è pronta per la progressione, che porta l’uomo sempre più lontano dall’animale.
Qualcosa di simile succede anche nel terzo personaggio, dove il cuore pensa e riduce l’animale a una macchina attoriale. Distaccato da sentimenti ed emozioni nonché dall’attivazione dell’istinto, l’attore può osservare con maggiore obiettività la sua creazione, condividerla nello spazio del gruppo e poi donarla allo spettatore.
GIOCHIAMO A FAR PER FINTA.
Concepiamo la teatroterapia come un sistema dinamico e complesso di relazioni intrapsichiche ed extrapsichiche, difficilmente semplificabili in una sola teoria scientifica, per cui ci dobbiamo avvalere dei nuovi concetti epistemologici di complessità.
Le scienze dell’uomo (psicologia, pedagogia, antropologia…) dovrebbero avere un nuovo tipo di filosofia che si occupi di qualità della vita, di valori, di esperienze condivise, piuttosto che di misurazioni calcolabili. E’ evidente che i dati di tale scienza sarebbero strutture di esperienze che non possono essere quantificate o analizzate, e tanto meno previste.
Per quanto riguarda la teatroterapia dobbiamo scoprire un modello concettuale capace di connettere fra loro i dati dell’esperienza in modo logico e coerente, tenendo sempre presente, nel far teatro, qualità e valori dell’esperienza umana.
Non vi può essere un osservatore obiettivo in questa esperienza, ma una percezione integrata tra soggetto che osserva e oggetto osservato (che è anche soggetto osservante), mentre il primo (oggetto osservante) è a sua volta osservato. Vogliamo dire che, mentre quando facciamo teatro ci sembra di essere protagonisti, quando guardiamo la scena da spettatori è a sua volta quest’ultima che diventa protagonista; non c’è primato dell’osservatore sull’osservato e, quindi, difficilmente, potrà sussistere un’unica visione dell’evento.
Nonostante ciò, l’esperienza e l’osservazione sistematica dei processi attoriali in teatroterapia, ci hanno indotto a tracciare un sistema coerente di riferimento teorico il cui punto di partenza si trova nelle teorie del gioco per focalizzarsi, poi, nel meccanismo dell’ingranamento tra attore e personaggio, fino a tracciare i lineamenti della struttura portante della teatroterapia.
La cornice generale in cui inserire la teatroterapia è, quindi, la teoria della complessità, con la sua visione olistica dell’essere umano e della natura che contiene non soltanto una visione complessiva del mondo e dei suoi fenomeni, ma assume anche un paradigma di ricerca preciso, le cui caratteristiche fondamentali sono riassumibili, schematicamente, nei punti che seguono:
- Si configura come un sistema aperto, ovvero un’entità organica, globale e organizzata con numerose parti differenziate, con funzioni e comportamenti autonomi (persone, gruppo, connessioni, azioni drammaturgiche ecc.)
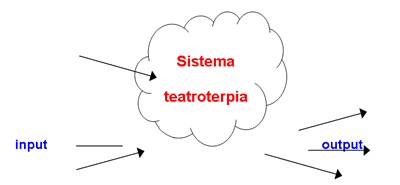
- Il setting, il gruppo, il terapeuta-regista rappresentano una rete di processi costitutivi di un progetto, nel quale nulla viene rifiutato a priori, i contrasti e le divergenze sono accettate ed esperite in funzione della possibilità evolutive del sistema.Rete di processo.
- La psicoterapia, come il teatro di ricerca, agisce nell’area del comportamento complesso, responsabile della creatività psicofisica, mentale e spirituale, riunendo la flessibilità propria del caos spontaneo alla stabilità dell’azione ordinata.
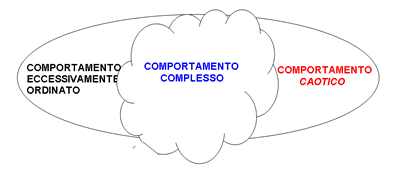
- Accettiamo come dato di fatto che persone, patologie, fattori culturali e antropologici, comportamenti creativi, distruttivi e performativi si autorganizzIno quando il sistema supera una soglia di complessità data dalle relazioni fra gli elementi. L’autorganizzazione si manifesta nella drammaturgia o transizione al teatro.
- Il gruppo di teatro, come ogni “gruppo”, è un organismo dinamico formato da sistemi di alleanze con forze centrifughe e centripete, di conservazione e di distruzione. La persona, che di per sé è un sistema complesso, si colloca nel gruppo come organo preciso del sistema.
- La struttura della teatroterapia è costituita da tre processi fondanti:Pre-espressivo – situazioni e tecniche che conducono l’attore-paziente alla presa di coscienza del proprio corpo-voce-mente, alla sua presenza qualitativa nello spazio scenico. Componente fondamentale della psicotecnica dell’attore (ascolto, emissione vocale, ritmo dell’azione, improvvisazione ecc.) è il pre-espressivo di tipo tecnico, libero, regressivo, sensoriale e trascendente.
Espressivo – situazioni e tecniche finalizzate alla costruzione di un personaggio che metterà l’attore-paziente in contatto con la propria creatività interpretativa, cioè la seconda parte della psicotecnica dell’attore, ovvero improvvisazione e interpretazione.
Post-espressivo – il montaggio scenico attraverso la drammaturgia dell’attore, del regista e del gruppo, l’analisi dei vissuti e delle dinamiche individuali e di gruppo (in sintesi, la razionalizzazione dei processi avvenuti in precedenza), la definizione dell’effetto personaggio attraverso la sua genesi, la costruzione dello spettacolo o transizione al teatro comparato al lavoro psico-analitico su se stessi.
LA STRUTTURA DELLA TEATROTERAPIA.
PROCESSO PRIMARIO PRE-ESPRESSIVO.
Né forma, né interpretazione: “Desidero sciogliere le mie paure e resistenze”.PROCESSO SECONDARIO ESPRESSIVO.
Interpretazione proiettiva: “Desidero interpretare un personaggio”.PROCESSO TERZIARIO POST-ESPRESSIVO.
Integrazione di azioni e testi nell’allestimento scenico: “Desidero estraniarmi da me e dal personaggio”.
IL PROCESSO PRE-ESPRESSIVO
Livello TECNICOLivello REGRESSIVOLivello LIBERO
Livello SENSORIALE
Livello TRASCENDENTE
- Le dinamiche principali della teatroterapia sono relative al gioco e all’ingranamento tra attore e personaggio.
GIOCO E TEATRO.
Fare in modo che i bambini siano messi in condizione di giocare è di per sé una psicoterapia, proprio come il gioco è di per sé una terapia per l’adulto.
Infatti, quando un bambino gioca ed è assorbito dal gioco, sta a significare che sta bene. È in sintonia con sé e con gli altri, con il dentro e il fuori (yin e yang). L’equilibrio che il bambino raggiunge giocando è fantastico. Egli si pone nell’area della cultura, mette da parte l’egocentrismo e non gli importa granché dell’ambiente circostante, sta vivendo in un’area intermedia che per l’adulto è l’area dell’arte, della filosofia. È lo spazio dove sperimentare la crescita, uno spazio suo e anche condivisibile, il luogo dell’indipendenza, dello star da soli alla presenza di qualcuno.
Il principio che caratterizza il gioco è la precarietà tra la realtà psichica e il controllo sugli oggetti reali, infatti, nel gioco spontaneo non finalizzato, il momento significativo è quello in cui il bambino sorprende se stesso, improvvisa una sequenza di azioni che hanno uno spazio e un tempo. Lo spazio non è completamente fuori da sé e neppure totalmente dentro, in sostanza, rispetto al bambino, lo spazio non è separabile da sé.
Il gioco della teatralità è un gioco simbolico dove l’attore interpreta un personaggio, rappresenta un altro, vuole essere in contatto, come diceva Stanislavskij e ciò è possibile solo in uno spazio intermedio tra area interna e area esterna, in cui si sviluppano i fenomeni transizionali dell’arte.
AREE PSICOLOGICHE
DELLA VITA PSICHICA E RELAZIONALE.

PERSONALITÀ INDIVIDUALE.
La personalità individuale organizzata è molto complessa, in quanto contempla le tre aree e fa riferimento all’idea d’identità multipla e dinamica.
Donald Winnicott (1896-1971), sviluppa, nella teoria del gioco, il concetto di spazio transizionale, in cui colloca lo sviluppo del rapporto madre bambino in quattro fasi:
- Il lattante e l’oggetto sono fusi. Il modo in cui il bambino vede l’oggetto è soggettivo. La madre è disponibile a rendere reale ciò che egli è pronto a scoprire.
- La disillusione. L’oggetto-madre è ripudiato, riaccettato e percepito obiettivamente. La fiducia nella madre produce l’area di gioco intermedia dove si origina l’idea del magico smarrimento.
- L’accettazione di sé come entità autonoma. Il bambino raggiunge la capacità di giocare da solo alla presenza della madre; sa che la persona che egli ama è disponibile e continua ad esserlo, quando è ricordata dopo essere stata dimenticata. La figura materna è percepita come se rispecchiasse ciò che avviene nel gioco.
- Il bambino si prepara ad ammettere il sovrapporsi di due aree di gioco distinte: la sua e quella della madre. Presto o tardi essa introduce il suo gioco. La strada è aperta per giocare insieme in un rapporto.
Se concepiamo il processo attoriale come un’attività ludica abbiamo quattro fasi:
- nell’area pre-espressiva attore e personaggio sono fusi. L’attore si prepara ad improvvisare attraverso un processo regressivo-catartico che lo mette in contatto con le fasi primarie di sviluppo.
- Fase della disillusione: il personaggio non appartiene all’attore. Esso è ripudiato, riaccettato e percepito obiettivamente nel suo movimento. La fiducia nel gruppo e nel conduttore produce l’area di gioco intermedia dove si origina l’idea del teatro.
- L’attore non desidera essere posseduto dal personaggio, egli raggiunge la capacità di star da solo estraniandosi dall’oggetto creato. L’oggetto è altro da sé ma è anche una parte di sé.
- Non resta che ammettere il sovrapporsi di due aree distinte: quella dell’uomo-attore e quella del personaggio. Il processo artistico diventa giocare insieme al personaggio, in un rapporto strutturato con principi e regole proprie.
Vi è una linea diretta di evoluzione che va dal fenomeno transizionale al gioco e dal gioco condiviso all’esperienza culturale.
Lo spettacolo è l’ultima tappa del processo dove il gioco condiviso degli attori e del regista diviene esperienza, che può essere vista dall’osservatore esterno. Dall’esperienza informe si passa a un’esperienza con una forma precisa e ripetibile. Da impulsi creativi, motori e sensoriali, indifferenziati e non indirizzati a uno scopo (area del gioco), si procede verso lo studio della comunicazione scenica e la codificazione nello spettacolo.

Questo procedimento non è rigido, ma dinamico, e, in tal senso, esperisce una possibilità di lavoro evolutivo intorno al teatro inteso come momento creativo e formativo.
Come il bambino introietta la madre attraverso la suzione al seno, così l’attore s’immedesima nel personaggio attraverso la fusione; nello stesso modo in cui il bambino esperisce la forzosa separazione dalla madre con la disillusione della sua costante presenza, l’attore nega l’identificarsi con il personaggio; infine, come il bambino elabora il lutto trasferendo le pulsioni affettive su un oggetto transizionale (ad es. il pollice da succhiare), così nel processo teatrale l’attore conquista la consapevolezza dello sdoppiamento, assume in sé l’oggetto artistico dal quale prende poi distanza. A questo punto il personaggio può diventare anche oggetto d’analisi.
L’INGRANAMENTO ATTORE-PERSONAGGIO.
L’attore è tutt’uno con il suo personaggio e il personaggio è tutt’uno con colui che lo esprime: l’attore attua, da un punto di vista psichico, un meccanismo di sdoppiamento che ha tutte le caratteristiche dell’ingranamento, concetto di natura psicoanalitica spiegato da Racamier (“Interazioni”, numero zero, Franco Angeli, 1992, pag. 61), applicabile alla vita psichica individuale e collettiva. Molti aspetti dell’ingranamento, osservabili nel contesto originario della macchina, si ritrovano anche sul versante psichico:
- la provenienza meccanica sottolinea il carattere sia dinamico che ripetitivo dell’ingranamento, così come noi lo concepiamo;
- l’idea di un “collegamento” completo rimanda a un grado elevato di organizzazione;
- l’esistenza di almeno due elementi in gioco (le due ruote dentate) ne definisce la dimensione intrinsecamente interattiva;
- il fatto che gli elementi stessi vadano a formare, in stato di movimento, un insieme unico (l’ingranaggio), fa pensare alla potenza unificante di tale “accoppiamento”.
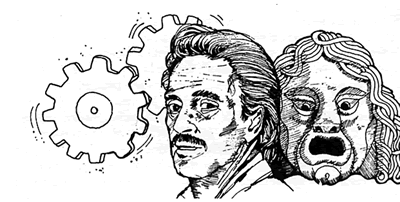
Ora proviamo a leggere il fatto teatrale con questa griglia interpretativa.
Immaginiamo il processo della recitazione come un procedimento identificatorio, formato da almeno due ingranaggi: il primo è l’ingranaggio costitutivo dell’uomo attore, il secondo è l’ingranaggio del personaggio che recita.
Nell’attore si instaurano due persone psichiche distinte per le quali ogni cosa provata, desiderata, voluta dall’una trova immediata risonanza nell’altra. E’ vero che l’attore influenza il carattere del personaggio che deve interpretare, ma anche il personaggio influenza lo stato d’animo del suo attore.
Da questa modalità di relazione dipende la veridicità del lavoro dell’attore e quindi la bravura artistica dello stesso. Un bravo attore è colui che possiede una forma di funzionamento psichico che permette agli ingranaggi di essere in perfetta sintonia.
Quanto più l’attore dipende dal suo personaggio e agisce nella stessa direzione, tanto più risulta difficile per lo spettatore capire quale dei due ingranaggi possegga la forza motrice.
Chi dei due subirà l’azione diventerà a sua volta promotore dell’azione.
Nella reversibilità del meccanismo dell’ingranamento risiede il vero segreto del teatro, di tutte le sue funzioni: pedagogiche, terapeutiche e formative.
L’individuo, in fase di rappresentazione, vive il paradosso di essere se stesso in un altro. Non è più solo se stesso e non è neppure solo personaggio. Se il protagonista della scena è solo se stesso, il pubblico vedrà l’uomo e non l’attore che recita i suoi stati d’animo e la finzione scenica fallirà, in quanto non c’è teatro, ma quotidianità.
Se il protagonista della scena è posseduto dal personaggio stesso perde il controllo sull’io: si ha un rito di possessione.
Nel teatro-letteratura avviene il contrario: l’attore fedele al testo scritto dal drammaturgo ne interpreta i desideri dando poco spazio al proprio Sé. La vera protagonista è la parola, la letteratura recitata.
Si verifica una potenza unificante nell’accoppiamento tra attore e effetto personaggio quando tra i due ingranaggi opera un meccanismo interattivo privo di origine precisa, dove la forza motrice c’è ma non è localizzata in uno solo dei due meccanismi.
Sulla scena l’attore non è mai solo, egli è doppio, o meglio, è strutturalmente ingranato con il suo personaggio; si mette, così, in moto un processo che ha caratteristiche precise:
- è un meccanismo dinamico ed anche ripetitivo;
- ha un grado elevato di organizzazione tra ruota motrice (attore) e ruota trascinata (personaggio);
- possiede una forte dimensione interattiva, preconscia e inconscia;
- comprende lo stato unico di movimento nell’azione scenica.
Se il personaggio fosse solo un fantasma o un idea, esso non potrebbe essere ingranato. Solo il fantasma-non fantasma è ingranabile – scrive Paul Racamier – “in quanto vissuto direttamente”. In questa dimensione interattiva non ha più senso chiedersi chi è il soggetto e chi è l’oggetto, in quanto si realizza un processo “senza origini”, fuori dallo schema causa-effetto.
Difficilmente possiamo determinare da dove nasce il personaggio, sappiamo che rimane in gestazione nel mondo sotterraneo dell’attore per lungo tempo, prima di emergere come effetto interpretativo. Sappiamo che l’io dell’attore ne è coinvolto, in quanto la tipologia del personaggio improvvisato prende anche una forma di funzionamento psichico, attuando un doppio intreccio tra dimensione intrapsichica e interattiva-relazionale.
La forte dipendenza reciproca, almeno nella struttura del lavoro pre-espressivo e soprattutto in quello espressivo di primo livello, è simile a quella del delirio, delirio controllato, in questo caso, dall’ingranamento che garantisce, con la sua meccanicità, una zona di consapevolezza.
Il personaggio, così, va ad occupare il posto o il luogo dei fantasmi intrapsichici ponendoli in una relazione sociale, quella del gruppo di teatroterapia prima e quella con il pubblico poi, favorendo la funzione transitoria dell’identificazione ingranante, per poi liberarsi definitivamente dall’ingranamento.
Nello spettacolo l’attore non è più ingranato con il personaggio: ora ne è distaccato, pur giocando ancora nello spazio transizionale; il suo gioco è definito da una partitura vocale e corporea precisa, che mostra, contemporaneamente, la maturità artistica e l’autonomia psichica.
L’AMPIEZZA DELLA PERSONALITÀ
L’Io dell’uomo nella società occidentale e postmoderna non può più essere considerato come unitario: da Jung in poi vige il “politeismo dei demoni interiori”, una moltitudine di personaggi, di Sé particolari, di immagini interiori che, nel loro insieme, formano la cosiddetta personalità individuale.
Come può questo individuo postmoderno vivere la propria identità come un tutt’uno che lo esprime?
Occorre che egli dia la possibilità ai suoi personaggi interni di incarnarsi nel suo corpo e di agire attraverso un processo legato alla spontaneità, al gioco, all’improvvisazione.
L’atto spontaneo, la “vivencia”, permette di attraversare il repertorio di emozioni e di azioni in cui la pulsione è espressa nella situazione, permettendo così all’individuo di esperire un senso di pienezza interiore e di armonia con l’ambiente. Nella relazione si ha la percezione di se stessi. Questo sentire dipende anche e soprattutto dal modo in cui si è “trattati” dagli altri.
Pirandello in “Ciascuno a suo modo” fa dire ad un personaggio: “… e non vuoi capire che la tua coscienza significa appunto gli altri dentro di te?”.
Infatti sono proprio gli altri che rispecchiandosi in noi ridefiniscono continuamente la nostra identità. Nel mondo contemporaneo è sempre più richiesto dalle circostanze un “Io flessibile”, che possa adattarsi rapidamente a sempre nuove circostanze.
All’individuo postmoderno è richiesto un grado elevato di creatività e, nello stesso tempo, una difficile coerenza che non può essere cercata nell’insieme della personalità individuale: infatti l’impressione di costanza, nei tratti della personalità, è pura illusione. La coerenza si trova in ogni frammento di personalità riferita alla relazione con le persone e le situazioni della vita. Abbiamo la possibilità di essere centomila personaggi e, quindi, di dilatare le nostre esperienze in modo altamente creativo, espandendo l’insieme della personalità oltre i confini limitati di un unico personaggio.
Abbiamo la disponibilità attraverso la trance di uscire persino dal corpo ed espanderci nell’universo. Il rischio è quello del non ritorno, del sentirsi frazionati, schizofrenici. Ogni personaggio che decidiamo di recitare è bene, perciò, che abbia confini propri, una logica propria, una coerenza propria.
Se da una parte le circostanze sociali inducono a continui cambiamenti, in un processo di crescita individuale che non ha precedenti nella storia dell’uomo, dall’altra assistiamo alla diminuzione del senso del limite e del senso di responsabilità morale.
Nella coerenza del personaggio ha sede la responsabilità dell’individuo. In questo senso egli non deve cercare la logica nella comparazione dei suoi personaggi. Per esempio, il ruolo dell’amante non può essere congruente con il ruolo del coniuge, l’aspetto eterosessuale della persona non può essere congruente con la tendenza all’omosessualità, ecc.
Si può transitare da un’esperienza all’altra, convertirci ad altre idee politiche o religiose, appartenere a gruppi diversi, sostenere punti di vista contrastanti in luoghi e giorni differenti, ma è opportuno mantenere la coerenza intrinseca nel ruolo del singolo personaggio. Diversamente, non prendersi su di sé i personaggi interiori, limiterebbe terribilmente la pienezza della vita.
Premesso che si devono sciogliere i vincoli di una presunta coerenza nei tratti globali della personalità, è opportuno abbandonare anche le maschere sociali e recitare a viso scoperto il proprio ruolo, sapendo che esso rappresenta solo una parte della nostra identità.
La fedeltà assoluta al proprio senso di identità nuoce all’individuo in quanto procura situazioni di isolamento, imbarazzo, fino a giungere alla depersonalizzazione. D’altro canto l’identità è talmente importante nell’equilibrio psicofisico che non può essere negata. Essa ha sede nell’immagine corporea e rappresenta il filo di collegamento tra passato, presente e futuro. L’immagine di un sé fisico unifica le identità parziali rappresentate dai vari personaggi giocati nella vita quotidiana, dando ad essi un corpo solo. Pur essendo consapevole che il rischio è quello di essere una persona diversa in situazioni diverse e che ciò significa non essere una persona completa in nessuno di queste, l’identità personale, tuttavia, la si va a riferire ad una visione complessiva della vita: essa trascende l’individuo stesso. Tanto è vero che manifestare la vera e profonda natura interiore prescinde dall’identità personale. Anzi quest’ultima è un ostacolo alla manifestazione del Sé profondo. Sarebbe come dire, se voglio restare me stesso non potrò mai provarmi in un altro personaggio che potrebbe svelarmi una nuova parte di me.
Risulta altamente contraddittorio dire: “Voglio essere me stesso e vivere la mia vera natura”. Se desidero essere me stesso metto un’armatura sul mio essere che viene protetto, rassicurato, delimitato.
Se voglio manifestare la mia vera natura, quella che posso intuire ma non conosco ancora nella sua essenza, ho bisogno di “volare via”, di abbandonarmi alla spontaneità, al gioco delle pulsioni inconsce.
L’uomo è un animale contraddittorio e, anche se si sforza di darsi delle spiegazioni e attuare il processo della comprensione verso sé stesso, non riuscirà mai a diventare un uomo inattaccabile.
Lacan, che ha contribuito in modo decisivo alla riformulazione della psicanalisi, descrive l’identità umana come qualcosa dalla quale non sono eliminabili incertezza, estraneità e insicurezza, perché esse fanno l’uomo così com’è.
L’essere umano non ha in sé nessun punto di riferimento fisso. Buddha dice di non essere legato a nulla e di non considerare nulla come suo, ciò equivale ad ammettere, in termini psicologici, che le strutture della personalità sono pure invenzioni intellettuali.
Capire è bello, come è bello spiegare, ma sia il processo della comprensione quanto quello della spiegazione sono tanto pericolosi quanto più sembrano riuscire. Nonostante ciò, tenteremo qualche spiegazione partendo dall’osservazione che l’errore principale che facciamo, per quanto riguarda noi stessi, è quello di considerarci come uno, in realtà siamo decine e decine, forse centinaia di Io differenti.
La difficoltà è integrare i diversi “Io” in un’unica psiche, mettere in relazione diversi personaggi, ognuno con il suo inevitabile fascino, in un’unica commedia dove l’individuo rappresenta lo spazio della scena.
Nessun analista usa il termine “personaggio” per definire il processo di identificazione tra la persona adulta e una parte del proprio Sé. Credo che questo termine rappresenti una nuova possibilità di capire, da una parte l’illusorietà del concetto di identità individuale e, dall’altra, l’incarnazione della libertà della persona. Oggi sia alle donne che agli uomini è concesso di adottare ruoli non tradizionali che solo trent’anni fa erano impensabili. Se si tiene conto che la salute mentale di ogni uomo dipende dalla gestione del senso di identità, per sviluppare le potenzialità individuali e realizzare con pienezza la propria vita, allora si comprende quanto sia importante osservarsi nel recitare il più ampio spettro di personaggi.
TRE DISPOSITIVI DELL’ANDARE IN SCENA
L’interpretazione “delirante” dell’attore è un processo che si compone di tre dispositivi:
Rivelazione – la scoperta di un elemento nuovo, l’interpretazione del personaggio, che nasce da un periodo di gestazione pre-espressivo, relativamente lungo. L’effetto personaggio ha la forma di un “delirio”, circoscritto nello spazio del gioco teatrale e dall’analisi introspettiva del processo psicoterapeutico.
Trasformazione – la consapevolezza dell’azione scenica tramite la ripetizione e la continua precisazione, una dimensione interattiva tra arte e terapia, ovvero la consapevolezza dei propri meccanismi funzionali tramite l’espressione artistica.
Soluzione – la determinazione della forma drammaturgia tramite lo spettacolo che diviene la sintesi di tutti i processi, le connessioni, le dinamiche e quant’altro è avvenuto nel gruppo.