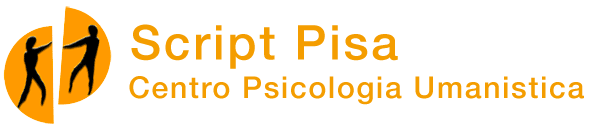“Non era il male a darle l’idea del piacere, a sembrarle piacevole; era il piacere a sembrarle maligno. E poiché, ogni volta che vi si abbandonava, s’accompagnava per lei a cattivi pensieri, il piacere finiva con l’apparire qualcosa di diabolico, identificandosi con il Male”.
Marcel Proust. “Alla ricerca del tempo perduto. Dalla parte di Swann”.
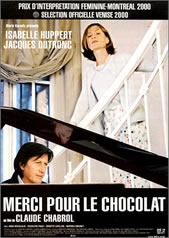 Titolo originale: Merci pour le chocolat.
Titolo originale: Merci pour le chocolat.
Regia: Claude Chabrol.
Soggetto e sceneggiatura: Claude Chabrol e Caroline Eliacheff.
Dal romanzo “The Chocolate Cobweb” di Charlotte Armstrong.
Fotografia: Renato Berta.
Montaggio: Monique Fardoulis.
Scenografia: Yvan Niclass.
Musica: Matthieu Chabrol.
Costumi: Elisabeth Tavernier.
Suono: Jean-Pierre Duret.
Interpreti e personaggi (alcuni): Isabelle Huppert (Mika Muller-Polonski), Jacque Dutronc (André Polonski), Anna Mouglais (jean Pollet), Rodolphe Pauly (Guillaume Polonski).
Produzione: Marin Karmitz per MK2 Productions, France 2 Cinéma, TSR.
Distribuzione: Mikado.
Durata: 99’.
Origine: Francia 2000.
Trama (tentativo di):
 La vicenda è ambientata a Losanna, in epoca contemporanea. Mika Muller (Isabelle Huppert), presidente di una importante fabbrica di cioccolata, sposa André Polonski.
La vicenda è ambientata a Losanna, in epoca contemporanea. Mika Muller (Isabelle Huppert), presidente di una importante fabbrica di cioccolata, sposa André Polonski.
André era già stato sposato, in prime nozze, con Mika. Dopo il divorzio aveva sposato Lisbeth, da cui aveva avuto un figlio Guillaume, ora ventenne. Qualche anno prima della vicenda narrata nel film, Lisbeth moriva in un incidente stradale sul lungolago di Losanna, mentre, di notte, si recava in farmacia per comprare il sonnifero di cui il marito aveva bisogno giornalmente, per addormentarsi. L’autopsia aveva rilevato tracce di barbiturici e di alcool nel corpo della moglie di André, benchè la donna non ne avesse mai fatto uso.
Jeanne Pollet (Anna Mouglalis) viene a sapere dalla madre (vedova) di non essere la figlia di colui che ha sempre creduto suo padre, ma di essere nata da una inseminazione artificiale. Da un’amica della madre viene inoltre a sapere di essere stata momentaneamente scambiata, in clinica, al momento della nascita, con Guillaume, il figlio di André e della seconda moglie, Lisbeth.
Jeanne immagina che potrebbe essere la figlia di André. Andrè è un pianista affermato, in crisi di creatività, Jeanne è una studentessa di pianoforte che ammira l’arte di Andrè. Un giorno arriva, da sconosciuta e all’improvviso, in casa dei Polonski e si presenta come la bambina che era stata sostituita temporaneamente nella culla a Guillaume Polonski, figlio di Andrè.
Apparentemente viene accolta bene dalla famiglia, Mika è formalmente cortese, Andrè è incuriosito e propone a Jeanne di darle lezioni di piano, sostituendo l’attenzione paterna nei confronti di Guillaume con quella per Jeanne (Guillaume non ha mai voluto seguire il padre nella professione di musicista e, il pianoforte comprato appositamente per lui, troneggia in solitudine nella villa dei Polonski).
Jeanne ha una straordinaria somiglianza con Lisbeth, la moglie morta di Andrè e madre di Guillaume. Jeanne sta al gioco della somiglianza e, dopo aver visto alcune fotografie di Lisbeth, si pettina e si atteggia come lei.
Nel corso della sua permanenza nella villa dei Polonski, Jeanne si accorge che Mika, la attuale moglie di Andrè, prepara ogni sera una tazza di cioccolata calda per il marito e per il figlio e ha l’impressione che nelle tazze Mika versi qualcosa d’altro.
Una sera, in circostanze simili a quelle in cui è morta Lisbeth, Mika si accorge che il sonnifero è finito. Prega Jeanne di andare a comprarlo in farmacia. Guillaume si offre di accompagnarla. La macchina, al ritorno dalla farmacia, è coinvolta in un incidente stradale analogo a quello in cui è morta Lisbeth qualche anno prima.
Mika confessa di essere stata lei a mettere il sonnifero nelle tazze di cioccolata di Lisbeth, di Jeanne e di Guillaume.

La trama del film richiede di essere raccontata per esteso soltanto in funzione di un’eventuale analisi successiva, soprattutto se si tratta di un’analisi di natura psicologica.
La narrazione segue apparentemente le modalità del giallo, con Jeanne inconsapevole detective dilettante che scoprirà le trame assassine e perverse di Mika, rischiando di essere la sua nuova vittima. E questa apparenza risalta maggiormente se prestiamo attenzione al fatto che lo svelamento dell’enigma si ha molto presto, all’incirca a metà dello svolgimento della vicenda che, più che una ricostruzione “d’ordine”, come avviene di solito nella vicenda criminale-poliziesca, è una decostruzione dell’atmosfera ordinata della famiglia Mika-Andrè.
Nell’atmosfera ovattata e perbene di questa famiglia altoborghese svizzera si snoda una vicenda tragica che riveste i panni di una moderna Orestea, con parti invertite maschili-femminili: Jeanne nei panni di Elettra che cerca di ridare vita ad uno svagato Oreste (Guillaume), mettendolo in guardia dalla matrigna (Mika) che ha ucciso la madre (Lisbeth) e ora cerca di “assopire” tutti, con la cioccolata al Nepiol.
A differenza della tragedia di Eschilo, il film di Chabrol non termina con una catarsi di natura sociale-individuale che concili l’individuo e la natura con le leggi che la società si è data per vivere in armonia con gli uomini e con gli dei.
 Il film può essere letto nell’ottica di una perversione d’amore derivata da un vuoto profondo, da un mancanza affettiva di ordine familiare (Mika è una figlia adottiva che si ritiene priva per questo di identità), che viene “perversamente” compensata col tenere legate (addormentate col sonnifero) a sé le persone affettivamente più significative e nell’eliminare fisicamente (addormentandole un pò di più) le figure che vengono viste come minacciose dell’ordine solipsistico stabilito dalla fantasia di Mika. Il film si presenta come un’ulteriore tessera nella filmografia di Chabrol che tende a costruire una storia asistematica del male e delle sue banalità (come un percorso destrutturato dell’opera storica della perversione scritta da Sade).
Il film può essere letto nell’ottica di una perversione d’amore derivata da un vuoto profondo, da un mancanza affettiva di ordine familiare (Mika è una figlia adottiva che si ritiene priva per questo di identità), che viene “perversamente” compensata col tenere legate (addormentate col sonnifero) a sé le persone affettivamente più significative e nell’eliminare fisicamente (addormentandole un pò di più) le figure che vengono viste come minacciose dell’ordine solipsistico stabilito dalla fantasia di Mika. Il film si presenta come un’ulteriore tessera nella filmografia di Chabrol che tende a costruire una storia asistematica del male e delle sue banalità (come un percorso destrutturato dell’opera storica della perversione scritta da Sade).
Mika si presenta come vittima-carnefice, vive una amoralità del tutto incosciente (quasi che anche lei si “addormentasse”, nel momento in cui assopisce, in parte o del tutto, chi vive con lei o si mette sulla sua strada). Il suo comportamento ha tutte le caratteristiche della coazione, compresa la ripetizione disordinata, il controllo ossessivo che finisce per sfuggire alla padronanza del soggetto e la rivelazione ultima che lascia la protagonista come impietrita di fronte ad una verità che apre agli “altri” (alle vittime, in questo caso).
La fissità della coscienza di Mika è una dolorosa giustapposizione all’impossibilità di riappropriarsi della sua costellazione psichica scissa e lasciata agire come tale.
L’agito degli addormentamenti-avvelenamenti progressivi è la difesa dal sentire il dolore della perdita d’amore in età infantile, dell’abbandono, di un’adozione sentita come un sostitutivo vuoto di un amore reale di appartenenza, di “corpo” e di “elezione”.
Le figure della sostituzione sono del tutto insufficienti nel vissuto della protagonista, perché la coazione che impone il controllo deve tenere gli altri (tutti gli altri) addormentati, non vitali, implosi all’interno di un’atmosfera familiare borghese formale e sempre uguale a se stessa. Non è possibile, per la moglie di André, correre i rischi d’incertezza che l’amore, coniugale o figliale, comporta.
Al posto della vita vissuta si colloca allora la figura della ripetizione, che è quella che rassicura e freddamente consola, dà difesa e sicurezza (figurativamente le sequenze, una in flash-back e una in diretta, dei prodromi dei due incidenti, della moglie di Andrè, Lisbeth, e di Jeanne e Guillaume, presentano analogie chiaramente sottolineate). Per lo svolgimento narrativo che ne consegue, le tracce del secondo crimine portano significativamente al primo.
In tutto il progressivo svolgersi della vicenda quello che colpisce è la mancanza iconica di violenza. Mika non uccide, accende soltanto una miccia, poi lascia morire. E tutti coloro che le stanno accanto, anche se con diversi toni, non rivestono i panni dei personaggi che rendono giustizia e reintegrano un ordine di realtà familiare-sociale o di pietas, laica o religiosa che sia.
Non c’è punizione, non c’è la scena finale dei gialli di tradizione americana, alla Chandler, col detective che, anche se ha risolto l’enigma di un crimine, sa che dolorosamente tutto si ripeterà. Nel finale tutti i personaggi riprendono la loro fissità e la loro distanza dalla realtà. Emblematicamente Andrè, ascoltata la confessione di Mika, riprenderà a suonare il pianoforte, guardando nel vuoto; ancora una volta la musica è un pesante diaframma rivolto a separarlo dalla realtà, come se non valesse la pena conoscere, perché equivale ad avere la risposta della morte. Anche come indiretta vittima, ad Andrè conviene rimanere all’interno del disconoscimento delle pulsioni negative di Mika, attraverso la reimmersione nella società delle “buone maniere” e della formalità borghese.
In ultima analisi il film può essere letto come la storia di una pietrificante perversione nata da una percepita privazione d’amore che crea uno stato di violenza larvata e onnipotente, tesa alla riappropriazione, ad “ogni costo”, dell’amore perduto. La per-versità (il camminare in un verso che presenta disordinate deviazioni) è costituita, in ultima analisi, dalla ricerca e dal mantenimento coatto dell’oggetto d’amore, con un’energia che arriva a dare la morte a coloro che, sotto la veste di fantasmi, sono visti da Mika come minacce e intrusioni al suo mondo di affetti, spento e ipercontrollato, ma proprio per questo rassicurante.
In termini di immagini, l’ultima sequenza del film (che accompagna i titoli di coda e li segue, quasi a significare che la vicenda appartiene ad un mondo mai cominciato e non finito, di natura primordiale e precivile) è come riassuntiva dell’intera narrazione.
In un lento piano-sequenza (cioè una ripresa che avviene senza stacchi di macchina e quindi senza tagli successivi di montaggio), Mika è ripresa dall’alto, sta piangendo, è sola, stesa su un divano, André è nella stanza accanto, suona il piano, accanto alla donna c’è uno scialle di lana che ha cominciato a lavorare all’inizio del film, lo scialle è nero e verde, assomiglia ad una tela di ragno, lei si contrae in posizione fetale, forse è sorpresa dalla sua stessa commozione, la cinepresa si sposta su una gru che si muove verso l’alto e, lentamente, apre sempre di più il campo visivo, imitando un ragno che progressivamente amplia la rete della sua tela.
Mika ora vi è completamente avviluppata dentro. Ora la verità è acclarata e la vita potrà essere molto più difficile di prima.
Chabrol, a onor del vero, termina il film con una chiusura che non apre e non interpreta, ma tende a far ritornare tutto ciò che è avvenuto nella fissità che copre l’intero film, percorso non tanto da tensioni narrativo-costruttive, quanto da elementi formali che presentano lenti movimenti progressivi in uno spazio che, anche visivamente, ha l’atmosfera asfittica di una morta gora.
Per chi volesse approfondire l’analisi del film e le problematiche psicologiche che vi possono essere correlate, segnalo i seguenti riferimenti:
1) “Il sonno avvelenato di Chabrol” di STEFANIA CARPICECI in “Carte di cinema”, n. 7, inverno 2000.
Devo a questo articolo la citazione di Proust. La critica, nella prima parte, ha un taglio decisamente psicoanalitico ed ha numerosi richiami all’opera di ANNA SALVO “Perversioni al femminile”, Mondadori, 1997. L’articolo è introdotto da un’altra citazione riportata da BANANA YOSHIMOTO “Sonno Profondo”, Feltrinelli, 1995: “Il sonno viene con l’avanzata della marea. Opporsi è impossibile. È un sonno così profondo. Nessun dolore, nessuna tristezza laggiù: solo il mondo del sonno, dove precipito con un tonfo”.
2) “Il doppio peccato di Madame Polonski” di NICOLA ROSSELLO in “Cineforum” n. 401, gennaio-febbraio 2001.
3) “Grazie per la cioccolata” di ROBERTO CHIESI in “Segnocinema”, n. 106, novembre-dicembre 2000.
4) “Per chi non vuole sapere chi sia il colpevole” di MAURIZIO PORRO in “Corriere della Sera”, 22 novembre 2000.
5) “Claude Chabrol” di ANGELO MOSCARIELLO, Il Castoro Cinema, La Nuova Italia, 1976.
6) “Idoli di perversità” di BRAM DIJKSTRA, Garzanti, 1988. Il libro non ha nulla a che fare col film di Chabrol, ma è un prezioso archivio di immagini pittoriche che, al femminile, rappresentano l’idea della peversità nella pittura dell’Ottocento e del Novecento.
Segnalo inoltre questi siti Internet che possono essere utili per approfondire la conoscenza dell’argomento “amore perverso” o notizie su “Grazie per la cioccolata”:
a) “L’amore perverso. Eros melanconico e perversificazione”, di RICCARDO DALLE LUCHE in www.psychomedia.it.
b) “Cinema di Claude Chabrol. Grazie per la cioccolata”, di NICOLA D’UGO, in www.controluce.it.
Giovanni Lancellotti
Psicologo psicoterapeuta SCRIPT Centro Psicologia Umanistica