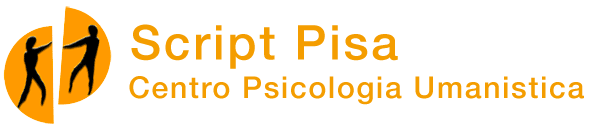Saveria è una ragazza di vent’anni, entrata in crisi dopo essersi fisicamente allontanata dalla famiglia d’origine per frequentare l’università.
Non sono pochi i giovani che malamente inciampano in quel particolare passaggio dell’esistenza. Sembra che, inaspettatamente, qualcosa si metta di traverso sulla soglia che conduce dalla famiglia d’origine al resto del mondo. In quei casi, pare evidente, l’adattamento al piccolo mondo di provenienza non fornisce gli strumenti per un facile proseguimento al di là del contesto di socializzazione primaria. Fuori le regole sono diverse. Si potrebbe argomentare che le famiglie patogenetiche sono quelle che si mantengono più o meno fuori dal mondo, cosa di cui i figli si accorgono a proprie spese, scoprendosi inadatti a procedere, programmati per vivere in un altro mondo, non in quello che, nel bene e nel male, li aspetta fuori dalle mura della casa paterna o materna che sia. Ma le famiglie patogenetiche non sono soltanto chiuse in se stesse ed escluse dal mondo: sono anche particolarmente rigide e sclerotizzate al loro interno, nelle regole, nelle credenze e nei ruoli che impartiscono ai propri membri, cosicché questi giovani non solo non si raccapezzano tanto facilmente, ma rimangono per giunta interdetti e bloccati di fronte alla necessità di un cambiamento, perché la flessibilità e il cambiamento sono qualcosa che non hanno mai visto, qualcosa di sconosciuto, per cui, in conclusione, non si orientano più e vanno in crisi.
S., nel suo disorientamento, sviluppò un complicato disturbo alimentare; ma neanche questa mi pare un’evenienza tanto sorprendente, soprattutto fra le ragazze di quell’età che si trovano alle prese con quel genere di difficoltà maturative. A qualcosa aveva bisogno di aggrapparsi e si aggrappò infatti al cibo, facile sostituto di quell’affetto primario con il quale non si sentiva più in contatto e dal quale non aveva fiducia di essere raggiunta e sostenuta oltre la soglia di casa, nella sua avventura verso l’ignoto.
S. era stata, in un certo senso, una bambina prodigio: pensando a lei, mi viene inevitabilmente da pensare al titolo del famoso libro di Alice Miller, Il dramma del bambino dotato, sulla cui copertina (almeno nella mia edizione Boringhieri del 1985) si vede una bambina modestamente vestita, ma tutta avvolta, si potrebbe dire, di una sua generosa esuberanza, colta nello slancio di saltare verso una meta alta e invisibile. S. era stata, come Mozart, una prodigiosa allieva del padre, esperto linguista, dal quale aveva imparato la linguistica comparata in età ancora infantile e poi, da adolescente, proseguendo da sola per la via in tal modo tracciata, divenne l’unico essere umano di nazionalità italiana in grado di parlare una rara lingua nord europea semiestinta, della quale scrisse addirittura l’unico dizionario con traduzione italiana.
Quando si presentò al primo colloquio, era già reduce da due precedenti esperienze fallimentari di psicoterapia. Dalla prima fuggì dopo pochissime battute: mi sembra di ricordare che si trattò dell’incontro con un analista chiuso nella sua ritualità ortodossa e ostentatamente neutrale, dal quale si sentì subito piuttosto agghiacciata. La seconda esperienza fu assai più inquietante. Si rivolse infatti ad una psicologa del Centro per i disturbi alimentari, la quale incentrò tutta la terapia sul sintomo del cibo, operando, secondo il mio modo di vedere, un sorprendente capovolgimento del senso delle cose: secondo lei, S. era angosciata e stava male perché mangiava poco e male e non viceversa. Il vero problema era il comportamento alimentare sbagliato nel quale la ragazza (cocciutamente) persisteva e tutta la sofferenza della sua vita non era altro che il sintomo e la conseguenza di ciò. Probabilmente, agli occhi della psicologa, si trattava di una forma di testardaggine ribelle che andava corretta in qualche modo e questo giustificava ogni sorta di prescrizioni coercitive e colpevolizzanti, fino a quella, insostenibile per S. anche con tutta la buona volontà, di non vedere e non sentire la madre per almeno un anno… quando si dice non andare troppo per il sottile! Perché certamente il disturbo alimentare rivelava un nucleo simbiotico nel rapporto con la madre, ma procedere con un assalto al legame di questa portata pare ai miei occhi come il tentativo di usare l’accetta per compiere un delicato intervento chirurgico.
Avevo inizialmente l’impressione poco rassicurante di lavorare con una persona che restava, in buona parte, assente: era disponibile al dialogo, ma esangue, mi ascoltava come in uno stato di trance e mi parlava di problemi assai seri senza comunicarmi emotivamente il senso di gravità al quale si sarebbero dovuti accompagnare. Il primo sogno che mi portò in analisi mi fece fare la diagnosi di una inequivocabile tendenza alla dissociazione:
È una notte di luna piena. Dense nubi avvolgono la luna, creando un effetto eclissi. Sento un grido lontano: uno stormo di gabbiani invadono il cielo notturno. Sono elettrizzata, sento che sta per succedermi qualcosa. Capisco che i gabbiani, nella loro lingua, mi invitano a seguirli in cielo. Salgo su di un tetto e di lì vedo le strade illuminate dai lampioni, gli alberi e le case, poi vedo un assembramento di persone che guardano verso di me e gesticolano: sono parenti, amici e persone curiose che non hanno capito e temono che io voglia buttarmi di sotto. I gabbiani continuano a chiamarmi, insistenti: un richiamo irresistibile, quasi ipnotico e il loro verso è bellissimo. Dicono il mio nome nella loro lingua. Sto cominciando a levitare e a salire, quando i miei genitori mi afferrano e mi tirano giù per i piedi. Mi sveglio all’improvviso e mi accorgo con spavento che non riesco a muovermi. Ho le membra tutte intirizzite, informicolite, pervase da un torpore fastidioso e mi sento come se fossi in un corpo non mio… poi ripiombo nel sonno. Dopo poco sento l’ultrasuono del gabbiano capostormo. Il grido si fa sempre più forte e intenso e, come ipnotizzata, so che la trasformazione è di nuovo vicina.
L’esistenza di S. era segnata dalla presenza invasiva di due fobie. La fobia dei temporali era cominciata molto presto, in età prescolare, ma aveva raggiunto il suo massimo nel periodo della pubertà, quando per un anno intero impedì a S. di frequentare la scuola statale; infatti, la preoccupazione costante rivolta al cielo per spiare la comparsa di ogni eventuale addensamento nuvoloso non le consentiva più di partecipare alle normali attività che si svolgevano in classe. La fobia del lombrico, invece, si presentò più tardi, aggiungendosi a quella dei temporali, ed ebbe il suo picco alle superiori, quando arrivò ad impedirle di aprire i libri di scienze, per paura di trovarlo rappresentato. La madre ebbe allora il compito di sfogliare preliminarmente i libri di testo per tagliare o tappare tutte le immagini proibite.
La spiegazione del meccanismo di formazione e del contenuto delle fobie è una pietra miliare della psicoanalisi freudiana e, da un certo punto di vista, una delle colonne che ne sostengono più validamente l’edificio. Infatti, questo genere di sintomo sembra fatto apposta per dimostrare che 1) esiste un inconscio, 2) esistono dei meccanismi di difesa (rappresentati in questo caso dallo spostamento e dalla proiezione) e 3) esistono dei contenuti ideativi perturbanti con i quali l’Io cosciente non vuole avere nulla a che fare. Quello che, secondo la mia esperienza, appare oggi meno sostenibile è la generalizzazione relativa al merito dei contenuti, che secondo Freud erano sempre di natura sessuale o aggressiva. Ma non mi sembra più di affermare qualcosa di tanto rivoluzionario, ribadendo la convinzione che sia terminato il sogno di una grande semplificazione scientista e fiscalista. In effetti, oggi il mondo interno degli esseri umani si presenta alla riflessione psicoanalitica sotto il profilo di una complessità irriducibile [1], nella quale si esprimono le peripezie di una soggettività variamente alterata, dispersa, proiettata, negata ecc., motivo per cui anche il contenuto delle fobie deve essere ricercato con una maggiore consapevolezza della fenomenologia dell’esperienza vissuta, che può essere più o meno autenticamente vissuta. Da questo punto di vista, mi giovo della mia iniziale formazione junghiana, la quale, al di là di tanti aspetti che mi paiono ampiamente criticabili con il senno di poi (irrazionalismo, scarso approfondimento della clinica, idealizzazione dell’inconscio e visione troppo ottimistica della malattia psicologica), mi ha comunque educato ad avere un approccio fenomenologico, particolarmente attento alla complessità dei vissuti soggettivi che grottescamente o paradossalmente si riflettono in ogni forma di concretizzazione nevrotica, a prescindere da ogni forma di metapsicologia. Un esempio tipico di quanto sto dicendo, sempre a proposito dell’interpretazione del contenuto di una fobia, si ritrova in un mio scritto, precedentemente pubblicato su questa stessa rivista (n. 8., febbraio 2004). Anche lì si trattava di decifrare il senso di una fobia molto particolare e circoscritta: un’intensa, irrefrenabile paura delle farfalle. Quasi a conclusione di un prolungato periodo di lavoro analitico, quando ormai tanti aspetti del mondo interno di questa persona erano stati chiariti e alcuni importanti cambiamenti psicologici erano stati raggiunti, un aiuto determinante venne da un sogno:
“Entro, in cerca di un libro, nella casa di una ragazza giovane, bella e mora. Mi fa entrare, ma non resta con me. M’invita a cercare il libro da sola, perché lei deve seguire un suo impulso di felicità. La casa è vicina al mare. Si vedono le onde impetuose e lei ha voglia di tuffarsi. Esce, vestita di un sari color smeraldo e io non provo nessuna apprensione per lei (il mare, anche mosso, non mi ha mai fatto paura). Smetto di cercare il libro e indosso un abito della ragazza, un altro abito orientaleggiante, una tunica color ocra. Improvvisamente lo scenario è cambiato e mi trovo con quell’abito nel mio paese natale, seduta su dei gradini a guardare la gente che passa. Passa mio padre, vestito elegante. Quando mi vede resta sorpreso, poi con un sorriso di scherno si avvicina e mi fa l’elemosina. Il senso d’umiliazione è tremendo.”
Nel sogno, la paziente andava a trovare un doppio di se stessa, che personificava lo slancio vitale, nella forma di un impulso spensierato verso la felicità. Come si capisce anche dai colori sgargianti degli abiti (verrebbe da dire delle ali), questa è la famosa farfalla, oggetto di fobia, e il sogno ci spiega perché essa fosse così temuta: la paziente aveva una grande paura, impersonando la se stessa farfalla, di essere giudicata con disprezzo dal padre. Aveva paura che cedere al lato solare e vitale di sé potesse significare l’irresponsabilità che ci fa andare incontro ad una brutta fine. Voglio aggiungere un chiarimento che renderà più significativa questa spiegazione. La madre della ragazza, una donna disturbata e instabile, aveva reso difficile la vita a tutti, in famiglia, compreso il marito, il quale aveva trovato la propria consolazione stabilendo un rapporto particolarmente stretto con la figlia, improntato all’ammirazione (idealizzazione) reciproca. Fino da bambina, la paziente aveva così assunto verso il padre un tacito impegno a non diventare mai come la madre, allo scopo di fornire al padre e se stessa quella che, in realtà, costituiva una forma indispensabile di rassicurazione narcisistica. Alla base della fobia c’era, in definitiva, lo spostamento sulla farfalla delle qualità psicologiche tipiche di alcune donne da lei nascostamente ammirate (leggerezza, slancio vitale e libera espressione del senso di sé) e la proiezione di quelle parti di sé, per non dire di quel alter-ego, di quella personalità in ombra che si riconosceva in tali qualità, cioè di quel lato del proprio Sé femminile al quale sentiva la tentazione e il bisogno di avvicinarsi, tentazione e bisogno considerati però come pericolosamente improponibili.
Tornando adesso a S. e alle sue fobie, devo dire che la prima delle due, cioè quella del temporale, è risultata presto comprensibile, ancora una volta con l’aiuto di sogni particolarmente espliciti. S. faceva da sempre il sogno ricorrente di un violento temporale che minacciava l’integrità della casa. Ma quando sognò che la furia dell’uragano divideva in due parti la casa con improvvisa esplosione, separando la madre da sé, non ci furono più dubbi. Il temporale rappresentava dunque da sempre l’evidenza che esiste qualcos’altro nel mondo, al di là della “rassicurante” dimensione simbiotica madre-figlia e che, prima o poi, quella cosa sarebbe venuta a stanarla con potenza inesorabile. Naturalmente rappresentava anche un’immaginazione condizionata dall’atteggiamento iperprotettivo della famiglia d’origine, intenzionata, a quanto mi è parso di capire, a prolungare a tempo indeterminato la simbiosi come unica o prevalente modalità di rapporto fra tutti i suoi membri. Come dire che il condizionamento psicologico (il messaggio implicito) registrato dalla mente di S. corrispondeva alla convinzione che l’unico ordine comprensibile del mondo fosse quello simbiotico. Tutto ciò che ad esso si contrapponeva si presentava come caos. Il mondo, fuori dalle mura domestiche, si presentava con la sua complessità e le sue attrattive come una dimensione coinvolgente, imprevedibile, magmatica, violenta e pericolosamente inarrestabile. Risulta fin troppo facile, a questo punto, comprendere le ragioni della crisi intervenuta in seguito al tentativo di allontanarsi fisicamente dalla famiglia d’origine per andare a studiare in un’altra città.
Come ho detto in precedenza, la seconda fobia, quella del lombrico, risultò per un certo periodo molto più enigmatica della prima. La madre, acculturata in psicoanalisi, suggeriva l’evidenza di una simbologia sessuale e, in un colloquio che ebbi con lei, mi prospettò svariate ipotesi di seduzione infantile a scapito della povera bambina, che aveva lungamente soppesato. Non ne trovai nessuna che fosse veramente convincente. Ebbi invece una vaga intuizione, ancora una volta aiutato da un sogno. Si trattò di un incubo, uno di quei sogni così sorprendentemente articolati che mostrano all’opera le intriganti capacità dissociative di S.:
Sono nella bottega di un antiquario e sto frugando fra libri molto antichi. Trovo una raccolta di diari che attraversano varie epoche, addirittura sembra che risalgano fino all’origine dell’umanità. Mi domando come possano essere stati scritti dalla stessa persona narrante. Improvvisamente capisco che l’autore è una persona che ha raggiunto la consapevolezza di tutte le sue incarnazioni precedenti e parla a partire da ciascuna di esse e poi scopro… che quella persona sono io! Buio totale. Adesso brancolo nel buio della mia prossima incarnazione. Comincio a mettere a fuoco qualcosa e mi accorgo che vedo il mondo dal basso. Davanti ai miei occhi c’è un selciato lucido di pioggia e vedo pericolosamente vicini ed enormi i piedi della gente che passa. Quando raggiungo un tombino e istintivamente (e voluttuosamente) mi lascio scivolare nella fogna mi rendo conto con indicibile orrore che sono diventata un lombrico!
A posteriori, mi rendo ben conto che questo sogno diceva già tutto o quasi tutto, ma sul momento lo raccolsi come un vero e proprio rebus, né le associazioni della ragazza valsero a dissipare le oscurità che presentava alla mia mente. Comunque, il sogno rimase da qualche parte nel mio cervello, come oggetto di ricorrenti rimuginazioni e quando, qualche mese più tardi, S. ritornò sull’argomento lombrico, provai a dirle un po’ a bruciapelo e con affettata nonchalanceche il lombrico di cui aveva tanta paura poteva anche essere un neonato. A quel punto, S. ebbe un trasalimento e un moto d’orrore che quasi mi fece preoccupare. La seduta successiva tornai sull’argomento e le feci notare che esiste un possibile nesso sul quale non avevamo mai riflettuto fra temporale e lombrico, perché, dopotutto, i lombrichi vengono fuori dalla terra soltanto dopo la pioggia. Questa osservazione la colpì moltissimo e le fece ricordare l’episodio in cui, per la prima volta nella sua vita, si era resa conto dell’esistenza dei lombrichi. All’epoca, S. aveva 10 anni ed aveva effettivamente piovuto da poco. Mentre camminava lungo un sentiero terroso per mano della nonna materna, questa le fece notare una creatura che strisciava nel fango: “vedi, quello è il lombrico!”, e così dicendo lo schiacciò per bene con la punta dell’ombrello. S. ricordava però di non avere avuto nessuna reazione angosciosa in quella circostanza. Soltanto a distanza di tempo il lombrico era diventato un’ossessione per lei, senza che mai avesse messo la cosa, almeno consapevolmente, in connessione con il ricordo di quel primo episodio, al quale, in definitiva, non aveva mai dato nessuna importanza. A questo punto, avevo in mano tutti gli elementi necessari per decifrare una buona volta il rebus.
In un certo senso, il sogno aveva rivelato la verità, dicendo che il lombrico era la nuova incarnazione che l’attendeva al termine di questa vita, o meglio aveva rivelato la verità che S. angosciosamente si aspettava, vedendo le cose dal punto di vista della simbiosi come unica forma di vita umana. Il lombrico rappresentava, infatti, la forma di vita totalmente diversa, indifesa, abietta e derelitta, nella quale si sarebbe trascinata dopo che il “temporale” avesse compiuto la sua opera devastatrice. Questa spiegazione che fu accolta con sorpresa ma senza particolari resistenze dalla ragazza, mi ricorda da vicino il motto medioevale che dice: extra ecclesiam, nulla salus. Motto che dovremmo adattare alle circostanze, volgendolo in questi termini: fuori dalla simbiosi non c’è salvezza!
Naturalmente, non ci si deve aspettare, secondo una visione poliziesca e romantica del lavoro psicoanalitico, che questa ricostruzione del significato delle due fobie possa avere avuto un valore terapeutico di per sé. Direi piuttosto il contrario: siccome attraverso l’analisi si era sviluppato un processo terapeutico che aveva già prodotto dei cambiamenti sostanziali nel mondo interno di S., allora la sua coscienza si è potuta avvicinare alle paure che l’avevano tenuta così lungamente in scacco, ridimensionandole, motivo per cui sono anche venuti i sogni e siamo stati capaci di decifrarne il significato.
Alberto Lorenzini
E-mail: alberto.lorenzini3@tin.it
[1] Secondo Kohut, gli “stati mentali complessi” sono gli elementi costitutivi primari del mondo interno, mentre le pulsioni sono elementi di carattere secondario, derivanti dalla frammentazione del Sé. Per esprimere questo concetto in un altro modo, si potrebbe dire che, normalmente, non esistono cose come la rabbia, la paura ecc, ma più precisamente, un Sé arrabbiato, un Sé spaventato ecc. Soltanto in situazioni traumatiche abbiamo a che fare con elementi psicologici che corrispondono alle pulsioni di Freud.